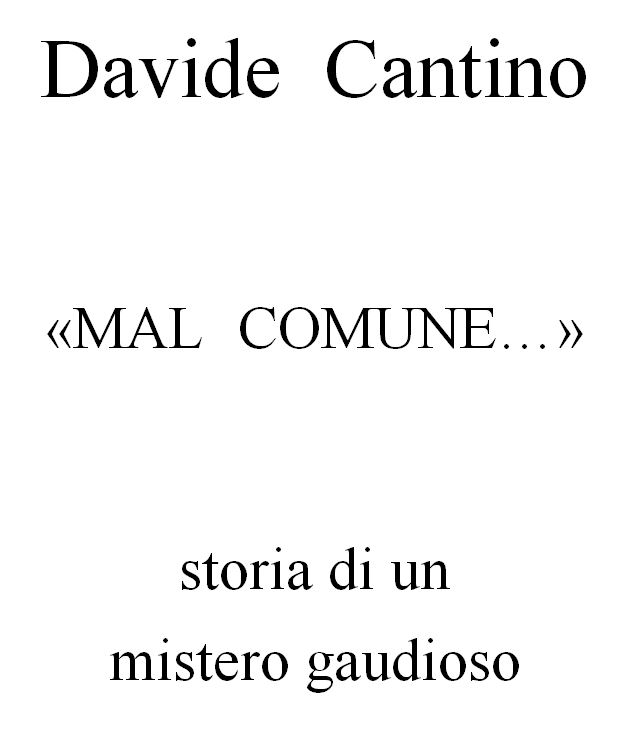
L’avevano portato in ospedale sperando che Lui, vedendo il mal comune, potesse finalmente provare il mezzo gaudio che il proverbio promette; ma si erano sbagliati. Non era un tipo da luoghi comuni e forse per questo su di Lui i proverbi non facevano effetto; e forse anche perché gli ospedali non sono affatto luoghi comuni. Il male è qualcosa di così comune che tutti lo ritengono naturale, ma Lui non l’aveva mai ritenuto qualcosa di naturale. «Non bisogna abituarsi a tutto, come se tutto fosse normale – diceva –, il male non è normale».
Lui era allergico alla vita perché la vita è male, o almeno così pensava. ‘Non se ne può più di questo tuo pessimismo’, dicevano Tutti quelli che lo conoscevano. Ma Lui non la pensava così. Lui credeva che Tutti fossero semplicemente assuefatti, assuefatti al male di vivere e non se ne accorgessero più, di questo male: è tutta una questione di assuefazione. Lui non si era assuefatto, tutto qui. Lui non si era abituato al male di vivere perché non voleva dare alla vita questa soddisfazione: la soddisfazione di (soc)chiudere gli occhi, come fanno Tutti. Sembrano sonnambuli: nascono, vedono il male, (soc)chiudono gli occhi per tutta la vita e li riaprono davanti alla morte, che glieli chiude, per sempre.
In ospedale Lui vide qualcuno aprire gli occhi davanti alla morte. Avrebbe voluto prenderlo per il collo e dirgli: ‘Perché apri gli occhi solo adesso, che la morte te li chiude?’, ma la pena che provava glielo impediva. Tutti pensavano proprio che Lui, in ospedale, avrebbe (soc)chiuso gli occhi; invece li tenne ben bene aperti, come sempre. Tutti deprecavano, questo suo lamentarsi continuamente della vita, e fu così che lo portarono in ospedale: «Va’, va’ a fare un po’ di volontariato, va’ ad aiutare chi sta peggio di te, che così magari riesci a renderti conto di quanto stai bene…».
Medici ed infermieri andavano e venivano su e giù. La cosa più impressionante era la loro assuefazione: erano abituati, ecco, erano abituati al male; sorridevano, parlavano del loro più e del loro meno… le infermiere spingevano barelle sulle quali qualcuno, con gli occhi (soc)chiusi, stava per esalare l’ultimo respiro, e spingendo ridevano, parlavano, scherzavano, come se niente fosse. Lui lo vedeva, questo contrasto penoso, tra la leggerezza del personale medico e la gravosità delle persone malate; quando gli esseri umani fanno parte di un personale spesso non sono più persone. «Come si fa – pensava – a far finta di niente in questo modo? Forse è per non impazzire, che fanno così?». Quella leggerezza era insostenibile. Certe volte è più pesante la leggerezza che la pesantezza, come in quel caso.
I medici sono come i meccanici: pensano di poter riparare tutto, si sono laureati per aggiustare corpi umani. Tutti i corpi alla fine si rompono definitivamente ma loro continuano ad aggiustarli; i medici sono nati per alleviare le sofferenze di Tutti, come i preti. La medicina cerca la salute del corpo, la religione ricerca la salvezza dell’anima; la medicina promette salute, la religione si ripromette salvezza, ma nessuno apre gli occhi.
Aveva visto uno morire: l’aveva visto aprire gli occhi per l’ultima volta; occhi stralunati e biechi, quelli che si aprono per l’ultima volta. La vita la si inizia aprendo gli occhi e la si finisce chiudendoli, ma tra l’apertura e la chiusura c’è quel “non vedere” insopportabile che Lui riteneva il compimento di Isaia 6,10:
Rendi insensibile il cuore di questo popolo,
rendilo duro d’orecchio e acceca i suoi occhi,
e non veda con gli occhi
né oda con gli orecchi
né comprenda con il cuore
né si converta in modo da essere guarito.
La guarigione, per Lui, non era quella che prometteva la medicina né quella che si riprometteva la religione: aveva un certa sua “idea”, di guarigione, Lui. Era questa sua “idea”, che lo rendeva antipatico a Tutti. In Matteo 13 Lui leggeva il Cristo dire «In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!», e gli sembrava che Vecchio e Nuovo Testamento facessero comunella per accusarlo della sua cecità, della sua sordità… Anche il Salmo 135 sembrava accusarlo:
Gli idoli delle nazioni sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.
Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono;
no, non c’è respiro nella loro bocca.
Diventi come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida.
Lui però aveva questa idea: che Tutti confidassero nell’ipnosi del mezzo gaudio; sì, la veglia del mal comune che si sogna nell’ipnosi del mezzo gaudio. Troppo doloroso, tenere gli occhi aperti di fronte al male di vivere – pensava Lui –, così Tutti li (soc)chiudono, entrano in trance, fino a quando la morte li costringe a chiuderli.
Era andato a scuola dai salesiani e per lavoro frequentava ambienti cattolici da più di quarant’anni, inoltre era appassionato di filosofia e teologia: per forza che faceva sempre i conti col cristianesimo, Lui, con tutte le omelie che si era sorbito! Nessuno lo capiva, perché si mettesse sempre a citare la Bibbia. Tutti dicevano che i preti l’avevano rovinato, e il discorso finiva lì. Di fatto, Lui cercava solo di prendere sul serio la ‘Buona Novella’; ma, più la prendeva sul serio e più gli sembrava… cattiva.
Quel Matteo 13 non gli dava pace: «guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia». Lui non vedeva, non udiva eppure aveva ascoltato – e come! –, ma senza comprendere. Non la capiva, la ‘Buona Notizia’; forse perché era troppo escatologica. La salvezza è al di là. Il male è al di qua, come questi malati in ospedale. Lui aveva occhi ed orecchi solo per Tutti quelli che soffrono, non per gli idoli della religione: il Salmo 135, per Lui, sembrava parlare dei credenti: di quelli che tengon gli occhi (soc)chiusi per intravedere ciò che a occhi aperti non potrebbero vedere; i credenti nella vita e i credenti in Gesù Cristo, che, appunto, è la Vita.
Si nasce aprendo gli occhi, si vive (soc)chiudendoli e si muore chiudendoli. In Giovanni 9 c’è quel famoso ‘cieco nato’: il Cristo sputa per terra, fa del fango con la saliva, gli spalma il fango sugli occhi e gli dice di andare a lavarseli: «Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva». A Lui il male di vivere si spalmava sugli occhi come il fango evangelico, come una blefarite squamosa che la saliva di nessun oculista era mai riuscita a guarire; viene la tentazione di (soc)chiudere gli occhi, quando bruciano, ma Lui continuava a tenerli aperti. Nessuno faceva così. Tutti (soc)chiudevano gli occhi.
Per non cadere nella condanna di Isaia 6 e Matteo 13 bisogna (soc)chiudere gli occhi. Tra parentesi, socchiudere non è chiudere: è (soc)chiudere con «soc-» tra parentesi. Solo la morte chiude gli occhi veramente, la vita tenta di chiuderli, ma siccome solo la morte li chiude veramente, la vita li (soc)chiude. La vita è un lento chiudere gli occhi, fino alla fine. Tutti cedono alla tentazione blefaritica di far calare le palpebre come un sipario pietoso, come un sudario che nasconde la faccia della morte. Nessuno riesce a tenere gli occhi aperti per sempre. Lui però, almeno, era riuscito a tenere gli occhi aperti per tutta la vita. Solo la morte glieli avrebbe fatti chiudere.
La speranza che dà la fede la si vede solo ad occhi socchiusi: per avere fede bisogna socchiudere gli occhi. Cristo apre gli occhi solo a chi li ha socchiusi; questo significa, la guarigione del cieco nato: che per chi tiene gli occhi aperti non c’è guarigione. Forse per questo Lui non guariva; era incurabile perché teneva gli occhi aperti: come si fa, a dare la vista a chi tiene gli occhi aperti? Chi tiene gli occhi aperti già ci vede. Chi tiene gli occhi aperti ha la vista, e nessun miracolo può dare la vista a chi la vista ce l’ha già. Cristo può dare la vista solo a chi non ci vede, e per non vederci bisogna (soc)chiudere gli occhi o chiuderli… infatti Cristo, oltre a guarire, risuscitava anche: il miracolo è solo per chi ha gli occhi (soc)chiusi e per chi li ha chiusi, cioè per chi è morto.
Matteo 25,29: «A chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha». Matteo 13,12: «Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha». Lui temeva che la punizione, per chi tiene gli occhi aperti, fosse quella di perdere la vista: a chi ce l’ha, la vista sarà tolta. Gesù dà la vista solo a chi (soc)chiude gli occhi? Allora Lui era perduto, (con)dannato a perdere la vista al di là. Tra parentesi, (soc)chiudere e (con)dannare… Senza parentesi la chiusura è dannazione.
Alla faccia del Salmo 135, gli «idoli delle nazioni» non sono argento e oro, ma l’opera delle mani umane: l’assuefazione alla vita. L’assuefazione alla vita procura quel benefico “mezzo gaudio” che il Leopardi – uno dei pochi, oltre a Lui, rimasti per tutta la vita con gli occhi bene aperti – ne La quiete dopo la tempesta definiva «figlio d’affanno»; quel «piacer» che è «gioia vana» perché è «frutto del passato timore». Lì, in ospedale, Lui vide uno svegliarsi dal coma. I parenti più cari gli stavano intorno: sorrisi, affetto, complimenti, congratulazioni, felicitazioni… il peggio è passato, la tempesta è finita: che quiete. Sulla parete, di fuori, vicino all’obitorio, una locandina faceva pubblicità a un’agenzia di pompe funebri che si chiamava La Quiete.
Come la figlia di Giairo, per la ‘Buona Novella’ ogni morto è solo uno che dorme: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Nel dormiveglia della vita ad occhi (soc)chiusi, Tutti pregustano l’esperienza della quiete finale: il sonno della morte apparente. Lui però, in ospedale, vide gente che non si svegliava più. «La nostra vita alterna continuamente sonno e veglia, ma alla fine il sonno vince, – pensava davanti ai cadaveri dell’obitorio –, se uno non sapesse che si deve morire, potrebbe farci su una scommessa: gli umani passano la vita metà addormentati e metà svegli, chissà se alla fine resteranno svegli o addormentati?». Testa o croce? La monetina decida se vincerà la croce del sonno o la testa della veglia. Ci vuole testa, per tenere gli occhi aperti, e Lui ne aveva, di testa. Infatti aveva sempre pensato che chi (soc)chiude gli occhi è uno che non ha testa: i cristiani, poi, gli sembrava che subissero di buon grado la croce proprio perché la testa non la volevano usare; in fondo, che altro è, (soc)chiudere gli occhi, se non staccare per metà il cervello?
Fides et Ratio. Il sonnambulismo cristiano è quello di chi tiene gli occhi per metà chiusi nel sonno della fede e per metà aperti nella veglia della ragione. Sonnambuli che camminano sognando la salvezza, questo sono, i cristiani. Così pensava, Lui. Tutti gli dicevano: ma goditi la vita, che è breve; va’ un po’ in ospedale, a vedere chi sta peggio di te… Lui ci era andato, all’ospedale, ma la vita non riusciva a godersela lo stesso.
«Meno male! Oh, meno male!…» Era arrivata una che temeva di avere un tumore; era con la figlia, e tutt’e due stavano impazzendo dalla gioia, con quel referto in mano: «…meno male che non è un tumore, meno male!». Lui pensava: «Aveva proprio ragione Leopardi: ‘piacer figlio d’affanno’… quella poveretta era affannata dalla paura di avere un tumore ed ora prova il piacere di sapere che non ce l’ha». Lui l’aveva sempre detto, che la gioia umana è solo un “piacere relativo”, e il “meno male” che rimbombava nella tristi sale ospedaliere non faceva che confermarlo: quella tipa era malata, ma non di una malattia mortale, e allora la malattia non mortale era diventata un piacere. Che bello essere malati! Meno male che sono malata di questa malattia e non di un’altra!
Venne il cappellano. Anche gli ospedali hanno i loro preti. I preti ce l’hanno per vocazione, di andare dove il male è maggiore; del resto, non fanno che obbedire a Marco 2,17: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Lui l’aveva sempre pensato, che sia i medici sia i cristiani campano sulle disgrazie altrui: i medici hanno bisogno delle malattie per poter promettere la salute e i cristiani hanno bisogno dei peccati per poter ripromettersi la salvezza. Sul male ci campano in tanti…. Mentre pensava a queste cose, Lui sentì la risata sguaiata di una donna incinta.
Camminando per le corsie ospedaliere, stava avvicinandosi al reparto più ipocrita: quello nel quale le donne stanno per diventare mamme. Lui osservava: una donna incinta è il simbolo più ipocrita della vita: ride per una faccia del pianto dell’altra faccia, come l’umorismo pirandelliano. A Lui era sempre piaciuta, la definizione di Pirandello: «L’umorismo è un fenomeno di sdoppiamento nell’atto della concezione; è come un’erma bifronte, che ride per una faccia del pianto della faccia opposta». Lui diceva sempre che è il concepimento, non la concezione, l’atto più umoristico della vita, è lì che lo sdoppiamento di gioia e dolore assume le sue sembianze più umoristiche; una donna che sta per partorire è proprio un’erma bifronte: ride per una faccia del pianto dell’altra.
Il bimbo finalmente nacque. Appena uscì dalla madre cominciò a piangere, e Tutti i parenti cominciarono a ridere. Lui lo trovò molto umoristico: l’ipocrisia pirandelliana dell’umorismo si ripeteva. Nessuno si vergognava di ridere per il pianto di qualcun altro. La mamma, dopo l’affanno del travaglio, finalmente provò piacere: «piacer figlio…»; il piacere di avere un figlio ripaga ampiamente dell’affanno di una gravidanza. Le donne sono le più assuefatte, alla vita: ogni volta che partoriscono giurano di non lasciarsi mai più mettere incinta, e dopo poco tempo, non appena il loro maschio le tenta, se ne dimenticano. Giovanni 16,21: «La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo».
Lui ricordò quel passo del Gorgia di Platone in cui Socrate dice a Càllicle: «Quindi, noi ora abbiamo rintracciato una forma di retorica rivolta a una massa di bambini, donne e uomini, e schiavi e uomini liberi; una forma, questa, che certo non desta la nostra ammirazione: affermiamo infatti che è adulatoria». A Lui sembrava proprio che la retorica del mal comune facesse presa solo su un pubblico di schiavi: si può adulare solo chi è assuefatto. Lui pensava che la logica del mal comune fosse un po’ come quei demagoghi alla Gorgia, che «si rivolgono alle masse come a bambini, esclusivamente nel tentativo di compiacerli…»: oratoria di massa.
Lui preferiva Guido Morselli, a Platone:
…tutto il mondo giace nel male. «Male» non in senso morale, si capisce; il male morale comincia e finisce col moralismo, il solo male è la sofferenza. Un individuo che soffre, a cui manca quello che gli occorre per essere. [Guido Morselli: Dissipatio H.G. – Gli Adelphi, Milano 2012 – pag. 64]
Prima Lettera di Giovanni 5,19: «…tutto il mondo giace nel male», ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. Guido Morselli cita la Bibbia; la Chiesa traduce «…tutto il mondo sta in potere del Maligno»: il male è diventato il Maligno, è stato moralizzato. Nell’ospedale Lui non vedeva che la Ponerìa: ἡ πονηρία, il cattivo stato di salute, ma non vedeva il Maligno. Tumori maligni sì, tanti, ma il Maligno, no. Povero Morselli, s’è suicidato, prima dell’«Evento», la disintegrazione dell’humanum genus: «l’umanità, angelicata in massa (faccio per dire), si solleva a un empireo. Tutto avviene in silenzio. Una volta tanto, in silenzio e senza retorica. Un volo d’anime, che riempie candidamente il cielo notturno». Senza la retorica platonica dell’anima bella. La Dissipatio Humani Generis – lo dice chiaro, Morselli, – è dissipazione «non in senso morale»: è una sorta di nebulizzazione dell’umanità che evapora nella sua sublimazione finale; Giamblico docet. Dopodiché la Natura «forse si rallegra di riavere in sé tutta la vita, chiuso l’intermezzo breve che per noi aveva il nome di Storia. Sicuramente non ha rimpianti né compunzioni», «il mondo non è mai stato così vivo, come oggi che una certa razza di bipedi ha smesso di frequentarlo. Non è mai stato così pulito, luccicante, allegro», «e questo epilogo, per moltissimi o per tutti, sarà la soluzione di problemi insolubili, il rimedio insperato di mali insoffribili».
…sed libera nos a malo… Nel reparto geriatria era morta una vecchina e l’anziano cappellano aveva appena terminato il Padre nostro; lo diceva ancora in latino, ma se l’avesse detto in greco avrebbe detto ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ribadendo la Ponerìa del male Maligno. La moralizzazione del male fisico è diventata la malignità: la dissipazione fisica (dissolvimento) è diventata dissipazione metafisica (vizio). Il cappellano si segnava nel segno della croce, la croce è il male che redime e salva dal Maligno: è una sorta di omeopatia, la ricetta cristiana per la salvezza; similia similibus curantur, il Salvatore ha riscontrato nel Male della sua passione e morte i sintomi presenti negli uomini “messi male”, cioè malati, e per questo ha incarnato il principio omeopatico della salvezza?
Lui adorava le etimologie e quando scoprì che «malattia» viene dal latino male habitus (= che sta male) capì la radice del ‘mal comune’: l’«abitudine». L’uomo abita il male, e quindi la malattia, per cui il suo habitus è lo spazio sociale che gli permette di avere in comune con gli altri uomini la medesima percezione della vita: per ciò a Tutti sembra normale il male, perché senza la sua normalità non si può socializzare. Lui lo conosceva bene, il prezzo della solitudine derivante dalla mancata socializzazione: non essendosi mai abituato al male, Lui non era mai riuscito a comunicare, con gli altri. Lo “stare” umano è habitus in quanto ‘star male’. Jung scrisse a Freud, su semplice cartolina: Le propongo di sintetizzare la nostra esperienza di psicologi in quattro parole. «Di dentro e di fuori, l’uomo è l’abitudine». Freud rispose: D’accordo! – Parola di Morselli.
Un gruppetto di comari convalescenti pettegolava. Il pettegolezzo è uno dei rimedi più possenti che l’uomo conosca contro il mal comune. Il pettegolezzo parla di ciò che sta sopra al sostrato del mal comune: un iperstrato – Lui lo chiamava – che fa da metacomunicazione aggregante. L’iperstrato della chiacchiera estemporanea è il manto che vela il mal comune, una specie di “velo di Maya”, ma non così flosofico. Tutti parlano l’esperanto dell’iper-chiacchiera, la koinè della normalità. La normalità è requisito essenziale per l’integrazione sociale: l’anormale è essenzialmente uno che parla del mal comune senza usare la koinè della chiacchiera.
1ª Comare: Allora, come va?
2ª Comare: Eh, cosa vuoi… siamo qui.
3ª Comare: Finché siamo qui va bene.
2ª Comare: E tua nipote, s’è poi laureata?
3ª Comare: Oh! sì! E col massimo dei voti.
1ª Comare: Eh, ma è intelligente, sua nipote…
3ª Comare: Ma anche tuo nipote è intelligente, ve’.
1ª Comare: Però non gli piace tanto studiare…
2ª Comare: …ma no, che non è vero…
1ª Comare: …pensiamo a star bene, adesso…
2ª e 3ª Comare: Sì! Quando c’è la salute, c’è tutto.
1ª Comare: Noi siamo qui, ma, avete visto, ieri, quello che è morto di leucemia?
2ª Comare: Oh, non me ne parlare…
3ª Comare: Che pena.
1ª Comare: Se Dio vuole noi possiamo ancora tirare avanti un po’, neh?
2ª Comare: Dai, parliamo di cose allegre, adesso.
3ª Comare: Sì, parliamo di cose belle, sennò….
1ª Comare: Ah, care mie….
Il mal comune è tabù. La morte e la malattia sono il tabù che non si deve nominare; e, se lo si nomina, lo si deve nominare nel gergo apotropaico ed esorcizzante dell’iperchiacchiera. La filosofia esorta a guardare in faccia il tabù del mal comune: solo i filosofi osano parlarne apertamente. Tutti preferiscono ammantarlo di vezzi lessicali garbati ed edulcoranti. La normalità è fatta salva solo se non ci si azzarda a parlare del tabù menagramo: Nessuno è accettato dalla società, se si mette a svelare (= togliere il velo) il mal comune; l’apocalisse del sostrato maligno (= svelamento), senza l’iperstrato della chiacchiera che lo copre, mostra una nudità che agli occhi di Tutti è impudicizia pericolosa. Genesi 3,9-11: «il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».
Se la Bibbia ha ragione, il male è tabù da quando il peccato è entrato nel mondo. Adamo, simbolo dell’umanità, comincia a vergognarsi della propria nudità e i suoi organi genitali diventano la proprie vergogne: le pudende. «Fece bene a vergognarsi, Adamo, – pensava Lui –: tutto il male che ci affligge comincia dai genitali». Vita pudenda est. La vita va svergognata perché deve vergognarsi; ma Tutti si premurano di salvare la vita svergognando la morte. Mors pudenda est. Il tabù menagramo della morte è impudico perché è impudente, sfrontato, spudorato. Il pudore che Tutti hanno nei confronti del mal comune è vestito su misura con l’abito ben confezionato dell’iperchiacchiera. Nessuno deve denudare il mal comune e mostrarlo per quel che è: Tutti si stracciano le vesti, se Qualcuno lo fa.
Matteo 26,65-66: Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Le buone maniere condannano la bestemmia, e condannato è chi parla del tabù primigenio ed atavico che istituì il nefandum: la colpa. Le vecchine cianciavano, da buone comari, e Lui pensava all’etimo di nefandum: ne + for, faris, fatus sum, fari = ciò che «non va detto». È incredibile, come le parole colleghino la «colpa» e l’«innominabile» nel nome della «nefandezza»! Nefando è l’«indicibile» misfatto di cui bisogna provare vergogna, il reato la cui rievocazione comporta la pena dell’esilio, dell’esclusione sociale.
Lui era stato mandato all’ospedale affinché, vedendo il mal comune in tutta la sua indecenza, ne provasse vergogna e, per il futuro, non si azzardasse più a pronunciarlo senza il velo della chiacchiera. Ma Lui al cospetto del mal comune reagì come Nessuno si aspettava: invece di coprirlo con la buona maniera del nefas ne parlò per fas et nefas, a diritto e a torto; a diritto secondo Lui, a torto secondo Tutti. Das Gerede, è la chiacchiera secondo Martin Heidegger: il § 35 di Essere e Tempo è tutto dedicato a Das Gerede:
«La chiacchiera è la possibilità di capire tutto senza preliminare appropriazione della cosa: essa protegge infatti dal pericolo di fallire in tale appropriazione. La chiacchiera, che chiunque può captare, non soltanto dispensa dal compito di una genuina comprensione, ma crea una comprensibilità indifferente cui nulla più si sottrae.» [Martin Heidegger: Essere e tempo – I Meridiani Mondadori, Milano 2006 – traduzione di Alfredo Marini – pag. 485].
Uno dei sintomi più sicuri della vicinanza del tabù è offerto dall’aumento della chiacchiera estemporanea e disimpegnata: quanto più il mal comune della passione e morte si fa dappresso, tanto più lo scudo della chiacchiera lo scherma per coprirne le vergogne. In ospedale era morta un’altra persona: lo si capiva dall’andirivieni inquieto del personale medico e infermieristico; due infermiere compivano il pietoso ufficio del paravento: quella specie di copertura a soffietto con delle ante che scorrono su rotelle. Si chiama paravento, ma non serve a riparare dal vento, non è un parabrezza; piuttosto, serve a coprire l’«Evento», l’evento della pena capitale che la vita commina a tutti: la Morte. La morte, il tabù ancestrale causato dalla colpa edenica, ha un sacco di cortine che le fanno da paravento: la chiacchiera del gossip è il paravento principale che Tutti usano per mascherare il mal comune.
1ª Infermiera: Fai piano che questi paraventi sono fragili, costano un occhio della testa ma si rompono come niente…
2ª Infermiera: Dove lo mettiamo?
1ª Infermiera: Qui, di sbieco, così… è meglio che quell’altro degente non veda… sai, ha la stessa malattia di cui è morto questo… non vorrei che…
2ª Infermiera: …certo… piano, fai piano, che sennò cade…
1ª Infermiera: …sì ecco, così…
2ª Infermiera: …’sto paravento sembra la veneziana che ho comprato per la casa al mare… sai, la casa che abbiamo comprato a Portofino…
1ª Infermiera: …ah, sì, la vostra casa di Portofino…
2ª Infermiera: …mio marito ci teneva tanto, con quel sole che batte sempre, d’estate, in salotto…
1ª Infermiera: Beata te che hai la casa a Portofino!
2ª Infermiera: Non costa nemmeno poi così tanto, perché non ve la prendete anche voi?
1ª Infermiera: Chissà, prima o poi… ma, piano, fai piano, con ‘sto paravento…
2ª Infermiera: Dài, che ce l’abbiamo fatta: è a posto, ci siamo.
1ª Infermiera: Ecco, così: non lo vede più nessuno, pover’uomo, con quel che ha sofferto…
2ª Infermiera: …guarda gli annunci immobiliari: a Portofino ci sono tanti appartamenti residenziali accessibili anche alle nostre tasche…
1ª Infermiera: …veramente, bisogna proprio che guardi…
Lui stava ascoltando questa chiacchierata e sperava che il defunto non sentisse. «Poverino – pensava – già ci starà male per il fatto di essere morto, non vorrei che ci stesse anche male per il fatto di non poter mai più andare a Portofino… chi lo sa? Magari era il suo sogno, andare a Portofino…».
Arrivò il cappellano: parlava del defunto e diceva che si era convertito, proprio in extremis; per il rotto della cuffia… A Lui venne in mente Luca 23,39-43:
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Qualcuno stava ad ascoltare il cappellano che commentava quel decesso:
Cappellano: Pover’uomo, quanto ha sofferto! Non aveva più nessuno, la moglie gli era morta e di figli non ne avevano potuti avere: era solo. Poi questa SLA: la sclerosi laterale amiotrofica l’aveva ridotto a una larva, non parlava nemmeno più, era tutto bloccato… In fin di vita, all’ultimo, è riuscito a farmi capire che era pentito… Sì, ha accettato la confessione sacramentale, lui, un mangiapreti impenitente! Gli ho dato l’assoluzione; ora è nelle mani di Dio. Mah, come Dio vuole, pover’uomo… Che il Signore lo abbia in grazia… il Signore sia lodato…
Qualcuno biascicò: «…sempre sia lodato». Strano, che Qualcuno, lì, osasse lodare quel capolavoro che la SLA aveva compiuto. Lui pensò: «Qualcuno può lodare Dio, senza lodare la SLA? Spero di sì!». Il Cappellano se ne andò sussurrando Giobbe 1,21: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!».
A Lui venne in mente la Risposta a Giobbe di Jung: la creatura “fa la morale” al suo Creatore, gli insegna a fare il dio. Lui aveva letto, ne La riga, la squadra e il compasso, come Dio possa essere, in qualche modo, il “paziente” dell’uomo.
«L’uomo aiuta Dio a guarire e Dio aiuta l’uomo nella guarigione. Ci vuole coinvolgimento, ci vuole interesse reciproco, sennò non succede niente. Se il medico è ferito di quella stessa ferita di cui è ferito il suo paziente, allora il paziente guarirà il medico prima ancora che questi possa guarire lui. Se Jung ha ragione, l’uomo e Dio sono feriti dalla stessa ferita: la ferita della differenza, la ferita della differita. L’uomo è lontano da Dio perché Dio è lontano da se stesso così come Dio è lontano dall’uomo perché l’uomo è lontano da se stesso. Sembra che tutto ciò che è pensato diventi realtà: non solo il pensiero di Dio è creatore, anche quello dell’uomo. Dobbiamo guarire Dio dalla ferita del suo essere Due e così guariremo noi stessi da quella stessa ferita» [Davide Cantino: La riga, la squadra e il compasso].
La riga, la squadra e il compasso, di un certo Davide Cantino, era uno dei libri che Lui preferiva in assoluto: gli sembrava che la sua teoria dell’omeopatia soteriologica fosse confermata dal fatto che anche in psicanalisi l’analista riesce a guarire il proprio paziente solo se riesce a patire il suo stesso disagio; in fondo, che altro è, l’incarnazione? Dio accetta di ammalarsi dello stesso male umano per poterne trovare l’antidoto; bisogna provare, per credere. Giobbe, analista di Dio?
Provare per credere. Lui non credeva. Forse perché non aveva provato? Ma provato che cosa? Cosa bisogna provare, per credere? Prima Lettera di Giovanni 1,3: «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi». Lui udiva soltanto i lamenti dei malati, e ciò che provava non lo induceva a credere. «Forse bisogna provare quello che hanno veduto e udito i discepoli, per credere?». Lui aveva provato più volte la sensazione che si prova all’annuncio che i preti fanno del kerigma, ma mai era riuscito a credere.
La pazienza è sintomo di abitudine. La fenomenologia dell’assuefazione vede nella pazienza il suo sintomo più rivelatore: è infatti assai “sintomatico”, che il malato (= affetto dal mal comune) si chiami «paziente»; paziente è chi sopporta, dal latino patiens, che è participio presente del verbo patior, eris, passus sum, pati: sopportare. Sopportare è patire, e non a caso Aristotele ha fatto della passio una categoria del pensiero umano; actio e passio sono le due categorie, opposte e contrarie, che regolano la vita umana. Anche Tommaso d’Aquino lo diceva, quod actio sit actus agentis, et passio actus patientis: l’assuefazione e la dipendenza dall’essere fanno credere che persino la passio sia un actus! Platone, poi, nel Sofista, aveva detto che «si debba porre come determinazione distintiva (ὅρον ὁρίζειν), che le cose che sono altro non sono se non capacità (τὰ ὄντα ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναμις)» e Aristotele, in Topici 146a 22-23, dirà qualcosa di molto simile all’ ὅρος di Platone:
τὸ ὂν τὸ δυνατὸν παθεῖν ἢ ποιῆσαι
«essere è ciò che è capace di patire o fare». Patior, ergo sum? Ago, ergo sum? So di essere perché subisco? perché agisco?
Lui pensava che quando l’essere umano vede il proprio agire, ma soprattutto il proprio subire, in tutto il suo essere autenticamente nudo, senza nessuna chiacchiera che lo copra, perde la pazienza perché vede la propria dipendenza e la propria assuefazione alla vita: l’abitudine è la morfina che addormenta l’informazione ontologica. Se l’informazione è – alla Gregory Bateson – percezione di una differenza, l’essere umano riceve l’informazione del proprio essere dalla percezione della differenza esistente tra il sostrato del male comune e l’iperstrato del mezzo gaudio; questo pensava, Lui.

Il gaudio sta in mezzo, fra male e bene, ed è la conclusione del sillogismo convenzionale che la chiacchiera esprime quando sentenzia: è la vita! La percezione della differenza è espressa dalla chiacchiera nell’eufemismo eudemonico che esorcizza il mal demonico (= mal comune). La percezione della differenza sarebbe insopportabile, senza l’eufemizzazione della chiacchiera. La morfina eufemistica del bon ton fa da paravento al tabù del mal comune e anestetizza la tremenda categoria della passio. L’abitudine azzera lo spread esistente tra i due emisferi opposti della percezione di actio e passio generando la narcosi esistenziale. «Chissà se narcosi e necrosi assonano a caso?» – così pensava, Lui. In fondo, è proprio la percezione della differenza tra narcosi e necrosi l’informazione ontologica della vita. Marco 15,22-23: Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Il Messia rifiuta l’anestesia: vuole bere il calice fino in fondo. Luca 22,41-43: Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Forse è perché a noi non appare mai nessun angelo dal cielo, che non riusciamo a bere il calice del mal comune fino in fondo… chi ci conforta, noi? Il mezzo gaudio della comunella?
Camminando su e giù per l’ospedale, al fine di trovare il mezzo gaudio promesso dal proverbio e dai suoi amici Tutti, Lui era ripassato per il triage, termine francese che indica smistamento: «chissà perché hanno usato un termine francese, per indicare questo squallido indirizzamento dei pazienti in pronto soccorso?». Ognuno un codice: codice bianco, nessuna urgenza; codice verde, urgenza minore; codice giallo, urgenza; codice rosso, emergenza; codice nero, decesso. Codice arancione, il paziente è contaminato.
Per Lui la vita era tutta da codice nero, perché Tutti muoiono. Lui considerava la vita un’emergenza, da codice rosso, appunto, e non capiva quel celeste di Tutti, che, tra l’altro, non è un codice contemplato dal triage. E nemmeno capiva il viola di Qualcuno, che, oltre a non essere previsto dai codici del triage, ricordava tanto la Quaresima. Nessuno aveva niente da dire, perché era codice nero: morto. Solo Lui capiva l’emergenza, e pensava: «Chissà, se al triage del Giudizio Universale, Dio smisterà i pazienti con dei codici di tipo ospedaliero? A quel Giudizio arriveranno tutti morti: se non si muore non si è nemmeno ammessi all’esame. Saremo tutti da codice nero, mortis in examine. Dio prima ci grazia e poi ci dà la grazia. I beati in codice bianco e i dannati, i contaminati dal peccato, in codice arancione?». Lui pensava a Luca 7,15: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». Il codice arancione è quello di coloro che hanno fatto uscire da se stessi cose sbagliate?
I medici fanno entrare nella bocca dei pazienti quantità industriali di farmaci: tanto, non è ciò che entra, ciò che contamina; ciò che entra poi esce… vita defecatio magna: defecatio matutina bona tamquam medicina, defecatio meridiana neque bona neque sana. «La vita finisce con una defecatio serotina – pensava Lui – e la scuola salernitana non l’aveva nemmeno presa in considerazione: nefas? alla sera della vita saremo giudicati sull’amore, e forse questa non è una cagata…». Prima ai Corinzi 15,32: «Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo»; Paolo cita Isaia 22,13: «Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo!». La narcosi non piace, al cristianesimo. La narcosi del mezzo gaudio che defeca la necrosi del mal comune è da uomo animale, non spirituale. «Saremo giudicati sull’amore, ma come si fa ad amare – pensava Lui – se non si ama la vita?».
L’amore per la vita è conditio sine qua non per poter amare. Chi non ama la vita nemmeno può amare altro, perché tutto è vita. Infatti, Lui aveva una sua “idea” di non-vita: la vera guarigione dell’essere umano sta nel nonessere – pensava. Se la vita è tutto, solo nel niente posso non amare – pensava. Non è che Lui non volesse amare perché l’amore non gli piaceva, no, è che non gli piaceva l’amore per la vita, tutto qui; e non gli piaceva l’amore per la vita perché non gli piaceva la vita, ovviamente. Ma, se saremo giudicati sull’amore, su cosa sarò giudicato, io, che non amo la vita? – pensava.
Gli avevano assicurato che lì, in ospedale, davanti a chi stava peggio di lui, Lui avrebbe imparato ad amare la vita, almeno la sua. Invece, niente. Imparare il mezzo gaudio dal mal comune gli ricordava tanto quel famigerato passo della Somma teologica, in cui San Tommaso d’Aquino scrisse che beati in regno coelesti videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat, i beati, nel regno celeste vedranno le pene dei dannati affinché la (loro) beatitudine più se ne compiaccia: Lui pensava che Tutti, consigliandogli quel “day hospital” filosofico, fossero un po’ come i beati del regno celeste: gente che aumenta la propria beatitudine guardando alle disgrazie altrui. Lui, al riguardo, la pensava come Nietzsche, e infatti la citazione dell’angelico dottore gli veniva dalla Genealogia della morale:
Dante, a mio parere, ha commesso un grossolano errore nel porre con una ingenuità da far paura sulla porta del suo inferno quell’iscrizione «fecemi l’eterno amore» – sulla porta del paradiso cristiano e della sua «eterna beatitudine» potrebbe stare in ogni caso a maggior diritto l’iscrizione «fecemi l’eterno odio» – ammesso che una verità possa stare sulla porta di una menzogna! Che cos’è, infatti, la beatitudine di quel paradiso?… Forse potremmo già indovinarlo; ma è meglio che ce lo attesti espressamente una autorità indiscutibile in questa materia, Tommaso d’Aquino, il grande maestro e santo. «Beati in regno coelesti – dice costui con la mitezza di un agnello – videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat». [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prima dissertazione, § 15 – pag. 38].
Chi ama la vita è gretto, egoista: perfetto interprete dell’istinto di sopravvivenza e di conservazione insieme. Come possono, Tutti, usare il mal comune alla maniera di un elettroshock? Provocare un accesso compulsivo con una scarica di folgorante mysterium iniquitatis…! La terapia elettroconvulsivante va forse bene per la depressione, per la psicosi, ma Lui non era affatto depresso, né psicotico: che ci andassero loro, Tutti quanti, in ospedale!
A vedere le pene dei pazienti in ospedale, Lui non solo non imparò ad amare la vita, ma, anzi, incominciò ad odiarla sempre più; non era tipo da gioire delle disgrazie altrui, e sperava proprio che Tommaso d’Aquino avesse scritto quella castronata dopo aver alzato un poco il gomito, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo; è per colpa di frasi come quella, che i filosofi più polemici hanno buon gioco, contro il cristianesimo. Nessuno deve compiacersi delle disgrazie altrui – così pensava, Lui. Sperava proprio che Tommaso fosse alticcio, quando scrisse quella robaccia, ubriaco di vino, per una volta, e non di Spirito Santo. Atti 2,1-13:
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».
A leggere queste cose, Lui, era fortemente tentato di credere. «Dev’essere entusiasmante – pensava – essere pieni di Spirito Santo, parlare in lingue…». Lui si era sempre rammaricato, per il fatto di non essere mai riuscito a parlare la lingua di Tutti, quella chiacchiera narcotica così analgesica e sedativa… si era sempre crucciato perché Nessuno capiva la sua lingua. «Qualcuno mi capisce? – pensava – Qualcuno può capirmi?». Solo taluni defunti, come Guido Morselli, forse, avrebbero potuto capirlo, ma quelli avevano fatto tutti una brutta fine. Non era una brutta fine, che Lui voleva, ma, anzi, un grande e generale lieto fine; solo, non sapeva in quale copione potesse trovarsi un lieto fine che non uscisse da un deus ex machina come Minerva dalla testa di Giove. «Nel medioevo cristiano Minerva, nata direttamente dalla testa della suprema divinità maschile, venne interpretata come la Sapienza che muove da Dio»: l’Enciclopedia Treccani era una grande consolazione, per Lui: vi trovava tutto ciò che voleva sapere.
La Sapienza. Gran cosa, la sapienza. Ma la ‘Buona Novella’ aveva trovato il modo di stroncare anche quella; Lui non sopportava Luca 10,21:
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli».
A Lui sembrava un insulto, quel passo di Luca. «E dunque – pensava – chi esulta di gioia nello Spirito Santo dice queste cose? Insulta la sapienza umana?». Quando pensava a quel passo di Luca gli effetti dello Spirito Santo gli sembravano meno desiderabili. Cosa aveva fatto, il cristianesimo, della sapienza? Uno stuoino su cui Dio si pulisce i piedi; uno zerbino buono per far da sgabello alla teologia, una passatoia su cui transitare per andare oltre. Oltre, dopo: in greco, μετά. L’oltre-mondo è meta-fisico. L’oltre-uomo di Nietzsche no.
Gli venne in mente il male metafisico di Agostino. Lui aveva letto, nelle Confessioni, che «il male non è che privazione di bene fino al nulla assoluto»: per Agostino, allora, il nonessere è il male assoluto? Lui non voleva finire male, però voleva finire nel nulla, e perciò tentava di salvare il nonessere dalla condanna agostiniana. Tutti volevano essere, e lì, in ospedale, la follia della brama ontologica si toccava con mano. Nessuno voleva non essere: codice nero. Chi può volere il codice nero, in un ospedale? L’ospedale è il luogo in cui innanzitutto e perlopiù non si fa altro che evitare la morte: la medicina serve a questo, o no? La medicina è come la grazia: salutare; salus, in latino, è sia salvezza metafisica sia salute fisica; c’è da sperare che la grazia sia più efficace delle medicine: non c’è una medicina che salvi dalla morte! Già, ma ci vogliono i sacramenti, segni efficaci della grazia, sennò, niente salute.
«Salute!». In corsia Qualcuno aveva starnutito e Tutti gli avevano augurato la salute, come si conviene; le buone maniere della chiacchiera non facevano certo difetto, in ospedale, e gli auguri sono la quintessenza della chiacchiera – pensava Lui. Il cappellano passò velocemente per accorrere al cappezzale di un altro moribondo da salvare: …salus perpetua… – bofonchiava ansimando. Lui cercava la quinta essenza, il quinto elemento oltre terra, acqua, aria e fuoco, ma non un quinto elemento alla Empedocle, o alla Aristotele, no: qualcosa di esterno all’elementarità della materia, qualcosa che non fosse cosa e che nemmeno fosse Dio, che non fosse fisica empedoclea né metafisica aristotelica; qualcosa di “filosofale”, non di filosofico.
Di “filosofale” a Lui veniva in mente solo la “pietra”, quella che pare mutasse ogni elemento in oro. Favole alchemiche. A Lui, però, non interessava l’oro, bensì il nonessere: essere-niente, essere-nulla, senza stare a disquisire se niente e nulla siano la stessa cosa; “non è cosa”, parlare di niente, o di nulla. Questa era la salvezza, la salute che Lui si augurava: il nonessere. Ma in ospedale Nessuno voleva il nonessere, né il non-essere, né il non essere: Tutti volevano essere (in vita). «Ci sarà mai Qualcuno che desidera non essere in vita? – pensava Lui –, Qualcuno che si chieda se tra essere ed essere-in-vita c’è qualche differenza…». Era Uno che pensava, Lui.
Per gli umani c’è forse qualche modo di essere diverso dall’«essere in vita», dall’«essere vivo»? Parrebbe di no. Se «essere in vita» fosse tutto l’essere umano, finita la vita, finito l’essere umano. Ma è così? Sarebbe troppo bello! Lui, dopo tanto pensare, si riposava mettendo in semplici poesiole i contenuti impegnativi dei suoi pensieri; una volta, pensando al presente dell’essere e al niente del nonessere, scrisse la seguente bazzecola, che alterna sempre le stesse rime originando il titolo Presente / Niente:
La vita certo è uno strano presente:
la si regala a chi non ne può niente,
a chi ancora nemmeno è presente
e quindi proprio non può farci niente.
La si regala a chi non è presente
per fare sì che lui esca dal niente:
è un presente che rende presente
senza preavviso, così, in un niente.
C’è qualcheduno, quaggiù, al presente,
che preferiva restare nel niente?
Forse costui non è ancora presente?
E se è presente, perché dice niente?
Va be’, sentite, assente o presente,
in verità me ne frega un bel niente:
ci sono io, quaggiù, ben presente
e di costui non m’importa, per niente;
visto che io qui sono presente,
dico ben forte a chi è ancora nel niente,
dico ben chiaro a chi già è presente:
è molto meglio restare nel niente
piuttosto che scender qui nel presente!
E voi perché fate finta di niente,
perché fate come chi non pre-sente
che questa vita finisce in un niente?
Chi è nel niente non so se pre-sente,
(se nel non essere si sente niente
questo non so) ma so che chi è presente,
sa che non è una cosa da niente
scendere qui, poter dire: «presente!»
e poi mancare all’appello in un niente;
Tu che mi leggi, ehi, tu, sei presente?
E allora basta far finta di niente!
Perché decidi di render presente
qualcuno senza che ne sappia niente?
Senza nemmeno saper se ha presente
cosa lo aspetta quaggiù – dici niente? –
Tu che mi leggi, su, dimmi: «presente!»
voglio saperlo: è finito nel niente
questo mio appello? Dai, dimmi: “presente!
sì, sì, ci sono, non sono nel niente”.
E se ci sei, tu che dici “presente”,
dimmi, com’è? stavi male, nel niente?
Ehi tu, rispondi! Non sei più presente?
«Non lo son più: guarda un po’, per un niente,
son trapassato, non son più presente,
sono defunto e non sono più niente…
…mi senti ancora? tu che sei presente?»
Non sento nulla! non sento più niente!
Ehi, tu, lettore, non sei più presente?
Che è? adesso fai finta di niente?
Dovevi dirmi, ce l’ho ben presente,
se stavi male, quand’eri nel niente….
…e invece nulla. Non sei più presente?
Dimmi, ti prego, che adesso nel niente
hai ciò che un vivo nemmeno pre-sente:
la pace eterna dell’essere niente!
Lui si divertiva come un idiota a comporre queste bazzecole, ma ne andava fiero, perché essere idioti non è essere deficienti: è sempre l’etimo a decidere le sorti di una parola, e «idiota» viene dal greco ἴδιος che vuol dire «proprio», «personale», «privato»; la proprietà peculiare di ciascuno è l’idiotismo che lo rende idiomatico: non è idiozia, è carattere personale e irripetibile. Quando Tutti gli davano dell’«idiota» Lui ne gioiva in cuor suo, perché intendeva quell’epiteto nel modo giusto – ἔτυμος – sapendo che τὸ ἔτυμον è «il significato vero e originario» di una parola.
Una sirena tagliava l’aria: Qualcuno, su un’ambulanza, stava arrivando al pronto soccorso. Presto il triage avrebbe sancito il colore del codice. Quando Qualcuno si trova su un’ambulanza non è mai buon segno, al di là del colore del codice. Come nel V canto dell’Inferno dantesco, anche al triage c’è un “minosse” che sentenziando smista pazienti e «vede qual loco d’inferno è da essa». Al triage
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
essamina le colpe ne l’intrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.
È un inferno, l’ospedale. Lui non capiva proprio perché Tutti gliel’avessero consigliato… Forse che, come Dante, come Paolo o Enea, anche Lui doveva compiere il suo itinerarium mentis in Deum, all’avventura, alla… Bonaventura da Bagnoregio? Perché girare per quei gironi? Perché vagare tra quelle bolge? Malebolge… il mal comune lo si vede bene, nelle Male-Bolge. C’è sempre Qualcuno che v’arriva, malamente.
L’ambulanza aveva finito di fischiare e Qualcuno era sceso, con le sue gambe, ma sorretto da due crocerossini, perché, infatti, su una delle due gambe zoppicava. Lui venne poi a sapere che quel Qualcuno aveva condiviso la sorte di Talete: peripateggiava passeggiando in meditazione e gli successe ciò che
«…si racconta di Talete, il quale, mentre stava mirando le stelle e avea gli occhi in su, cadde in un pozzo; e allora una sua servetta di Tracia, spiritosa e graziosa, lo motteggiò dicendogli che le cose del cielo si dava gran pena di conoscerle, ma quelle che avea davanti e tra i piedi non le vedeva affatto. Questo motto si può ben applicare egualmente a tutti coloro che fanno professione di filosofia». [Platone: Teeteto – in Opere complete 2: Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico – Biblioteca Universale Laterza, Bari 1990 – traduzione di Manara Valgimigli – pag. 124]
Così Platone, in Teeteto 174 [a-b]. Lui era ben felice che all’ospedale vi finisse finalmente Qualcuno che si era infortunato lavorando col cervello; ce n’erano pochi, in ospedale, di ‘infortuni sul lavoro mentale’: un vero e proprio “INAIL filosofico”! Al triage non sapevano infatti dove mandarlo: nemmeno l’esperto “minosse” di turno aveva la minima idea di dove si manda un filosofo… meno male che Lui intervenne:
LUI: Signor Minosse, lo mandi in osservazione, è un filosofo…
MINOSSE: Ma non vede che zoppica? E guardi che caviglia gonfia che ha! È una frattura, ascolti me, è una frattura: lo devo mandare in radiologia a fare una bella radiografia; ha finito, per un po’, di fare il peripatetico!
QUALCUNO: Stavo attraversando i binari del treno e, non so come, sono caduto.
MINOSSE: Stava andando al lavoro?
QUALCUNO: Sì.
MINOSSE: Quindi è un INAIL.
QUALCUNO: Cos’è, un INAIL?
MINOSSE: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: bell’acrostico, vero?
QUALCUNO: Sì, non lo conoscevo…
LUI: Signor Minosse, nemmeno io lo conoscevo.
MINOSSE: Lasciate fare a me, voi due, siete filosofi e non ve la cavate bene, nelle cose pratiche. Piuttosto, perché, signor Qualcuno, lei ha attraversato i binari del treno? Non c’era, il sottopassaggio?
QUALCUNO: Sì, ma arrivava solo fino al binario cinque, e il mio treno partiva dal binario sei.
MINOSSE: Ma in che stazione ferroviaria ci sono ancora sottopassaggi che non arrivano a tutti i binari?
QUALCUNO: Nella stazione di Chivasso.
LUI: È vero, una volta l’ho preso anch’io il treno, dal binario sei, e ho dovuto attraversare il binario cinque.
MINOSSE: Robe da matti! Ci sono ancora stazioni del genere?
LUI e QUALCUNO: Così pare.
Lui seppe poi che Qualcuno si era procurato una frattura all’apice del malleolo peroneale destro; una robetta da niente che però gli causò quasi un mese di gesso: gli fecero una ‘doccia gessata’ che lo costrinse ad un pensiero non peripatetico di tipo domestico, con la gamba in su. Lui lo cercò poco dopo, ma l’avevano già dimesso.
Qualcuno era di quelli che non se la sentono di rinnegare la vita e quindi si pongono a metà tra la celeste speranza di Tutti e il codice rosso di Lui. C’è sempre Qualcuno che preferisce lamentarsi della vita senza metterla in discussione: Leopardi, per esempio. Qualcuno è semplicemente pessimista: il pessimismo è una delle più poetiche menzogne, perché usa il male di vivere per chiacchierare; la chiacchiera poetica è la visione romantica della vita. Il leopardiano Canto notturno di un pastore errante dell’Asia è una delle poiesi più tipiche del romanticismo: ci si lamenta della vita ma la si vive.
Nasce l’uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
Per prima cosa; e in sul principio stesso
La madre e il genitore
Il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
Con atti e con parole
Studiasi fargli core,
E consolarlo dell’umano stato:
Altro ufficio più grato
Non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perchè dare al sole,
Perchè reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
Perchè da noi si dura?
Leopardi non era certo uno qualunque: era Qualcuno, non c’è dubbio, un grande; Lui, però, aveva sempre evidenziato in viola quei cinque versi:
Ma perchè dare al sole,
Perchè reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
Perchè da noi si dura?
Qualcuno arriva solo fin lì – pensava Lui –: arriva a capire il mal comune ma non si spinge fino al codice rosso della desistenza. Desistenza: così Lui chiamava quella certa “idea” che aveva in testa per guarire Tutti dalla vita. Leopardi diceva «a me la vita è male», «è funesto a chi nasce il dì natale», ma poi si fermava lì: Lui pensava che Qualcuno, nei secoli scorsi, era arrivato ad un passo dalla “soluzione finale”, ma non l’aveva osata. Soluzione finale, ovviamente, non nel senso nazista del termine.
Il Romanticismo è stata una delle più poetiche menzogne che la storia abbia mai ammirato; menzogne, poetiche ma ipocrite. Ancora una volta Lui era d’accordo con le etimologie: «romantico» viene da romance, cioè ‘romanzesco’, non reale. Il Romanticismo prese il mal comune come tema delle sue poiesi e ci ricamò su una pittoresca fiction di trine morbide. Le poiesi romantiche sono narcotiche, sono la necrosi romanzata del mal comune. L’ispirazione romantica è essenzialmente quella del piangersi addosso: il cosiddetto pessimismo che Qualcuno – lo stesso Leopardi – ostenta, in ultima analisi ha bisogno del mal comune per ordire il suo bel broccato ben filato. L’ordito che la poiesi romantica trama, è ordito alle spalle della verità.
Per “verità” Lui intendeva il sostrato del mal comune osservato senza l’iperstrato del mezzo gaudio narrativo. Lui non voleva essere un ‘io narrante’ perché pensava che, dal momento che si comincia a narrare, la chiacchiera è già lì a velare la verità del mal comune: per ciò Tutti lo chiamavano Lui. Tutti amavano la maya poietica che costruisce castelli in aria sulle fondamenta del mal comune, Lui invece abbatteva quei castelli lasciando che le fondamenta potessero vedersi per quel che sono. Tutti cianciavano, Qualcuno si lamentava delle ciance cianciando; Lui preferiva non cianciare.
Non gli andava proprio giù, che Qualcuno si lamentasse delle ciance cianciandoci su: se si decide di mangiare in un piatto, in quel piatto non si deve sputare; non si sputa nel piatto in cui si mangia. Qualcuno mangiava i suoi stessi sputi; che schifo! La vita fa sputare sangue e Qualcuno con quel sangue ci fa delle flebo. Per i giovani “farsi una flebo” significa annoiarsi, farsi seghe mentali: ecco, Lui pensava, Tutti sono un po’ come i romantici, raccolgono il sangue che la vita fa loro sputare e ci fanno delle flebo. I Canti del Leopardi sono bellissimi, ma sono una flebo, così pensava.
Proprio vero, parli di flebo e la flebo arriva: un’infermiera stava spingendo una sedia a rotelle sulla quale un paziente languiva con una flebo al braccio. Fleboclisi. In greco φλέψ φλεβός è sostantivo femminile che vuol dire «vena», «vaso sanguigno». Sempre in greco, κλύσις -εως è sostantivo femminile che vuol dire «lavaggio con clistere», dal verbo κλύζω: «lavo». Fleboclisi: un clistere “per endovena” (sic!). I romantici della chiacchiera si lavano la bocca, con il mal comune, si sciacquano la cavità orale; l’oralità è la flebo della chiacchiera, ma Lui pensava che l’oralità andasse superata, così come va superata la ‘fase orale’, alla Freud. La libido rematica – ῥῆμα significa ‘parola’ – verbalizza il piacere del mezzo gaudio che nasce dalla parola nefasta del mal comune: ne fas! Parola impronunciabile e afasica, quella del mal comune.
Qualcuno ama la Quaresima: quadragesima, quadragesimus, quarantesimo giorno prima di Pasqua. Tutti sono felici come delle pasque, Qualcuno fa penitenza. Tutti hanno bisogno che Qualcuno faccia quaresima, perché senza quaresima Nessuno può essere felice come una pasqua. Lui non era felice come una pasqua e nemmeno triste come una quaresima: Lui aveva superato il pessimismo morboso di chi si compiace del mal comune senza nominarlo. Lui non era Nessuno, non era Qualcuno, e, pure, non era come Tutti. Tutti vogliono essere e Nessuno vuole non essere: per Tutti essere felici è essere. Tutti si lamentano, ma per Tutti essere è essere felici.
«La società si riproduce ciecamente, trae da uomini e cose altri uomini e altre cose, e qualsiasi piano si abbozzi, tosto essa lo rompe e dilaga come se avesse un’esistenza propria che pendesse come una mannaia sul capo di tutti. È la propria esistenza, infatti, che le interessa. Essa pensa solo a esistere e basta». [Manlio Sgalambro: De mundo pessimo, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 2004 – Dell’apatia – pag. 156].
Lui non amava essere, ma non per questo odiava l’Essere. Certo, se essere è essere (in) vita, allora Lui odiava l’essere; il che avrebbe anche potuto essere in linea con la ‘Buona Novella’ di Giovanni 12,25: «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna». Peccato che a Lui non interessasse conservare la propria vita per la vita eterna. Ha proprio ragione Sgalambro: Tutti pensano solo a esistere e basta. Bulimia ontologica. Lui non era anoressico, ma nemmeno bulimico, ontologicamente. Certe volte pensava che la certezza cristiana del non praevalebunt avesse sempre avuto buon gioco perché faceva leva sulla bulimia ontologica di Tutti: «io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza», Giovanni 10,10.
A Lui veniva quasi la nausea, quando vedeva Tutti strafogarsi di vita, Qualcuno affogarvisi dentro e Nessuno affogare veramente. Per Tutti affogare è farsi un «affogato», un sorbetto tutto ricoperto di vita, di melassa ontologica: sorbirsi la vita facendosi un affogato è quel far finta di affogare che il naufragio leopardiano dell’Infinito così romanticamente definisce «dolce»; ma è solo Allegria di naufragi, pensava Lui, senza per questo voler insultare Ungaretti. La fiction preferita da Tutti è la favola narrata da Esopo ne Lo scherzo del pastore:
Un giovane pastore portava ogni giorno le sue pecorelle a pascolare. Si annoiava molto e così decise di fare a tutta la gente del villaggio uno scherzetto. “Aiuto… al lupo al lupo!”. Iniziò allora a gridare con quanto fiato aveva nella gola. Arrivarono tutti i contadini armati di forconi e randelli, ma quando giunsero nel grande prato non videro neanche l’ombra del lupo. Il pastorello rideva a crepapelle: “Era solo uno scherzo e voi ci siete caduti!”. Qualche giorno dopo rifece lo stesso e i contadini allarmati giunsero di gran carriera al prato. Subito si accorsero che il giovane pastore si era burlato ancora una volta di loro. Un giorno arrivò d’improvviso un intero branco di lupi; il giovane pastore iniziò a gridare disperatamente: “Al lupo al lupo!”. Ma questa volta i contadini, pensando a un’altra burla non si mossero più. Indisturbati, i lupi, fecero strage di pecore e agnelli. Chi mente sempre non è più creduto quando afferma la verità.
«Tutti fanno come quel giovane pastore – pensava Lui –: scherzano col codice rosso senza pensare che ogni codice rosso, prima o poi, diventa codice nero». Nessuno lo capiva. Proprio in quel momento si sentì un segnale acustico intermittente, con cadenza lenta: un degente aveva effettuato la chiamata dal suo letto premendo il pulsante rosso incorporato nella stazione di testaletto: «al lupo! al lupo!»; nessuna infermiera però si affrettò ad accorrere, perché quel degente premeva troppo spesso il pulsante rosso, era un rompiscatole. È tipico dei pazienti esercitare il diritto alla chiacchiera romantica: più si invecchia e più ci si aggrappa ai medici e alle medicine. Nessuno affronta di petto il problema morte, no, Tutti si cullano nell’illusione che medici e medicine possano procrastinare a tempo indeterminato il licenziamento ontologico: questo ricorrere sempre più spesso a medici e medicine, che aumenta di anno in anno, a mano a mano che si invecchia, è lo stesso che fa ricorrere al sacro e ai sacramenti. Gli anziani amano parlare dei propri bubù perché parlare dei bubù è il modo migliore per non parlare del babàu della morte. La vita “fa” la bua e gli anziani, tornando bambini, si lamentano della bua per non pensare alla vita che “la fa”.
«La vita è una bua piena di bubù che finiscono in un babàu – pensava Lui». Negli ospedali Tutti confidano nei medici, ma Geremia 17,5 disse «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore». La speranza celeste di Tutti coloro che hanno un bubù esorcizza il pensiero del babàu intonando il Salmo 131: Qualcuno dispera,
Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.
“Finire in un babàu” assona tanto con “finire in un amen”: ogni messa finita è un andare in pace. Quel degente che suonava troppo spesso il pulsante rosso rompendo le scatole alle infermiere è morto; adesso che era morto, Tutti lo compativano dicendo: «Poverino, ma allora stava male sul serio!». I bubù postumi sono sempre canonizzati dal babàu. Bisogna morire, per poter essere presi sul serio. Lui pensava a Guido Morselli; in prima pagina, su Dissipatio H.G. la casa editrice Adelphi ha scritto: «Ormai considerato un classico della letteratura italiana contemporanea, Guido Morselli…» eccetera eccetera; ma, se era un classico della letteratura contemporanea – pensava Lui – perché Morselli è stato pubblicato solo a partire dal 1974, cioè postumo, visto che s’era ucciso nel 1973? Perché le case editrici hanno sempre rifiutato i suoi scritti finché era in vita?
Certi editori si sentono degli dèi: come Dio, fanno la grazia solo post mortem. «La salvezza, se ci si pensa bene, è sempre postuma» – pensava Lui, e gli veniva in mente quello che la Madonnna avrebbe detto a Bernadette nella terza apparizione di Lourdes: «Non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell’altro». Siamo tutti dei condannati a morte, ma Dio ci concede la grazia solo dopo averci graziati! Al di qua concedere la grazia a un condannato a morte significa revocare la pena di morte, al di là graziare significa far morire. Come il chicco di grano che si trova in Giovanni 12,24 anche la vita non viene condonata se prima non muore. E gli editori fanno lo stesso: un libro non germina editorialmente, se prima non ne muore l’autore!
La falce, «che pareggia tutte l’erbe del prato», aveva appena reciso la vita di una bambina: lo strazio dei genitori esternava lamenti quasi animaleschi. Lui pensava: «Ma, chi mette al mondo una vita, non lo sa, che la morte può arrivare in ogni momento? Perché Tutti si ostinano a pensare che la falce della morte tagli solo arbusti stagionati?». E, se tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Luca 23,27-31:
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?».
A guardare quei due genitori piangere sulla salma della propria bambina, Lui vedeva Dio come uno sterminatore, e gli veniva ancora in mente Sgalambro:
L’Uno che secondo Platone non è «né questo né quello» è tale non perché sfugge a ogni determinazione positiva, ma perché le distrugge continuamente. Insomma, se si esamina il concetto di Dio, vien fuori che egli è ‘Niente’ non davanti alla logica delle definizioni, ma perché annienta continuamente ogni determinazione, perché è l’Annientante. [Manlio Sgalambro: De mundo pessimo, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 2004 – Lettera sul’empietismo e su un recente progresso della teologia – pagg. 248-249].
Quella bambina, ormai morta, era una “determinazione” da annientare? da far terminare nello s-terminare celeste? Tutti lo pensavano: la mia carne riposa nella speranza, caro mea requiescit in spe. La speranza di uscire dalle determinazioni esistenziali? per approdare all’indefinibile Uno di Platone? o di Cristo? o di Nessuno?
Tutti vogliono il loro bene. Il Bene non interessa molto, ma il bene sì. Lui aveva letto il Menone di Platone, e ricordava quella frase che Socrate dice a Menone in 77 [c]: «Non ti sembra, uomo eccellente, che tutti desiderino cose buone?». Le cose buone sono quei beni di cui il Bene è ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα, le cose buone, τὰ ἀγαθά oppure τἀγαθά, sono l’oggetto che il desiderio, ἡ ἐπιθυμία, desidera, ἐπιθυμέω, dal profondo della sua anima, ὁ θυμός, la quale è il latino fumus. In greco ὁ θυμός è l’anima come «forza vitale» e tale sostantivo è incorporato quasi psicosomaticamente nel verbo ἐπιθυμέω a dire che il desiderio nasce dall’animazione stessa dell’anima. Lui non desiderava la vita – lo sapevano Tutti – e quindi restava sempre di stucco, quando sentiva Platone far dire a Socrate che Tutti desiderano il Bene. «Come posso usare il verbo ἐπιθυμέω per desiderare il nonessere? Come posso usare un verbo che contiene in sé la vita stessa?» – così pensava.
Il vecchio cappellano dell’ospedale recitava il De profundis per il rito delle esequie celebrato in onore della piccola defunta; il Salmo 130: «Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce», De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam… e Lui si chiedeva: «Ma, nel profondo, cosa c’è? Forse lo θυμός di Platone? Il cuore? Forse che il profondo del Salmo 130 sono i precordi?». In Lui c’era un gran desiderio di nonessere: com’era possibile che questo desiderio fuoriuscisse dalla vita stessa? La piccola defunta sarebbe stata cremata, questa era la volontà dei genitori; un rogo avrebbe avvolto il suo corpicino… Lui pensava a Isaia 30,33:
Il Tofet, infatti, è preparato da tempo:
esso è pronto anche per il re.
Profondo e largo è il rogo,
fuoco e legna abbondano.
Lo accenderà, come torrente di zolfo,
il soffio del Signore.
«Il soffio del Signore» è, nella traduzione dei Settanta, ὁ θυμὸς κυρίου e nella Vulgata è flatus Domini. Lui non sapeva spiegarsi come tutto, da Platone alla Bibbia, congiurasse per fare dell’anima la forza vitale che desidera l’animazione della vita: nell’Antico Testamento ὁ θυμός è addirittura il fiato di Dio!
Nel Menone Socrate non ha dubbi: «…la virtù è volere le cose buone e averne il potere», ἡ ἀρετὴ βούλεσθαί τε τἀγαθά καὶ δύνασθαι. Ma volere non è potere – pensava Lui. Se virtù è la capacità – δύναμις – di procurarsi le cose buone – τἀγαθά – sembra che la vita non sia una cosa buona, dal momento che non è in facoltà di Nessuno il procurarsela in modo definitivo. Tutti vogliono vivere per sempre e Nessuno ci riesce.
…nessuno ci riesce… ripensando a questa frase, Lui era tentato di fare un’analisi logica che facesse di Nessuno un soggetto a tutti gli effetti: come se fosse una persona in carne ed ossa; tipo Ulisse, nel IX Libro dell’Odissea, che quando Polifemo gli chiede come si chiama, risponde: «Nessuno è il mio nome», Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα. «Se Nessuno può procurarsi una vita eterna al di qua, pur volendolo, è segno che solo uno che non sia Qualcuno può procurarsi la felicità».
Lui pensava: «Se Nessuno è un soggetto vero e proprio, deve essere per forza un abitante del nonessere. Il nonessere è il regno di Nessuno, e perciò non ha luogo, cioè è u-topico: u-topia deriva dal greco οὐ (= non) e τόπος (= luogo) e significa dunque «non-luogo». Se c’è un essere che ha luogo, dev’esserci anche un nonessere che non ha luogo. Il soggetto è ciò a cui si riferisce ogni predicato, ora, se io voglio un soggetto al quale non sia riferibile nessun predicato, posso solo pensare a un soggetto che sia Nessuno, o Niente… Niente sono i nonesseri non umani del regno del nonessere e i vari Nessuno ne sono gli abitanti umani che non sono».
Lui aveva letto da qualche parte che «nessun documento storico testimonia la morte di Nessuno, probabilmente perché Nessuno può vivere per sempre», non ricordava più dove l’aveva letto; ma ricordava invece molto bene di aver letto nel Menone come alcuni
Sostengono che l’anima dell’uomo è immortale (Φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀντρώπου εἶναι ἀθάνατον), che ora ha una fine – che gli uomini chiamano morire – e ora di nuovo nasce, ma che non va distrutta mai (ἀπόλλυσθαι δ’οὐδέποτε). Ed è per questo che bisogna vivere la vita nel modo più pio possibile: infatti coloro di cui
Persefone accetterà l’espiazione dell’antica
colpa, di questi nel nono anno restituisce le anime
in su, verso il sole superiore;
e da queste nobili re e uomini potenti per forza e grandissimi
in sapienza cresceranno; e nel tempo a venire saranno chiamati
dagli uomini eroi puri.
[Platone: Menone – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2010]
Il frammento 133 di Pindaro che Socrate cita in Menone 81 [b-c] parla di una colpa antica che gli umani avrebbero commesso (contro Persefone?). A Lui veniva in mente Giovanni 12,25: ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. Chi ama la propria Psyché la perde: ἀπολλύει αὐτήν, lo stesso verbo usato da Platone quando dice che la Psyché non va distrutta mai, ἀπόλλυσθαι δ’οὐδέποτε. Platone ha una speranza più verde, di quella celeste del Cristo: la ‘Buona Novella’ prende in considerazione anche la ‘Cattiva Novella’ della perdizione eterna, che Platone considera, sì, ma non nei termini cristiani del “perdere l’anima”. L’anima è immortale… Mentre pensava a queste cose camminando per un oscuro corridoio dell’ospedale, Lui si trovò improvvisamente dinnanzi l’obitorio. Tutti conoscono la parola «obitorio», ma solo Qualcuno conosce l’«òbito»: la morte. Obeo, is, ii, itum, ire: andare incontro, percorrere, passare; obire diem: morire & presentarsi nel giorno.
La piccola era lì dentro. A guardarla, tutto sembrava, tranne che immortale. Lui pensava alla figlia di Giairo, della quale il Cristo disse: «la fanciulla non è morta, ma dorme». A Lui sembrava morta. «Forse la morte e la vita dipendono da come le guardiamo? È questo, credere?» – pensava Lui. Ma, per quanto cercasse di vederla viva, la bimba restava morta. «Se Platone avesse ragione – pensava guardando la piccola – i suoi genitori potrebbero rivederla in qualche sua incarnazione… Se Platone ha ragione, la sua anima è ancora da qualche parte…».
A Lui non andava proprio giù, questa storia dell’immortalità dell’anima, questa favola bella dell’indistruttibilità “psichica”, e ripensava ossessivamente alle parole di Socrate: l’anima non va distrutta, mai, ἀπόλλυσθαι οὐδέποτε, mentre fissava gli occhi chiusi della bimba stesa in quella camera mortuaria. Pochi posti favoriscono la riflessione tanto quanto un obitorio; forse solo nei cimiteri Lui aveva trovato ambienti così favorevoli al pensiero, ma in un obitorio è diverso, perché lì vedi la salma in tutta la sua morte. Del resto, la filosofia è essenzialmente pensiero sulla morte, più che sulla vita… tradizionalmente si vuole che Amleto dica le sue parole più famose proprio davanti a un teschio. Essere o non essere?
Se ha ragione Platone, e l’anima è indistruttibile, addio ‘non essere’. È questo che a Lui non andava: dover essere per sempre, in un modo o in un altro: dal momento che nasci, sei eternamente. Allora meglio non nascere. Se Platone ha ragione, «apprendere è reminiscenza», τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις. Ma Lui non ricordava proprio nulla: forse ricordare nulla è ricordare il nonessere in cui eravamo prima di nascere? Ricordare nulla non è ricordare niente. Un po’ come Nessuno, che è Qualcuno: è colui che abita il nonessere.
Per fare la diagnosi della patologia di cui era affetta la povera bambina ora defunta, i suoi genitori avevano collaborato con il medico affinché l’anamnesi riuscisse il più efficace possibile, ma niente da fare; anamnesi patologica recente, anamnesi patologica remota… la storia clinica della piccola era stata redatta con cura. Anche nella Santa Messa che il cappellano aveva celebrato per lei, l’anamnesi era stata pronunciata con enfasi: unde et memores… «celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo»: la celebrazione anamnetica del cappellano fu toccante. L’anamnesi che Socrate spiega a Menone induceva a non credere che la redenzione del Cristo fosse un evento perfetto compiuto una tantum: il ‘sacrificio perfetto’ di cui parlano le preghiere eucaristiche della Messa e che san Paolo spiega in Ebrei 9,27-28:
«E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza».
Come si fa a credere? – pensava Lui. Da una parte Platone, per il quale all’Anima tocca nascere di nuovo, πάλιν γίγνεσθαι; dall’altra Paolo, per il quale agli uomini tocca morire una sola volta, ἅπαξ ἀποθανεῖν. Come conciliare il πάλιν (= di nuovo) di Platone con l’ἅπαξ (= una volta sola) di Paolo? Lui era un sostenitore dell’ἅπαξ λεγόμενον: sperava che l’essere di ogni umano fosse ontologicamente unico ed irripetibile; si augurava che la vita non fosse eterna, ma che, nel libro dell’essere, essa fosse pronunciata una volta soltanto per ogni essere umano, al di qua: ἅπαξ λεγόμενον. Almeno questo! In realtà, Lui aveva una speranza assai più ambiziosa: che l’essere non fosse mai più pronunciato da Nessuno, ma per questo ci voleva la desistenza. “Pronunciare” l’essere è far essere: se uno non c’è, non può pronunciare nulla. Il Creatore ha fatto essere il creato pronunciando il suo fiat: Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. … Dixit quoque Deus: Fiat firmamentum… Dire è porre in essere, almeno per Dio.
La bambina stesa davanti a Lui non diceva più nulla. Dicevano che, in vita, era una chiacchierona, che cinguettava come una cinciallegra. Flatus vocis… Lui sperava che il monaco Roscellino di Compiègne avesse ragione: il suo nominalismo estremo poteva aprire un varco al nonessere, perché se le parole sono solo “aria fritta”, ad esse non corrispondono realtà sostanziali; non per niente Roscellino fu accusato di eresia per il triteismo che professava, e tutti i suoi libri furono bruciati. Ma a Lui non gliene poteva fregar di meno, del triteismo; semplicemente, Lui vedeva nel nominalismo un modo per sconfessare la dipendenza ontologica del linguaggio dall’essere: «la parola creatrice è una mostruosità – pensava –, qualunque dio può arrivarti lì, dire una cazzata e quella cazzata ti diventa una cosa reale!
A Lui sembrava che il Creatore non fosse poi così onnipotente: in fondo, Lui non poteva non essere. In quel momento si accorse che, come una vita a Lui parallela, un altro Lui aveva fatto capolino: il Lui ‘che è’. A questo punto, a Lui venne in mente che, se doveva esistere un essere che non poteva non essere – Lui – allo stesso modo doveva non esistere un essere che doveva non essere: il nonessere – Lui. Non esistere non è non essere: è non essere in vita; ma, chi l’ha detto, che non essere in vita debba per forza essere da qualche altra parte che non sia la vita? La vita eterna del cristianesimo, come quella del platonismo, sono un essere per sempre, al di là di questa vita, ma, chi l’ha detto, che, se c’è ‘questo essere qui’, al di qua, non ci possa non essere ‘questo essere qui’ al di là? che questo essere al di qua possa una buona volta non essere al di là. E se essere al di là fosse un semplicissimo nonessere? Il problema non è «essere o non essere»; il problema è: «essere e nonessere».
Genere animale, specie umana… differenza… le tre sostanze seconde di Aristotele potrebbero essere flatus vocis. «Io appartengo al genere animale e alla specie umana – pensava Lui – e la differenza specifica tra me e un animale è che io ho la ragione e l’animale no: questa è la mia definizione? La differenza specifica tra me e un animale?». Fu così che si pose il problema della differenza specifica intercorrente tra medico degli umani e medico degli animali: tra un dottore e un veterinario. «Se uno curasse solo il corpo sarebbe un medico della somaticità. Se uno curasse solo l’anima, sarebbe un medico della psichicità. Se l’essere umano è un sinolo psicosomatico, che se ne fa, di due dottori? Ci vorrebbe un medico solo che curasse sia la Psyché sia il Soma» – così pensava.
Gli veniva ancora in mente l’Odissea, perché nell’XI libro si legge che
questa è la sorte degli uomini, quando uno muore:
i nervi non reggono più l’ossa e la carne,
ma la forza gagliarda del fuoco fiammante
li annienta, dopo che l’ossa bianche ha lasciato la vita;
e l’anima, come un sogno fuggendosene, vaga volando.
Quella “vita” che abbandona le bianche ossa degli umani, nel greco di Omero è θυμός ma la ψυχή poi se ne vola via, quindi la ψυχή non è il θυμός. Presto il fuoco avrebbe cremato le bianche ossa della bimba defunta stesa lì davanti a lui senza θυμός, in obitorio: e la sua ψυχή? dov’era? c’era ancora?
Quando Nessuno va nell’Ade, la sua defunta madre gli dice ciò che prima Lui aveva letto nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti ma poi nella versione più classica di Ippolito Pindemonte:
È de’ mortali
Tale il destin, dacchè non son più in vita,
Che i muscoli tra sè, l’ossa, ed i nervi
Non si congiungan più: tutto consuma
La gran possanza dell’ardente foco,
Come prima le bianche ossa abbandona,
E vagola per l’aere il nudo spirto.
E se Nessuno andasse all’Ade? Lui in Matteo 25,46 è categorico: «E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna»; per questo Lui preferiva credere in un nonessere nel quale non vi fossero né beati né dannati, né giusti né ingiusti: perché non gli andava di immaginare un’eternità eternamente divisa tra buoni e cattivi, tra beati e dannati, tra salvati e condannati.
«Se lo θυμός è il fiato umano che fa vivere – pensava Lui –, il mio desiderio non è ἐπι + θυμία (= secondo il θυμός) perché io non desidero affatto che il mio θυμός salga al cielo come una specie di “fumo” psichico». Sperava che la teologia cristiana fosse fumo negli occhi. «Lo Spirito è la differenza che c’è tra il genere psichico (= Anima) e la specie somatica (Corpo)?» – così si chiedeva. Se così fosse,
Anima : Corpus = Spiritus : Ratio
Come il Logos razionale è la differenza tra genere animale e specie umana, così lo Pneuma spirituale è la differenza tra genere psichico e specie somatica… tutto fumo, θυμός!
Lui ce l’aveva a morte con Lui. Non poteva, non doveva, Lui, tirar fuori quello Pneuma per sublimare l’Anima-Psyché-Logos: lo Pneuma può diventare dissipatio animae, se qualcosa va storto, dissipatio animae et corporis, anzi. Sempre che per dissipatio non si intenda la distruzione ma la dispersione… i genitori volevano che le ceneri della piccola defunta fossero sparse al vento, disperse… Ma il cappellano cercava di convincerli, che la chiesa non vuole lo spargimento delle ceneri. Lui, davanti a queste proibizioni ecclesiastiche diventava cattivo: «Ha forse paura, la Chiesa, che, nel giorno del Giudizio, chi ha fatto spargere le proprie ceneri dopo la cremazione, non ritrovi più il proprio corpo?». Che scenetta ridicola: un’anima che non trova più il proprio corpo! Platone ci avrebbe fatto su uno dei suo dialoghi. Il cristianismo impone di credere alla resurrezione dei corpi; Romani 8,11: «E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi». C’è però anche Giovanni 5,28-29: «viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna».
A Lui non andava proprio giù, questa discriminazione post mortem: πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. Amava distinguere i colori dei due grassetti: rosso per i dannati e celeste per i salvati: et procedent qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae; qui vero mala egerunt, in resurrectionem judicii. Il codice rosso era quello dei dannati. Il codice azzurro era quello dei salvati. In ospedale, però, il codice azzurro non esisteva, quello rosso sì. Al triage della ‘Valle di Giòsafat’ codice rosso o codice azzurro – pensava Lui – perché il codice bianco del Purgatorio sarà superato.
Gioele 4,1-2:
Poiché, ecco, in quei giorni e in quel tempo,
quando ristabilirò le sorti di Giuda e Gerusalemme,
riunirò tutte le genti
e le farò scendere nella valle di Giòsafat,
e là verrò a giudizio con loro.
«E là verrò a giudizio con loro…» – dice Lui –, καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς. Il verbo διακρίνω vuol dire «separare» ed è lo stesso usato in Ezechiele 20, 33-35: «Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore Dio –, io regnerò su di voi con mano forte, con braccio possente e con ira scatenata. Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano forte, con braccio possente e con ira scatenata e vi condurrò nel deserto dei popoli e lì a faccia a faccia vi giudicherò»: καὶ διακριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς. A Lui non era mai piaciuto, il Dies irae, quando supplicava:
Inter oves locum præsta
Et ab hædis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
La separazione del διακρίνω nel giudizio del κρίνω. In latino haedus è un innocuo sostantivo maschile che vuol dire «capretto», come ovis è un innocente sostantivo femminile che vuol dire «pecora»: che bisogno c’è di tutto quell’accanimento escatologico? Perché proiettare nell’Aldilà quella smania di giustizia che abbiamo al di qua? al di qua, va bene, è giusto prendersela con i capri, giudicarli, metterli in galera e magari dare loro persino l’ergastolo, se se lo meritano; ma, al di là, perché non “lasciarli vivere” impedendo che vivano? perché non “lasciarli in pace” permettendogli il nonessere? Questa sarebbe misericordia, per Tutti.
Ezechiele 37 si apre con uno scenario apocalittico:
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore”». Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno all’altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c’era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: “Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano”». Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: “Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. Perciò profetizza e annuncia loro: “Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò”». Oracolo del Signore Dio.
Lui evidenziava sempre in azzurro quelle parole, perché gli sembrava che Antico e Nuovo Testamento si dessero man forte e congiurassero insieme per lanciare meglio la loro minaccia ontologica e imperversare sulle coscienze; «quel benedetto spirito – pensava – perché deve a tutti i costi svegliare i morti? Perché non li lascia riposare in pace?». È ipocrita, la preghiera dell’eterno riposo, con quel suo «riposino in pace…». Lui non ha rispetto, per chi dorme nel sonno eterno, Ezechiele 37,14 lo testimonia: «Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete», καὶ δώσω τὸ πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς καὶ ζήσεσθε; lo Pneuma, τὸ πνεῦμα: è Lui che dà fiato alle trombe del Giudizio, quel fiato è Dio stesso, come dice Giovanni 4,24: «Dio è spirito», πνεῦμα ὁ θεός, Spiritus est Deus.
La piccola defunta era sempre lì, stesa, con gli occhi chiusi; ma, a un certo punto, sembrava averli socchiusi per un istante, gli occhi, sicchè a Lui venne voglia di parlarle:
LUI: Dove sei, piccola?
LEI: Dove non sei tu.
LUI: Ma allora sei da qualche parte?
LEI: In parte.
LUI: Hai parte nell’essere?
LEI: In parte.
LUI: Cosa vuol dire, “in parte”?
LEI: L’essere non è parte di me, ma io sono parte di Lui.
LUI: Allora sei da qualche parte.
LEI: Sì, in qualche parte.
LUI: Vuoi dire in qualche misura?
LEI: È smisurato, l’essere.
LUI: Quindi non si può, scampare all’essere?
LEI: Se si vuole, sì.
LUI: Cioè, vuoi dire che chi lo vuole, dopo la morte può non essere?
LEI: Sì.
LUI: Tu, quindi, sei perché hai voluto essere?
LEI: Sì.
LUI: Perché hai voluto essere?
LEI: Perché sono stata bene, in vita.
LUI: Vuoi dire che chi sta bene in vita vivrà per sempre?
LEI: Sì.
LUI: E colui per il quale la vita è male?
LEI: Per costui è bene non essere.
LUI: Bene è dunque essere se si vuole e male essere se non si vuole?
LEI: Il desiderio è θυμός, pulsione di vita.
LUI: E il non desiderio?
LEI: Il non desiderio è noluntas: pulsione di morte.
LUI: La dicotomia freudiana di ἡ φιλία e τὸ νεῖκος?
LEI: La dicotomia empedoclea di amore e odio. Come dice Empedocle, «che l’universo è ora in moto ora di nuovo in quiete: in moto quando l’Amicizia dalle cose molteplici forma l’uno o quando la Contesa dall’uno forma le cose molteplici, in quiete nei periodi di tempo intermedi».
LUI: Come dice Aristotele nella Fisica quando parla appunto di Empedcle! Ma come fai a sapere tutte queste cose?
LEI: L’essere è internetwork, è sapere in rete ontologica.
LUI: Senti, tu dici che chi prova τὸ νεῖκος dopo la morte non sarà più? Sei sicura?
LEI: Sì.
LUI: Ma come fai a dirlo, se tu sei? Come fai a vedere chi non c’è, se tu sei? se tu sei nell’essere?
LEI: Noi che siamo, vediamo il non essere appunto perché siamo.
LUI: Ma, allora, conseguentemente, chi non è dovrebbe vedere l’essere proprio in quanto non è!
LEI: Vedere non è essere, e non vedere non è non essere.
LUI: Tu quindi, che sei, non vedi? Se hai appena detto che vedi il non essere in quanto sei!
LEI: Non può capirlo, uno che vive ancora nell’esserci; ma, se proprio vuoi, te lo dico così: io, che sono, mi vedo essere e perciò vedo anche che non sono nonessere. Sum, ergo non sum non esse.
LUI: Tu allora vedi chi dice Non sum, ergo sum non esse?
LEI: Io lo vedo perché non lo vedo.
LUI: ?
LEI: Sta’ tranquillo, se ami τὸ νεῖκος tu non sarai in eterno.
LUI: Ma non sarò avendo coscienza di essere oppure non sarò e nemmeno ne avrò coscienza?
LEI: Solo chi è ha coscienza.
LUI: Il nonessere è dunque incoscienza?
LEI: Il non essere è non essere, in coscienza.
LUI: Ma cosa intendi tu, adesso, per coscienza? Consapevolezza di un valore morale, o consapevolezza che un essere ha di essere?
Lui si risvegliò da quel sogno dispiaciutissimo per non aver potuto sentire la risposta alla sua ultima domanda; ci teneva, a sentirla, subito, però, il suo dispiacere trapassò nel piacere di una simpaticissima ironia: in fondo, com’è vero che uno trova solo ciò che cerca, è anche vero che uno sente solo ciò che desidera sentirsi dire. Era tutto un sogno, cioè Lei aveva detto ciò che Lui desiderava sentire: Lui stava praticamente parlando con se stesso e le risposte che si dava erano le cose che desiderava fattesi verbo.
Chissà, se il Verbo, che il cristianismo dice essersi fatto carne, in ultima analisi non incarni altro che il desiderio più profondo dell’umanità: essere? Chissà, forse la parola, il verbum, non è che la proiezione verbale di un desiderio… se così fosse, la forma mentis avrebbe in sé solo le categorie dei concetti che vuole avere… quindi Tutti hanno sempre parlato di vita eterna perché questo è ciò che desiderano… del resto, il fatto che desiderio sia ἐπι + θυμία lascia forse intendere che Tutti hanno “in animo” di vivere, hanno “a cuore” la vita, hanno “ἐπι θυμός” l’essere; e, siccome poi si tende a mettere su un “piedistallo” ciò che si desidera, forse è per ciò che Tutti hanno posto l’Essere in cielo e hanno fatto derivare il desiderio de sideribus, «dalle stelle»: un desiderio è sempre astrale, siderale, specie quando è irraggiungibile… è così che gli si canta gloria in excelsis. In De sideribus, Ampelio scrisse che gli astri ad arbitrium suum vagantur et motu suo hominum fata regunt: gli umani si lasciano reggere e governare volentieri dai desideri che hanno posto nel loro empireo siderale.
Lei – cioè Lui – gli aveva lasciato aperto uno spiraglio, aveva lasciato spazio a un po’ della sua speranza meontologica, quando nello scambio delle due seguenti battute
LUI: E colui per il quale la vita è male?
LEI: Per costui è bene non essere.
gli aveva fatto, forse, intendere che a colui per il quale la vita è male è riservato il nonessere? Forse. In realtà, Lui, un po’ perché sapeva di essersi sentito dire esattamente ciò che desiderava, un po’ perché la frase di Lei era sibillina, non era affatto sicuro della sua speranza meontologica: «cosa voleva dire, Lei, quando mi disse: ‘per costui è bene non essere’?» – pensava – «…una cosa può essere bene che non sia, ma invece magari è: lo constatiamo ogni giorno, al di qua». Lui sperava che Lei volesse dirgli: stai tranquillo, siccome Dio vuole il tuo bene, se per te è bene non essere, tu non sarai in eterno.
Ma, il bene, è ciò che “è bene” per ognuno di noi, o non forse ciò che è “Bene” per tutti? “Il” Bene, o “il mio” bene? Ancora Platone e la sua mania di idee universali! Potremo mai liberarci dalle nostre categorie mentali? Le nostre categorie mentali sono l’effetto dei nostri desideri o non piuttosto quello della nostra storia, del pensiero che i nostri antenati ci hanno lasciato nel DNA? Noi siamo soltanto l’eredità dei nostri avi che sopravvive a se stessa e a noi stessi? Lui sperava ovviamente di no; sperava che, almeno al di là, ognuno potesse vivere per sempre il proprio bene, cioè ciò che al di qua ha sempre desiderato. Uno ha sempre desiderato essere? Che sia eternamente! Un altro ha sempre desiderato non essere? Che non sia in eterno! Lui tendeva a vedere l’al di là come il regno in cui ognuno raggiunge la propra felicità, non quella degli altri.
Certe volte gli veniva da pensare che la deformazione professionale più notevole e perniciosa del ‘lavoratore di concetto’, come si dice – ma Lui voleva dire del filosofo – è quella di voler sempre ricondurre tutto agli universali. La Metafisica di Aristotele è proprio il ‘manifesto’ di questa mania occidentale: l’eziologia che si sposa con l’universale ontologico. «Tutti gli uomini per natura tendono al sapere», così esordisce la Metafisica di Aristotele, e, si noti, quel sapere è εἰδέναι (che puzza tanto di idea platonica). Poi, «l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è conoscenza degli universali», la γνῶσις degli universali si ottiene con la τέχνη e non con la ἐμπειρία. Coloro che hanno imparato l’arte dall’esperienza sono i veri conoscitori, in quanto essi: «conoscono il perché e la causa», mentre gli altri «sanno il puro dato di fatto»: hanno “scienza” unicamente coloro che «sanno la causa», τὴν αἰτίαν ἴσασιν. Il verbo οἶδα riserva ai “tecnici” l’εἰδέναι della gnosi. Aristotele sentenzia dunque: «noi riteniamo che l’arte sia soprattutto la scienza e non l’esperienza», laddove scienza è ἡ ἐπιστήμη. Sapienza, σοφία, è «la ricerca delle cause prime e dei princìpi», «è una scienza che riguarda certi princìpi e certe cause»; essa pertiene a chi possiede «la scienza dell’universale», ἔχοντι τὴν καθόλου ἐπιστήμην. «E la più elevata delle scienze, quella che più deve comandare sulle dipendenti, è la scienza che conosce il fine per cui vien fatta ogni cosa; e il fine, in ogni cosa, è il bene, e, in generale, nella natura tutta, il fine (τὸ οὗ ἕνεκα) è il sommo bene (τἀγαθόν)».
In ospedale, Lui non vedeva altro che ricercatori del sommo bene aristotelico, infatti ogni medico che si rispetti ricerca le cause delle malattie per poter addivenire a una scienza che possa ambire al sommo bene della salute: la scienza medica. In ospedale Lui vedeva anche la ricerca di un altro sommo bene: la salvezza, solo che non erano medici coloro che la perseguivano, bensì preti. Per il raggiungimento sia della salute sia della salvezza si bada all’universale: per i medici universale è la legge fisica della salute, per i preti è la legge metafisica della salvezza; la prima guarisce il corpo, la seconda l’anima. La religione guarisce l’anima con lo Spirito e la medicina guarisce il corpo con i farmaci. Lo Spirito è per l’anima ciò che i farmaci sono per il corpo.
Certe volte Lui pensava che la teologia cattolica avesse rubato la sua “cattolicità” al καθόλου di Aristotele: vedendo che solo una legge universale può assurgere alla dignità di scienza e così diventare efficace per il conseguimento della salute, può darsi che la religione abbia pensato di elevare anche lei il suo concetto di legge universale innalzando la salute fisica agli altari della salvezza metafisica e denominando poi tale concetto “Dio”. In questo senso, Dio sarebbe nient’altro che la santificazione della salute, la canonizzazione di un procedimento scientifico.
«Sarà per questo che Tutti mi hanno caldamente consigliato questa esperienza ospedaliera? – pensava Lui – perché io giungessi a capire che la salute è il correlato fisico della salvezza?». Ma concluse che non poteva essere, che Tutti fossero così intelligenti; non che Lui sottovalutasse Tutti, ma, onestamente, era poco probabile che Tutti gli avessero consigliato un ritiro spirituale di tipo ospedaliero perché Lui capisse il funzionamento del procedimento alchemico di sublimazione della salute fisica in salvezza metafisica: non Tutti erano così profondi.
Effettivamente, la trasmutazione alchemica somiglia molto alla transustanziazione teologica; i sette gradi della trasmutazione alchemica – calcinazione, sublimazione, soluzione, putrefazione, distillazione, coagulazione e unione – sono una sorta di “scala” analoga a quella che serve per salire al parnaso del Tabor, monte sul quale il Cristo si è trasfigurato. Ecco, la trasmutazione fisica della scienza medica sembra aver fatto da modello alla trasfigurazione metafisica della scienza teologica; Luca 9,28-36:
Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Et facta est, dum oraret, species vultus ejus altera: questa species è, nel greco di Luca, τὸ εἶδος e altera è ἕτερον; a dire che l’alterità della salute fisica è, nella trasfigurazione cristiana, la salvezza metafisica – così pensava Lui. La salvezza è una “specie alterata” di salute. Magari non adulterata, ma alterata sì.
«Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica…». Il Simbolo Niceno-Costantinopolitano professa la cattolicità della Chiesa. L’universalità è la vocazione del cattolicesimo: καθολικός vuol dire universale, e καθόλου (καθ’ ὅλου) ne è l’avverbio, quello usato da Aristotele nella Metafisica. L’universalità è l’essere assoluto, l’essere assolutamente, in generale, completamente e nell’insieme: in totale. È stupefacente, rilevare che il greco ὅλος (= tutto intero) ha il suo esito latino nell’aggettivo salvus! L’ ἐπιστήμη è conoscenza (= scientia) vera perché è universale, e universale è quella sapienza (= σοφία) che conosce le cause: la conoscenza della causa prima è dunque conoscenza assoluta.
La Wissenschaftslehre di Fichte è l’esito romantico della dottrina dell’ἐπιστήμη nel suo iter cattolico che Platone ha siglato metafisicamente e Aristotele ha puntualizzato fisicamente: dottrina della scienza. La scienza fisica è gnoseologica, la scienza metafisica è ontologica. La ricerca dell’universale è, platonicamente, ricerca del διὰ πάντων cioè di ciò che “passa” attraverso tutto, che per-corre tutte le cose: il dia-pason ontologico; in Menone 74 [a] Socrate dice: «Eccoci di nuovo ricaduti nella stessa situazione, Menone: cercavamo una (μίαν) virtù sola e ne abbiamo trovate molte (πολλάς), in un modo diverso rispetto a poco fa: ma quell’unica, che passa attraverso tutte (ἣ διὰ πάντων τούτων ἐστίν) queste, non riusciamo a scoprirla». La molteplice pluralità che diviene esistenzialmente al di qua, procede da εἷς μία ἕν (= uno) il cui esito latino è sem-el, sem-per: una volta per tutte, sempre; ὅλος è salvus e εἷς μία ἕν è una volta per sempre… la molteplicità “filtra” dall’ εἷς μία ἕν nel πᾶς πᾶσα πᾶν con la “dialisi analitica dell’Uno” sì che tutta la molteplice pluralità ha nell’Uno quel “comun denominatore” attraverso di cui tutto passa: ἣ διὰ πάντων τούτων ἐστίν. «Ciò che è», τὸ ὄν, è «uno e intero», ἕν καὶ ὅλον, in quanto “affetto”, πάθος, dall’uno?
L’esser uno si predica dell’ὄν-ὅλον solo come una sua proprietà (πάθος) qualificata in riferimento alle sue parti; l’uno privo di parti è invece ciò che proprio di per sé è uno. In quanto è solo affetto dall’uno, l’ὄν-ὅλον non sarà identico ad esso. Che la distinzione tra i due tipi di uno sia basata dell’ὄν-ὅλον in ultima analisi sul fatto che il primo ha parti, l’altro ne è privo, non invalida la possibilità di vedere sullo sfondo l’assunzione che «se una cosa è semplice affezione di un’altra non può essere identica a quella cosa. [Platone: Sofista – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2008 – traduzione di Bruno Centrone – pag. 135, nota 100]
In ospedale Lui aveva visto alcuni casi di insufficienza renale cronica: i pazienti affetti da questa patologia “andavano in dialisi”, come si dice, cioè andavano a depurarsi il sangue secondo la voce del verbo διαλύω: dissolvere, sciogliere, dissociare, scomporre… quei pazienti non lo sapevano, che la sostanza della dialisi è un λύω che in latino è luo sia come sciogliere sia come liberare, pagare, scontare, subire, stornare… la dialisi è procedimento chimico-fisico che separa più sostanze disciolte in un liquido, e l’analisi è lo stesso procedimento, ma noetico-metafisico: ἀναλύω e διαλύω sono analisi e dialisi in quanto procedimento rispettivamente metafisico e fisico: l’analisi separa la sostanza “cattolica” dell’Uno andando verso la deduzione della molteplice realtà così come la dialisi separa la sostanza ematica del Sangue andando verso l’espulsione delle scorie che i reni non sono più in grado di far fuori.
«Un ospedale è icona del Purgatorio – pensava Lui – o, meglio, forse è il Purgatorio ad essere icona di un ospedale». Se, platonicamente, l’«immagine somigliante» è εἴδωλον εἰκών allora un sanatorio è, al di qua, τὸ εἴδωλον -ου di cui il Purgatorio è, al di là, ἡ εἰκών -όνος per cui ἡ ἰδέα è vedere, ἰδεῖν, l’aspetto, τὸ εἶδος, della salute sotto le speci della salvezza. Salus è sia idolo (= salute al di qua) sia icona (= salvezza al di là). Lui, lì, in ospedale, vedeva bene i due esiti della scienza medica: chi entra in ospedale o non ne esce più, perché, non guarendo, muore, oppure ne esce, perché, guarendo, se ne torna a casa; Lui lo vedeva bene, che da un ospedale se ne esce solo in due modi: o finendo all’obitorio o tornando a casa; e gli veniva in mente la “Casa del Padre”… Giovanni 14,2-4: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via», ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν· καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν, In domo Patris mei mansiones multae sunt; si quominus dixissem vobis: quia vado parare vobis locum. Et si abiero, et praeparavero vobis locum, iterum venio, et accipiam vos ad meipsum: ut ubi sum ego, et vos sitis. Et quo ego vado scitis, et viam scitis.
In una ‘casa di cura’ non ci si sente mai a casa propria, c’è poco da fare: ogni paziente vuol tornare a casa, cioè vuol guarire… la casa è simbolo di salute… forse per questo il Cristo ha chiamato “Casa del Padre” il luogo della salute eterna, della salvezza? ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου… In domo Patris mei… Lui rifletteva: «A pensarci bene, forse non è nemmeno un caso che, nel comune parlare, l’aggettivo ‘sano’ sia spesso unito all’aggettivo ‘salvo’ a formare il sintagma ‘sano e salvo’». Il concetto di salvezza è metafora bella del concetto di salute? Del resto, cattolicamente, il Purgatorio, nell’immaginario teologico, è uno stato provvisorio destinato a risolversi nel Paradiso… in un ospedale, invece, la risoluzione di una malattia non è necessariamente a lieto fine: la morte è la mancata guarigione di una mancata risoluzione… il problema della vita non è mai risolto, dalla medicina… la sconfitta della medicina è assoluta: alla fine la morte vince sempre. A Lui venne da pensare che, forse, gli uomini si erano inventati un Purgatorio con lieto fine d’ordinanza proprio per catartizzare, in qualche modo, il perenne finale tragico di una morte fuori ordinanza… la mors perpetua al di qua è stata “salvata” dalla vita aeterna al di là.
Ubi Ecclesia, ibi nulla mors… Extra Ecclesiam nulla salus… La salus cattolica è proiezione metafisica della salute fisica? La salvezza è cattolica perché è destinata a tutti: in Prima a Timoteo 2,4 san Paolo lo dice chiaramente, che Dio, nostro salvatore, «vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità», e in Giovanni 17,1-3 il Cristo così prega il Padre suo: «glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo». La Chiesa Universale è cattolica perché dà la salvezza a tutto il genere umano, e gratis. La Chiesa fa quello che la Medicina non può fare: non sarà che la potenza della Chiesa si fonda sull’impotenza della Medicina? – pensava Lui.
Lui, che era un insegnante non ancora di ruolo nonostante l’età ormai avanzata, patendo il precariato, pensava sempre che la precarietà della salute fisica diventasse in qualche modo “di ruolo” nella definitività della salvezza metafisica grazie al miracolo cristiano: al contratto a tempo determinato della Medicina ecco subentrare il contratto a tempo indeterminato della Grazia; una bella trovata, quella della Chiesa, perché riesce a immettere in ruolo, al di là, “pazienti” a cui nessuno concederebbe mai la grazia, al di qua. La salvezza è la salute… “di ruolo”! La grazia è il farmaco universale che può tutto: in questo ‘tutto’ Lui vedeva τὸ ὅλον, cioè «l’intero» che è «uno», secondo il dettato platonico:
«E certamente nulla impedisce che ciò che è diviso in parti sia affetto (πάθος) dall’esser uno proprio in riferimento alle parti nella loro totalità, e che appunto in questo modo, essendo tutto e intero, sia uno (πᾶν τε ὄν καὶ ὅλον ἕν εἶναι)». Lo ὅλον è uno in quanto unità delle sue parti; l’unica condizione affinché esso possa essere ὅλον è che sia «tutto intero». [Platone: Sofista – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2008 – a cura di Bruno Centrone – 245a – pag. 133]
Il «tutt’intero» è «tutt’uno»: πᾶν ὄν = ὅλον ἕν. «Salute e Salvezza sono tutt’uno – pensava Lui –, la Salvezza è la salus perpetua che il Requiem aeternam chiama lux perpetua». Requiem aeternam dona ei (eis), Domine, et lux perpetua luceat ei (eis). Requiescat (-ant) in pace. Amen. La grazia di Dio è la medicina che procura la salute eterna. «Tutti i medici vorrebbero questo farmaco universale – pensava Lui – ma al di qua non esiste, sicché tale pio desiderio è stato messo in cielo, affinché possa scendere de sideribus, visto che non può salire de terra». «Il mio regno non è di questo mondo», disse Cristo a Pilato. La farmacologia si occupa di salute della vita biologica e la teologia di salvezza della vita ontologica.
La vocazione della Medicina è l’universalità, ad onta delle varie e molteplici branche di specializzazioni che necessariamente si presentano come tentativi di arrecare la salute almeno in qualche specialità. Lui, girando per l’ospedale, vedeva i vari reparti: Istologia e Anatomia patologica, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia, Ematologia, Gastroenterologia, Geriatria, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Pronto Soccorso, Radiologia, Urologia… Una struttura sanitaria è composta da reparti: la molteplicità delle specialità procede dall’ εἷς μία ἕν nel πᾶς πᾶσα πᾶν come in Platone il divenire filtra dal πᾶν ὄν nel diapason del διὰ πάντων che fa diventare l’Essere una pluralità di esseri. In ultima analisi, tutti i reparti ospedalieri, immaginati come un tutt’uno, sono quell’ ὅλον che “cattolicamente” garantisce la salvezza.
Lui si era appisolato un attimo su una delle panche che si trovavano davanti all’obitorio: il dialogo con Lei l’aveva prostrato e ora si godeva un meritato riposo. Sognava…
Un ‘Intero’… un “intero medico”: tutte le specialità mediche riunite in un una sola facoltà, ma non facoltà intesa come facoltà universitaria, bensì come capacità di fare qualcosa: capacità di guarire tutte le malattie. Oh! Il medico tuttologo si è laureato all’Università “Cattolica”! «Piacere, mi chiamo Lui. Scusi, ma Lei è religioso?». «No». «E allora come fa a essere tuttologo?». «Non sono religioso ma sono, clinicamente, cattolico». «?».
«Clinico»: dal lat. clinĭcus, gr. κλινικός, der. di κλίνη «letto». Il medico tuttologo era morto, anzi, non era mai nato: stava steso su un catafalco dell’Università Cattolica posto volutamente all’entrata per simboleggiare la vanità della salute umana; era clinicamente… inclinato, come i morti nel cimitero sono morti perché «cimitero» viene dal lat. tardo coemeterium, gr. κοιμητήριον «dormitorio», der. di κοιμάω «mettere a giacere». Il tuttologo era incline alla salute eterna, per questo, alla “Cattolica”, avevano declinato la sua vocazione ad una κλίνη clinicamente morta.
Un ‘Intero’… un “intero medico”: tutte le specialità mediche riunite in un una sola facoltà… πᾶς (= tutto) πᾶσα (= tutta) πᾶν (= tutto) & ἀκέομαι (= guarisco) ἀκέω (= guarisco) ἀκή (= guarigione)… pas, pàsa, pan, achèomai, achèo, achè… pan, pan, pan… achèo, acèo, acèa… pan… acea… PANACEA! Ecco cos’è la guarigione cattolica! La salvezza è una panacea! È il rimedio universale che guarisce tutto ciò che i farmaci non possono guarire! Il farmaco universale, il farmaco cattolico…
Πανάκεια era figlia di Asclepio ed Epione, Esculapio e Lampezia… Epion è la ninfa “che allevia il dolore”… Ἀσκληπιός è il dio della medicina… La medicina copula con la morfina e genera colei che può guarire tutte le malattie: la Salute… Invece la Salvezza nasce per opera dello Spirito Santo da una Vergine che non “conosce” uomo… Luca 1,34-35: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra….
Socrate: «Allora dimmi questo, Menone: quello per cui non differiscono affatto (le medicine), ma per cui sono tutte la stessa cosa (la panacea), che cosa dici che sia?». Lui: «La Salute della Salvezza!». La virtù terapeutica… Menone: «Socrate, sai dirmi: la virtù s’insegna? Oppure non s’insegna…». Luca: «Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte…». Socrate: «Straniero, rischio di sembrarti un essere beato – uno che sa se la virtù è insegnabile…».
La Salvezza è la panacea dell’ ὅλον, la virtù terapeutica universale…
Paolo: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni… Socrate: «Così pure a proposito delle virtù: anche se sono molte e di vario tipo, possiedono tutte una qualche forma unica e identica grazie alla quale sono virtù, guardando alla quale è agevole per chi risponde mostrare a chi interroga che cosa sia la virtù. Capisci, no, cosa intendo?» «…la stessa cosa vale anche a proposito della salute… ti sembra che una sia la salute dell’uomo, e un’altra della donna? o non ti sembra piuttosto che si tratti in tutti i casi della stessa forma, qualora sia salute, che si trovi in un uomo o in chiunque altro?…».
La Salvezza è il pleroma della Salute… Paolo: «È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di lui…». Socrate: «…quell’unica che passa attraverso tutte…». Τὸ πλήρωμα… πληρόω: porto a compimento… rendo perfetto… sacrificio perfetto a te gradito… «Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo». Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito… εἶπεν· Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
Pleroma… πληρόω: porto a compimento… τελέω: compio, porto a termine, muoio… «dixit: Consummatum est. Et inclinato capite tradidit spiritum»… τελέω… consummo… la medicina perfetta è il sacrificio perfetto… perfetto è completo: tutt’intero. La morte porta a compimento… il compimento della salute è la morte!? Al di qua no, al di la sì… Ohhh!!! Vedo un morto che completa la sua salute finta al di qua in una salvezza infinita al di là… gratifica: «compenso straordinario in denaro, oltre lo stipendio pattuito, come premio per il buon rendimento, per condotta lodevole, o in speciali occasioni». Gesù: «…senza di me non potete far nulla…». Salmo 127: «Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori….». Ohhh!!! Vedo un ospedale che reca la scritta: “Se la panacea non costruisce la Medicina, invano si affaticano i medici”.
Dormiva, sognava, e nel mentre cominciava a svegliarsi, Lui. La vida es sueño… To die, to sleep. To sleep, perchance to dream… ’tis a consummation: consummatum est!
Si svegliò tutto stordito, come uno che sia stato rapito e travolto dalla platonica “mania poetica”, oppure dalla “mania mantica”… Si svegliò con Parmenide in testa: non riusciva a toglierselo dalla testa. Il Tutto è uno: ἕν τὸ πᾶν. Il molteplice non esiste: μή ἐστι πολλά. Una specie di timor panico si impossessò di Lui: davanti a sé non vedeva che reparti ospedalieri, eppure Parmenide diceva che il tutto è uno… «il reparto è una parte, lo dice la parola stessa – pensava – l’ospedale è un tutto diviso in reparti, come la Medicina». La salvezza è un reparto della Salute? La Salvezza è il facsimile della Salute? Verosimile?
Chiese qualcosa per il mal di testa a un dottore che passava di lì: gli diede un Moment, che per caso aveva in tasca. La Salvezza gli sembrava dissomigliante dalla Salute… «forse ha ragione Platone – pensava –, c’è un’Idea di Somiglianza e c’è un’Idea, ad essa opposta, di Dissomiglianza… ma se la Salute è tutto… la Salute non può partecipare della natura del dissimile, perché sennò il dissimile sarebbe Malattia… Quando c’è la salute c’è tutto… allora è la Salute, non la Salvezza, il πᾶν ὄν cattolico… il vero panismo ontologico è quello della Salute».
Il miraggio della Totalità, das Ganze… A Lui venne in mente che
Le differenze rientrano, per Hegel, nella categoria di numerabilità dell’ordinato come Gestalt del Dasein; se l’universale è la vita, das Leben, la natura organica cade in die Einzelheit des Daseins, nella singolarità della esistenza. Il dettaglio, il particolare, die Einzelheit, è tale come das Einzel, il singolo, che è dettaglio del tutto, ma come dettaglio per sé è la morte della vita del Tutto: ist für sich, è per sé, e quindi non è per sé come tutto, es nicht als Ganzes hier für sich ist. [Davide Cantino: Rotazione e Rivoluzione]
Cos’hanno “combinato”, Adamo ed Eva?
Adamo ed Eva hanno “combinato” semplicemente questo: hanno ‘scombinato’ l’ordine universale decidendo di volerlo conoscere discorsivamente, sì che questo ha cominciato ad apparire frammentato nei due pezzi, Teile, che l’Urteil ha cercato di riunire. Crimen viene da cerno, il cui participio passato, cretus, è la cernita indiscreta del discreto; cerno è κρίνω, io giudico, ich urteile, da qui la “crisi” di Adamo ed Eva: essi decisero, sie urteilen, di conoscere sub specie decisionis e questo fu il “crimine” che li fece decedere, cioè dipartire dall’universale, donde il loro decesso nel singolare: «e allora l’autonomia diviene crimine», scrive Hegel [Phänomenologie: pag. 423]. [Davide Cantino: Rotazione e Rivoluzione]
Da quando aveva aperto il dizionario di greco e aveva letto, alla voce ὅλος, cf. lat. salvus, Lui si era sempre più convinto che quella del cattolicesimo era una mania veramente ossesionante: solo ciò che è Tutto-Intero è fonte di salvezza, e non solo in senso religioso. Ci si mette anche la filosofia, a predicare il Tutto-Intero!
Anche la sinapsi, venendo dal gr. σύναψις «collegamento», der. di συνάπτω «congiungere» (comp. di σύν «con» e ἅπτω «unire»), sembra dire che tutto tende, in natura, all’Intero, tramite contatti reciproci e sussunzione sotto un gran denominatore concettuale. Lui, grande ammiratore di Immanuel Kant, aveva sempre riflettuto sul fatto che la conoscenza si ha nella misura in cui si ha la com-prensione, cioè il ‘prendere insieme’ del concipio, is, cepi, ceptum, ere: il ‘concetto’ viene dal participio passato di un verbo che significa «prendere insieme», cioè, appunto, comprendere. Basta aprire la Critica della ragion pura all’inizio dell’Analitica trascendentale per vedere quanto la tendenza sinaptica contribuisca alla conoscenza scientifica già “raccomandata” dalla Metafisica di Aristotele:
«Ora, questa compiutezza di una scienza non può essere accreditata fiduciosamente sulla scorta della considerazione approssimativa d’un aggregato, frutto di semplici tentativi; essa è quindi possibile solo mediante un’idea della totalità della conoscenza intellettuale a priori e attraverso la suddivisione dei concetti che la costituiscono, stabilita in base a questa idea; cioè solo mediante la concatenazione unitaria e sistematica di questi concetti» [Kant: Critica della ragion pura – UTET Libreria, Torino 2005 – a cura di Pietro Chiodi – pag. 135].
Lo stesso Kant, poche righe dopo, scrisse che «l’intelletto puro … è un’unità per se stante» e, qualche pagina dopo, che «non esiste altro modo di conoscere se non per concetti». Trattando poi della Deduzione trascendentale dei concetti puri dell’intelletto, Kant scrisse che «la congiunzione (conjunctio) di un molteplice in generale non può mai provenirci dai sensi», «è un’operazione dell’intelletto, che possiamo indicare con la designazione generale di sintesi»; la conjunctio kantiana ha la stessa vocazione della σύναψις: «congiunzione è la rappresentazione dell’unità sintetica del moltelice». Il famoso ‘Io penso’ di Kant, Ich denke, fornisce «l’unità trascendentale dell’autocoscienza»: cioè, in soldoni, se la poliedrica e multiforme molteplicità, che ‘io’ percepisco con i sensi, non diventasse, nel mio stesso ‘Io (penso)’, un’immagine unica e compatta, che collega i vari tasselli del puzzle fenomenico, ‘io’ non potrei mai avere conoscenza di ciò che esperisco sensorialmente; la conoscenza è com-prensione in quanto col-legamento secondo la voce del verbo concipere, che poi è il tedesco begreifen: comprendere grazie al conceptum del Begriff. La Critica della ragion pura è un grande inno alla sinapsi gnoseologica: «il principio dell’unità sintetica dell’appercezione è il principio supremo di ogni uso dell’intelletto»; com-prendere è con-cepire. Quello che noi percepiamo con i sensi, nella cosiddetta “intuizione” (sensibile) è un oggetto,
«Ma oggetto è ciò nel cui concetto è unificato il molteplice di una data intuizione. Ogni unificazione delle rappresentazioni implica perciò l’unità della coscienza nella sintesi di esse. Ne deriva che l’unità della coscienza è ciò per cui solamente ha luogo la relazione delle rappresentazioni a un oggetto, quindi la loro validità oggettiva; dunque ciò che fa sì che divengano conoscenze e su cui poggia la possibilità stessa dell’intelletto». [Kant: Critica della ragion pura – UTET Libreria, Torino 2005 – a cura di Pietro Chiodi – pag. 165].
«L’unità trascendentale dell’appercezione è quella in virtù della quale tutto il molteplice dato in una intuizione è unificato in un concetto dell’oggetto». Eccetera, eccetera.
«Chissà, – pensava Lui –, chissà se questa vocazione all’Unità, ineludibile per la com-prensione gnoseologica, abbia anche qualche risvolto ontologico?». E gli veniva in mente la cosiddetta ‘preghiera sacerdotale’ del Cristo in Giovanni 17,21 quella in cui il Figlio prega «perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi»:
καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί,
ut omnes unum sint,
sicut tu, Pater, in me et ego in te,
ut et ipsi in nobis unum sint.
Lui aveva scritto un motto, per significare questo concetto: qui manet in Filio permanet in Patre. Lui lo chiamava l’imperativo ontologico dell’ in esto, siate ‘in’, volendo con ciò significare che l’innesto “comandato” nella parabola della vite e dei tralci era l’innesto sacramentale di omnes tum in Filio ac deinde in Patre…
Giovanni 15,4-6: «Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano». Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potest fere fructum a semetipso, nisi manserit in vite, sic nec vos, nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere. Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet.
La ‘Buona Novella’ non perde mai l’occasione per minacciare l’Inferno – pensava Lui: «Ma guarda un po’, ‘sto vangelo, proprio sul più bello dell’idillio sinaptico dell’in esto, ti tira fuori il fuoco… il Cristo fa tanto l’agnellino, ma poi, quando s’incazza con chi non rimane in Lui, subito fa la voce grossa di Matteo 25,41: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli”… Discedite a me maledicti in ignem aeternum, qui paratus est diabolo, et angelis ejus, Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ».
A Lui pareva che i preti avrebbero avuto un mucchio di argomenti affascinanti, se solo avessero voluto e saputo fare un catechismo poco poco “colto”; per esempio, questa storia dell’unità, gnoseologica ed ontologica, come requisito fondamentale della ‘com-prensione’ da una parte e della ‘com-unione’ dall’altro, a Lui pareva un argomento con cui si sarebbero potuti affascinare un mucchio di giovani. Invece niente: i preti se ne stavano rannicchiati nella piccola cuccia del loro catechismo parrocchiale, fatto da volenterosi ma umili volontari spesso senza alcuna cognizione, né filosofica né teologica!
Proprio mentre Lui pensava queste cose, passò di lì un Tizio, di quelli che vanno a Messa ma non fanno la comunione perché non ritengono che fare la comunione sia necessario; uno di quelli che vanno a Messa ma poi non credono alla risurrezione e a tanti altri articoli di fede che per il cristianesimo sono dogmi: insomma, uno di quei tanti ignoranti che spacciano buon senso a buon mercato, che fanno i cristiani senza sapere nulla del Cristo che dovrebbero seguire. L’aveva sentito – Lui – dire a una signora: «Se Dio vuole uscirò da questo ospedale tra tre giorni; mi ha protetto, il Signore… Domenica gli accenderò tre candele… sempre che, se Dio vuole, io riesca ad uscire di qui». Era tutta una sfilza di “se Dio vuole”, ma poi, quando la sua interlocutrice parlò di comunione, quel Tizio cominciò a preferire le candele e tutto il suo stupido corredo di bigotterie infondate. Lui non ci vide più e lo arringò:
LUI: E così, lei va a Messa senza fare la comunione?
TIZIO: …sì… ma… ah! lei mi ha sentito, quando parlavo con la signora…
LUI: …certo, che ho sentito, e mi chiedo cosa vada a fare, lei, a Messa, se poi non fa la comunione.
TIZIO: Perché, lei la fa, la comunione?
LUI: No, perché io a Messa non ci vado.
TIZIO: Oh, lei non va a Messa… e perché, allora, si stupisce tanto di me? Io, a Messa, almeno, ci vado.
LUI: Non solo mi stupisco, ma mi incazzo anche, perché lei è come uno che accetta un invito a pranzo, si siede al tavolo, e poi non mangia.
TIZIO: E cosa gliene frega, scusi, a lei, se io non mangio?
LUI: Me ne frega eccome… io non me ne frego mai, quando vedo Qualcuno che compie un gesto senza conoscerne il significato.
TIZIO: Che gesto?
LUI: Andare Messa.
TIZIO: E che significato avrebbe, secondo lei, andare a messa?
LUI: No, guardi, non è “secondo me”, questo significato; vede, che lei non conosce il significato oggettivo dell’andare a Messa?
TIZIO: Oggettivo?
LUI: Conosce la differenza tra “oggettivo” e “soggettivo”?
TIZIO: Lei ha del tempo da perdere…
LUI: …invece lei ha delle candele da trovare?
TIZIO: Ma mi faccia il piacere!
LUI: Dica, che piacere vuole che le faccia?
TIZIO: Si tolga dai piedi!
LUI: Non prima di aver sentito da lei cos’è una Messa.
TIZIO: Mi interroga come se fossi uno studente?
LUI: La interrogo come se fosse un ignorante.
TIZIO: Io?
LUI: Allora me lo dica: cos’è, per lei, la Messa?
TIZIO: È un’occasione per stare con gli altri, la Domenica, nella casa di Dio.
LUI: Uh, stare insieme? La Domenica? Nella casa di Dio?
TIZIO: Sì. E per lei, cos’è, la messa?
LUI: È il rito con cui si celebra il sacrificio del corpo e sangue di Gesù Cristo, sotto le speci del pane e del vino; è il memoriale della sua passione e morte.
TIZIO: Ma bravo, bene! e allora?
LUI: E allora andare a Messa senza mangiare il corpo e sangue di Cristo è non aver capito niente del suo sacrificio. Giovanni 6,53: Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita».
TIZIO: Ma chi è lei? un prete? che cita il vangelo a memoria?
LUI: E chi è lei? un cristiano? che va a Messa senza sapere cosa ci va a fare?
TIZIO: Non mi rompa i coglioni, guardi, io ho da fare…
LUI: …già: vada, vada a fare le sue cose!
TIZIO: Vaffan…!
Il cappellano dell’ospedale aveva sentito l’ultima parte del dialogo e, stupito, si rivolse a Lui dicendo:
CAPPELLANO: Figliolo, lei è un cristiano convinto… ed anche preparato… mi pare.
LUI: No, si sbaglia: io non ho nemmeno la fede.
CAPPELLANO: Ma no, com’è possibile? figliolo, io ho sentito, cosa diceva a quel Tizio…
LUI: È solo una questione di onestà intellettuale: non mi piacciono quelli che agiscono senza sapere ciò che fanno.
CAPPELLANO: Ma lei ha detto cose giuste, lei ha fatto una vera e propria lezione di catechismo, a quel Tizio.
LUI: Non è necessario credere, per fare un po’ di catechismo: basta studiare.
CAPPELLANO: Certo, certo, lo so: ma in Giovanni 17,3 il Cristo dice: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo»; giovanotto, lei potrebbe utilmente fare un po’ di catechismo, anche qui, con me, in ospedale… lei potrebbe fare in modo che Qualcuno conosca l’unico vero dio… poi, per quel che riguarda la fede, vedrà: l’appetito vien mangiando… vedrà che imparerà ad amare ciò che insegna…
Lui preferì non rispondere, a quella frase preconciliare… il cappellano predicava l’habitus di Tommaso d’Aquino: l’habitus cattolico non è un accidente che comporta un possesso (habere) esteriore (il famoso vestito, ad esempio “Socrate indossa la tunica”) ma, piuttosto, esso dà un possesso interiore (se habere) che diventa un modo d’essere, una disposizione del soggetto. Lui però aveva sempre pensato che l’abito non fa il monaco, e per questo preferì tagliar corto.
Si allontanò dal cappellano con Parmenide in testa: questo, gli interessava. Stava leggendo il Parmenide di Platone e non gli passava altro, per la testa. Pensava al concetto platonico di “partecipazione”, quella μέθεξις che è sostantivazione del verbo μετέχω. A dire il vero, Platone usa anche il verbo μεταλαμβάνω nel senso di ottenere, avere parte… a Lui venne in mente Giovanni 13,8 quando Pietro non vuole lasciarsi lavare i piedi dal Signore e questi allora gli dice: «Se non ti laverò, non avrai parte con me», οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ, Si non lavero te, non habebis partem mecum. In greco τὸ μέρος è «la parte» e μείρομαι è «dividere». La Moira è il destino perché è la “parte” che ci capita in sorte: “moire” sono le parti multiformi e cangianti del divenire fenomenico procedente dall’Uno. Avere parte è condividere: la comunione cattolica.
Nel Parmenide di Platone c’è un’ipotesi – peraltro subito abbandonata – che secondo Lui sembrava annunziare e lasciar presagire l’unità sintetica di Kant:
«A meno che, Parmenide, – obiettò Socrate – ciascuna delle Idee non sia un pensiero (νόημα) e non possa nascere in nessun altro luogo se non nelle nostre anime; così infatti sarebbe una e singola e non potrebbe subire più le difficoltà che prima erano poste». [Platone: Parmenide – Rusconi, Milano 1994 – a cura di Giovanni Reale – 132 b – pag. 73]
Nel verde di Platone, Lui evidenziava τὸ νόημα, «l’oggetto del pensiero», vocabolo illustre che rima con ἡ νόησις, «il pensare» e con νοέω, l’azione compiuta da ὁ νόος, «la mente». E se l’Idea platonica fosse un noema, un concetto puro dell’intelletto, alla Kant?
«In questo modo sono possibili giudizi sintetici a priori, allorché noi riferiamo le condizioni formali dell’intuizione a priori, la sintesi della facoltà di immaginazione e la sua unità necessaria in un’appercezione trascendentale, ad una possibile conoscenza empirica in generale; e affermiamo: le condizioni della possibilità dell’esperienza in generale sono al tempo stesso condizioni della possibilità degli oggetti dell’esperienza, e possiedono quindi validità oggettiva in un giudizio sintetico a priori». [Immanuel Kant: Critica della ragion pura – Bompiani, Milano 2004 – a cura di Costantino Esposito – pag. 327]
L’Idea platonica è il transcendens che trascende la realtà non perché si trova al di là, ma perché è al di qua: nel νόος umano – pensava Lui. Le Idee platoniche sono trascendenti, non trascendentali. L’unità sintetica del molteplice delle intuizioni teorizzata da Kant è die Einheit, synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Anschauungen.
«La Salvezza è un’idea trascendente della ragione (= die Vernunft), di cui la Salute è il concetto trascendentale dell’intelletto (= der Verstand)» – pensava Lui. Ma Platone diceva che «le Idee (τὰ εἴδη) stanno nella realtà come modelli (παραδείγματα) e gli altri oggetti assomigliano (ἐοικέναι) ad esse e sono copie (ὁμοιώματα). La partecipazione (ἡ μέθεξις) alle Idee delle altre cose non consiste in altro che nell’essere fatte a immagine (εἰκασθῆναι) di quelle». Lui non potè non pensare a Genesi 1,26: «Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza», καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, et ait: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram.
E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò
A Lui pareva incredibile: la Bibbia usava esattamente i due vocaboli usati da Platone in Parmenide 132 [d].
- ἡ εἰκών imago
- τὸ ὁμοίωμα similitudo
Bisogna però anche dire che la traduzione in greco, della bibbia, di cui Lui si serviva era quella cosiddetta dei Settanta, la quale fu commissionata da Tolomeo Filadelfo, che fu re dal 285 al 247 a.C., ora, se si pensa che il Parmenide di Platone fu scritto all’incirca tra il 368 e il 361 a.C. si può anche pensare che i 72 traduttori venuti da Gerusalemme ad Alessandria d’Egitto per invito del re Tolomeo si siano lasciati influenzare dalla terminologia platonica… chissà!
Mentre pensava a queste cose, Lui capitò davanti al reparto di cardiologia: il cuore… il cuore della legge… amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore… Matteo 22,36-38: Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento…».
Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua.
- ἡ καρδία cor, cordis
- ἡ ψυχή anima, animae
- ἡ διάνοια mens, mentis
In cardiologia Lui vedeva solo gente che amava il proprio cuore, non Dio. I chirurghi si compiacevano della loro manualità, peraltro insita nel loro nome, ἡ χειρουργία = χείρ + ἔργον, opera delle mani, e operavano i loro prodigi di “manodopera”. Lui pensava al cuore, alla sua sistole [dal gr. συστολή «contrazione», der. di συστέλλω «restringere, contrarre»] e alla sua diastole [dal gr. διαστολή «dilatazione», der. di διαστέλλω «disunire, dilatare»]; la contrazione e la dilatazione del miocardio gli ricordavano tanto il pulsare ontologico dell’Uno: «L’Uno, dunque, a quel che sembra, prendendo e abbandonando l’Essere nasce e perisce»,
Poiché è uno e molti, e poiché nasce e perisce, non è forse che quando nasce l’Uno perisce l’essere molti, quando nascono i molti perisce l’essere Uno? [Platone: Parmenide – Rusconi, Milano 1994 – a cura di Giovanni Reale – 156 b – pag. 183]
L’alternarsi continuo di γίγνηται (= nasce) & ἀπόλλυται (= muore) scandiva il fieri del divenire nella “circolazione” ontologica di
- τὸ πολλὰ εἶναι l’essere molti
- τὸ ἓν εἶναι l’essere uno
e i due verbi preposti all’alternanza di essere uno / essere molti sono dividere, διακρίνω, e unificare, συγκρίνω. «L’Essere non va mai in blocco cardiaco? – si chiedeva Lui – Non va mai in standby?». Uno / Molti / Uno / Molti… Sistole / Diastole / Sistole / Diastole…
Giovanni 12,25 usa lo stesso verbo che Platone usa per significare il morire dell’Uno all’uno per diventare Molti: ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. Il verbo ἀπόλλυμι, come ὄλλυμι, è assai poco “apollineo”: significa morte e distruzione. A Lui questa girandola platonica di sistole e diastole ontologica ricordava il gioco delle forze, das Spiel der Kräfte, di Hegel:
«…una volta poste come autonome, le differenze passano immediatamente nella loro unità, la loro unità immediatamente nel dispiegamento, e questo a sua volta ritorna nella riduzione. Ora, un tale movimento si chiama forza». [Hegel: Fenomenologia dello Spirito – Bompiani, Milano 2000 – a cura di Vincenzo Cicero – pag. 215]
È uno scambio reciproco, il gioco delle forze, «scambio assoluto e immediato delle determinazioni», e
«Mentre così noi manteniamo entrambi i momenti nella loro unità immediata, l’intelletto, al quale appartiene il concetto della forza, è propriamente il Concetto che sostiene i momenti differenti appunto come differenti. Nella forza stessa, infatti, i momenti non sono affatto differenti: la differenza cade soltanto nel pensiero». [Hegel: Fenomenologia dello Spirito – Bompiani, Milano 2000 – a cura di Vincenzo Cicero – pag. 215]
Il Concetto, der Begriff, è l’unione che l’Intelletto, der Verstand, compie nel Pensiero, im Gedanken. «Quella di Hegel è fenomenologia dello Spirito, quella di Platone è fenomenologia dell’Essere-Uno – così pensava, Lui – ma in fondo è lo stesso sforzo filosofico: il tentativo di “farsi una ragione” della coesistenza di unità e molteplicità nell’essere. «…quando passa dall’Uno ai molti e dai molti all’Uno, non è né uno né molti, né si divide né si riunifica», scrisse Platone in Parmenide 157 [a]: il non essere fa capolino nell’istante in cui uno non è più uno e non è ancora molti:
«L’istante. In verità questo sembra il significato della parola “istante”: ciò da cui partono i cambiamenti nelle due opposte direzioni. Non è infatti dall’immobilità ancora immobile, né dal movimento ancora in moto, che c’è il mutamento; ma è questo istante dalla straordinaria natura, posto in mezzo (μεταξύ) tra movimento e immobilità, e che non è in alcun tempo, ciò verso il quale e dal quale quanto si muove muta nella quiete e quanto è fermo muta nel movimento». [Platone: Parmenide – Rusconi, Milano 1994 – a cura di Giovanni Reale – 156 d,e – pag. 185]
«L’istante», τὸ ἐξαίφνης, è ciò che «all’istante», ἐξ + αἴφνης, subito, αἶψα, vale a dire quel frattempo nel cui frattempo, μετά + ξύν, le due forze in gioco, Uno e Molti, si scambiano il loro stans: in + stante, seduta stante. Anche nello Zarathustra di Nietzsche l’istante è l’attimo in cui tempo ed eternità trapassano l’uno nell’altra. Frattanto, mentre Lui pensava all’istante, immantinente un altro paziente trapassò: il suo cuore si era fermato. E Lui pensava:
Tra la vita al di qua e la vita al di là, ci sarà un istante in cui, come in una zona franca, uno possa godersi la libertà di non essere né al di qua né al di là? Un istante in cui l’al di là non è ancora e l’al di qua non è più…
L’istante è il tempo di Nessuno. È il momento senza tempo in cui Qualcuno non è più, in cui Tutti non sono ancora. L’istante è il non-tempo frapposto nel mentre che uno non è più Qualc-uno e non è ancora Nes-suno. L’istante avviene intanto che il tempo è spirato e l’eternità non respira ancora.
È quello il momento in cui bisogna evadere: lì Lui non ci vede, quello è l’unico istante in cui Lui ci perde di vista; bisogna sfuggirgli mentre siamo in quell’istante, se ci riusciamo, la nostra anima è salva: non più in vita al di qua e non è ancora in vita al di là. La sospensione dell’essere forse è in quell’istante: l’istante del trapasso, l’attimo della mutazione ontologica. È in quell’attimo che noi possiamo, forse, impedire al ‘non essere ancora’ di diventare ‘essere per sempre’: forse è lì, il nonessere, nell’istante in cui il per sempre non è ancora e l’essere non è più.
Nel non-essere-più del tempo Qualcuno può diventare finalmente Nessuno? L’istante del nonessere forse è la zona d’ombra in cui non siamo più ‘in noi’ e non siamo ancora ‘in Lui’: in quel momento l’anima non è più nel corpo e non è ancora nello spirito. Forse, la libertà di non essere sta nella capacità di evitare lo spirito dopo aver perso il corpo? L’anima è braccata tra spirito e corpo, esce dall’uno per entrare nell’altro: lo spirito è pericoloso, perché fa riprendere il corpo! Se uno evita lo spirito la sua anima se ne resta senza corpo nel nulla del nonessere.
È nell’istante, che uno esce dall’al di qua dei Molti per entrare nell’al di là dell’Uno, dove Lui è Tutto. L’Uno è l’al di là dei Molti e i Molti sono l’al di qua dell’Uno. L’istante è la zona di confine sulla cui linea nessuno ha giurisdizione, la linea di confine è la linea di demarcazione che fa da frontiera tra i due regni che si spartiscono l’essere umano: l’al di qua e l’al di là. L’istante è terra di Nessuno: lì ‘nessuno comanda’ perché ‘Nessuno non comanda’. Lì uno la fa franca, perché quella è zona franca. Il totalitarismo del nonessere è anarchia, quello dell’essere è dittatura. Al di qua il carcere della vita terrena, al di là quello della vita celeste: è nell’istante in cui passiamo da un carcere all’altro, che forse possiamo evadere; evadere restando ben nascosti, dove le guardie carcerarie dell’al di qua non possono più nulla e quelle dell’al di là non possono ancora niente.
Quella è la vera cella di sicurezza: quella in cui il controllo della polizia penitenziaria è nullo; solo nel nulla atemporale dell’istante uno può ridurre al niente la vigilanza ferrea delle guardie ontologiche. È nell’istante del trapasso, che angeli e demoni si contendono la proprietà della nostra anima: il contenzioso avviene “in coscienza”, ma solo l’incoscienza del nonessere salva dal procedimento giudiziario che Lui vuole avviare: il rischio di finire sotto le grinfie del suo codice penale basta per giustificare la volontà di latitare nel nonessere. Nel nonessere stanno i latitanti, quelli che sono riusciti a sottrarsi alla giustizia divina.
Lui era decisamente sovrappensiero… Quando pensò che Nessuno latita, gli venne in mente l’etimologia heideggeriana di verità: ciò che non si nasconde, ciò che non latita; finalmente ebbe chiaro in cosa consiste la falsità del nonessere: nel reato della latitanza dall’essere. Siccome solo nell’istante del nonessere l’Essere perde il controllo sull’essere umano, Lui non vuole che Qualcuno si nasconda nel nonessere per sfuggire la sua giustizia divina e istituisce il reato della falsità come latitanza da Lui.
La vita è solo l’avviso di garanzia che Lui spicca per avvisare gli esseri umani che sono in corso delle indagini preliminari per raccogliere elementi utili a una loro eventuale imputazione: la responsabilità penale della vita, ogni essere umano se la gioca nel Giudizio Universale, in cui Lui tira le somme per la sentenza finale, dopo la quale nessun ricorso sarà più possibile in appello. Dalla vita intrauterina si deve uscire per forza, per entrare nella vita, ma dall’istante che si esce dalla vita forse si può non entrare nell’utero di Dio: la vita eterna. Dall’utero materno se ne esce vivi, e se non se ne esce, è perché si muore; l’aborto è appunto questo. Ma se aborior, aboreris, abortus sum, aboriri è morire e orior, oreris, ortus sum, oriri è nascere, ci sarà pure un hortus, magari, conclusus, in cui concludere la clausura ontologica!? E se l’istante del nonessere fosse tale hortus, hortus in quo Nemo ortus est.
Lui andava decisamente fiero, di questo suo ultimo parto latino: hortus in quo nemo ortus est. Intraducibile, in italiano, perché l’orto italiano non è quello in cui uno è s-orto, mentre l’hortus latino può essere quello in cui uno ‘è’ o ‘non è’ ortus (= nato). E allora, visto che aveva fatto trenta, Lui fece trentuno, e disse:
hortus in quo nemo ortus est, instans
e vide che ciò era buono. Meno buono era il fatto che in latino instans, antis avesse anche il significato di «incerto»; certo, Lui poteva aspettarselo, da instans, che fosse ‘incerto’, visto che esso è per definizione «instabile», come participio presente del verbo insto: in-sisto. L’istante incombe minaccioso, minaccioso per la stabilità epistemica dell’essere, che lo evita come il diavolo l’acqua santa. L’in-stans è «l’attimo che sta (= stans) in mezzo (= in)» tra questa vita e l’altra vita. «Se Platone avesse calcolato bene le conseguenze delle sue affermazioni su τὸ ἐξαίφνης credo che non ne avrebbe parlato proprio», pensava Lui.
In effetti, τὸ ἐξαίφνης è il classico «tempo morto», e, ontologicamente, non è certo bello, che il tempo sia morto: τὸ ἐξαίφνης è l’abortus sum (= sono morto) che non ha ancora avuto il tempo di pronunciare i natali celesti dell’ortus sum (= sono nato). La vita nasce nel dies natalis ma tale dies può essere ortus al di qua oppure ortus al di là: nell’«hortus del nonessere» si rimane se si riesce a evitare l’«ortus dell’essere». È interessante leggere la definizione di ‘tempo morto’ in fisica: è il tempo che impiega un certo apparato di misura, dopo aver ricevuto uno stimolo esterno, per essere pronto ad eseguire correttamente una nuova misura; per analogia, si può pensare al tempo che impiega un flash a ricaricarsi dopo lo scatto di una foto.
Lui pensava che τὸ ἐξαίφνης fosse, in un certo senso, la défaillance dell’εἶναι, l’état de ce qui fait défaut: lo condizione di ciò che fa difetto, al nonessere fa difetto l’essere. Ecco perché, per l’Essere, essere in difetto è aver commesso una mancanza: perché ogni mancanza di essere è difetto come colpa; per l’Essere è una pecca, essere senza essere: chi manca di essere manca contro l’Essere e questo è il suo peccato. La più grave mancanza è mancanza di essere, e ogni mancanza contro di esso è mancanza contro l’Essere.
Ma chi, «manca di essere»? Qual è l’«essere mancato» per eccellenza? – si chiedeva Lui – e rispose: «colui che non è (ancora) nato». Dopo aver dato questa risposta geniale, Lui pensò: ma, se il cristianismo ha ragione, ci sono due modi di non essere (ancora) nato:
- Non essere ancora nato alla vita al di qua
- Non essere ancora nato alla vita al di là
Quindi, ci sono solo due modi per non essere: o non nascere al di qua, o non nascere al di là. Per non nascere al di qua ci vuole una coppia che decida di non avere figli, per non nascere al di là ci vuole un istante in cui poter decidere di non nascere al di là (se questo istante esiste e se in esso è possibile decidere di non essere più). Lui si arrabbia sempre moltissimo, quando Qualcuno decide di rinunciare ad essere, perché, a suo modo di vedere, rinunciare ad essere è rinunciare all’Essere, cioè a Lui. I preti dicono che amare è accettare di essere e quindi accettare l’Essere, ma Lui non la pensava come Lui, cioè come loro, come i preti. A Lui non fa certo difetto, l’essere, e quindi, per Lui, chiunque sia in difetto di essere è, appunto, in difetto: colpevole. Lui vuole che tutti siano come Lui: che tutti siano, cioè. L’imitazione di Cristo è l’imitazione dell’Essere. Matteo 5,48: «Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste», Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν, Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est.
Cosa sia la perfezione di cui parla la ‘Buona Novella’ è chiaro a chiunque consideri il termine greco con cui essa viene significata: ἡ τελειότης. Lui subito – all’istante – ripensò alla definizione aristotelica di fine: «il fine, in ogni cosa, è il bene, e, in generale, nella natura tutta, il fine (τὸ οὗ ἕνεκα) è il sommo bene (τἀγαθόν)». In τὸ ἐξαίφνης il fine può non essere raggiunto: se perfezione è nascere al di là per raggiungere il Sommo Bene, restare in τὸ ἐξαίφνης è restare imperfetti; l’importante è che Lui non se ne accorga! Sarebbe capace di tutto, se scoprisse che Qualcuno è rimasto nel ventre del nonessere…
Lui pensava al liquido amniotico: τὸ ἀμνειός è il sacco amniotico, l’involucro del feto, perché τὸ ἀμνίον è il vaso per il sangue, nei sacrifici; può darsi che l’etimologia di τὸ ἀμνειός si spinga fino a ὁ ἀμνός, l’agnello – pensava Lui – e allora vorrebbe dire che l’Agnus Dei è tale in quanto sacco amniotico dell’Essere, la sacca divina che protegge la vita in quanto vita stessa. Giovanni 1,29: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!», Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Il peccato, ἡ ἁμαρτία, è voce del verbo ἁμαρτάνω: fallisco il bersaglio. Se il bersaglio è il ‘fine’ del tiro, è lo ‘scopo’ del lancio, ecco che “giungere al fine”, come si dice, è chiudere la partita in quanto si è raggiunto il bersaglio. Ma se essere è il fine, la meta dell’essere umano, ecco che allora diventare perfetti è raggiungere l’Essere perfettissimo: ancora una volta Lui. In τὸ ἐξαίφνης il fine si può evitare, il bersaglio si può mancare.
In ospedale era mancato un altro degente. Ne mancavano ormai molti, all’appello, da quando Lui era entrato in accettazione per il suo day hospital spirituale. Molti anche avevano avuto un mancamento, ma quelli non erano mancati: non è una mancanza grave, un mancamento. A Lui mancavano molto, coloro che erano mancati. «Nessuno dovrebbe mancare – pensava – perché è sintomo di malessere, mancare. Il benessere fa essere e il malessere fa mancare». Con questa ennesima illminazione, Lui aveva chiarito ancora meglio a se stesso che il ben-essere, la salute, è icona sacramentale della salvezza, quella cosa buona e giusta per la quale un celebrante, nel prefazio della messa, rende grazie rivolgendo la sua orazione
a te, Signore, Padre santo,
che sei Dio di misericordia
e alla punizione della colpa
preferisci un generoso perdono.
«Sì, sì – Lui pensava – Dio preferisce un generoso perdono ma non per questo disdegna una gretta condanna». L’uomo è un essere gretto, forse per questo si è modellato un Dio a sua immagine e somiglianza.
Il cappellano vagava come un buon pastore tra le sue pecore più bisognose, quelle più sofferenti, per portare loro il conforto dei sacramenti, in ossequio alla quinta delle sette opere di misericordia corporale: visitare gli infermi, ma anche in osservanza alla quarta delle sette opere di misericordia spirituale: consolare gli afflitti. Tutti lo accoglievano con riverenza e riconoscenza, ma Lui lo vedeva, che Tutti erano semplicementi attaccati alla loro vita e alla loro salute, più che alla ‘grazia di Dio’ annunciata e proposta dal cappellano. Giovanni 6,26: «voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati».
Prima di fare questo “ritiro spirituale ospedaliero” Lui aveva sempre studiato con passione Kant; adesso, però, dopo aver visto la meschina, egoistica grettezza di cui sono capaci gli esseri umani quando si trovano nell’indigenza fisica, cominciava a rivalutare il grande antagonista di Kant: David Hume. Pensando alla Ricerca sull’intelletto umano di Hume, An enquiry concerning Human Understanding, del 1748, Lui osservò che la salute è una impression ben più vivida della salvezza, la quale ultima potrebbe quindi definirsi thougts or ideas: il benessere e il malessere fisico lasciano un’impressione che possiede «un grado di vivacità», a pitch of vivacity, assai più vivida del pensiero o dell’idea di salvezza. C’è poco da fare: Lui, in ospedale, aveva toccato con mano che la sensazione di benessere o di malessere è quella che ‘si prova’, non quella che ‘si pensa’; anzi, spesso i pazienti si consolavano di non poter provare la sensazione benefica della salute proprio lasciandosi “impressionare” dall’idea della salvezza al pensiero di Giovanni 16,20-23: «In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla»: tristitia vestra vertetur in gaudium.
Più stava in ospedale, più Lui pensava che Hume avesse ragione: una impression è più forte di un pensiero o di un’idea; «quando Qualcuno di questi pazienti sarà dimesso e se ne tornerà a casa guarito – pensava – il ricordo del malessere, pensato a casa, sarà assai meno vivido del malessere effettivamente provato qui. La “prova” di una sensazione è nel suo ‘essere provata’, non nel suo ‘essere pensata’: questo è perception, per Hume»; «tutte le nostre idee o percezioni più deboli sono copie delle nostre impressioni o percezioni più vivide», All our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions or more lively ones. Il benessere della salute è innanzitutto percezione sensibile: «sensazione o sentimento», feeling or sentiment. Hume lo confermava nell’idea che la Salvezza, in quanto pensiero della salute metafisica, fosse soltanto una copia di un ‘sentire’, to feel, che nel suo originale paradigma è Salute fisica.
Feeling and sensation sono la porta per la quale le idee entrano in testa ma «tutte le idee, specialmente quelle astratte, sono naturalmente deboli ed oscure», All ideas, especially abstract ones, are naturally faint and obscure, mentre «tutte le impressioni, cioè tutte le sensazioni, sono forti e vivide», all impression, that is, all sensations, are strong and vivid.
Quando, perciò noi nutriamo qualche sospetto che un termine filosofico sia usato senza qualche significato o idea (come avviene troppo spesso), dobbiamo soltanto stabilire da quale impressione sia derivata quella supposta idea. E se è impossibile assegnarne una, ciò servirà a confermare il nostro sospetto. [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pag. 31]
La Salvezza. From what impression is that supposed idea derived? Quella supposta idea deriva dall’impressione di salute – pensava Lui – ma siccome la Salvezza è una salute posta nell’al di là, ecco che essa è solo supposta, appunto, dall’impressione di malessere al di qua che cerca l’idea di benessere al di là. Il malessere di una malattia, quanto più è doloroso, tanto più ‘fa impressione’ e quindi lascia nella mente l’impressione che, al di là, possa esserci un malessere perfetto: ‘un inferno’; così come, il benessere di una guarigione, quanto più è piacevole, tanto più ‘dà l’impressione’ di poter credere in una salute perfetta: ‘un paradiso’. Ciò che impressiona, genera idee simili e, omeopaticamente, idee contrarie.
Una paziente aveva avuto una violenta reazione idiosincrasica: i sulfamidici le avevano provocato un’anemia emolitica e lei, pallida e stanca, era visibilmente affetta da ittero: aveva una pelle gialla da far paura, dovuta al patologico aumento nel sangue della bilirubina che si deposita nei tessuti. Lui pensò che la farmaco-idiosincrasia è un esempio di intolleranza farmacologica che ben potrebbe esemplificare lo scetticismo provato da Hume nei confronti del nesso causa / effetto: in fondo, è esperienza di tutti i medici che un farmaco non solo non è tollerato da tutti i pazienti, ma che, seppur tollerato, in pazienti diversi sortisce spesso effetti diversi; il quadro clinico che sopravviene dopo l’assunzione di un farmaco è perlopiù diverso nei vari pazienti. Parlando della relazione causa / effetto, Hume ebbe a scrivere
«Oserò affermare come proposizione generale che non ammette eccezioni che la conoscenza di questa relazione non si consegue in alcun caso mediante ragionamenti a priori; ma nasce interamente dall’esperienza quando troviamo che certi particolari oggetti sono costantemente congiunti tra loro». [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pag. 41]
…when we find, that any particular object are constantly conjoined with eatch other. A Lui sembrava di vederlo, Kant, leggere con preoccupazione queste affermazioni di Hume e poi pensarci su, per vedere se gli riuscisse di dimostrare la loro falsità… Lui sosteneva che la Critica della ragion pura forse non sarebbe nemmeno nata, se Hume, nella sua Ricerca sull’intelletto umano, non avesse insinuato in Kant il famoso, forte dubbio circa l’oggettività del rapporto di causa & effetto. Kant riuscì a dimostrare la fondatezza soggettiva, cioè umana, del rapporto fisico di causa & effetto, ma dopo Hume nessuno più riuscì a riabilitare la fondatezza, soggettiva o oggettiva, del concetto di causa metafisica, che nella Causa Prima, Dio, aveva sempre avuto il suo maggior esponente. Ma il concetto di causa non è così pacifico come può sembrare, specie in campo farmacologico:
…il rabarbaro non ha sempre avuto effetti purgativi, né l’oppio ha sempre avuto effetti soporiferi per tutti coloro che hanno preso queste medicine. [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pag. 89]
Osservando i così diversi effetti che uno stesso farmaco ha su soggetti affetti dalla stessa patologia, Lui finì per ritrovarsi d’accordo con Hume: «si deve certamente ammettere che la natura ci ha tenuto a grande distanza da tutti i suoi segreti e ci ha concesso soltanto la conoscenza di poche superficiali qualità degli oggetti, mentre ci nasconde quei poteri e princìpi dai quali dipende interamente il loro influsso». Sebbene tutti gli argomenti riguardanti l’esistenza siano fondati sul nesso causale,
«Se si dicesse che da un numero di esperimenti uniformi noi inferiamo una connessione fra le qualità sensibili ed i poteri segreti … ritorna ancora la questione: su quale corso di argomentazione è fondata questa inferenza? Dov’è il medio, dove sono le idee interposte che congiungono proposizioni tanto distanti l’una dall’altra?» [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pag. 57]
…on what process of argument this inference is founded? Per il fatto che B succede sempre ad A, non potremo mai inferire una volta per sempre che A è la causa di B: «la loro congiunzione può essere arbitraria e casuale», Their conjunction may be arbitrary and casual. A Lui venne in mente Luca 12,54-57: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?».
Passò di nuovo il cappellano. Quando passa un prete, Qualcuno tocca ferro, perché talvolta egli va a dare l’Estrema Unzione a un moribondo. L’Unzione degli Infermi è un sacramento che nell’immaginario di Tutti è riservato a chi sta per morire, ma la chiesa si premura di precisare che esso è il sacramento dei vivi, non dei morti. In un ospedale, quando si vede passare un cappellano subito si dice: in questo mondo Qualcuno sta per morire. «Se Hume ha ragione – pensava Lui – chissà che, in futuro, di fronte a un cappellano ospedaliero che passa, Tutti non possano dire: nell’altro mondo Qualcuno sta per nascere». La vita causa la morte al di qua e la morte stessa causa la vita al di là: la morte è effetto e causa al contempo; la morte è effetto della vita al di qua e causa della vita al di là.
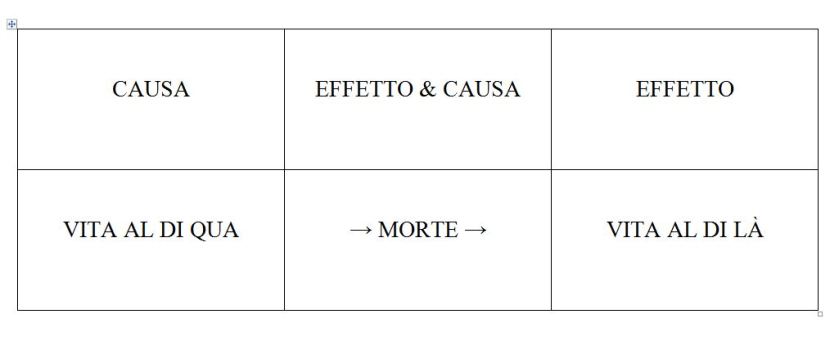
La morte è l’effetto che causa la vita al di là. Come se dicessimo, poniamo il caso, che Caio, il quale adesso è figlio di Tizio e Sempronia, cioè effetto dei propri genitori, nulla esclude che, più in là, possa diventare a sua volta genitore anch’egli. Giovanni 12,24: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». Lui si sentiva così in sintonia con Hume, che gli venne da dire: «Chi lo sa, se un giorno, un chicco di grano possa non morire? Meglio rimanere solo in τὸ ἐξαίφνης e non rischiare la morte eterna, che morire e poi magari finire all’Inferno!».
La religione cristiana ci ha abituato a credere che la prima morte, quella che è effetto della vita al di qua, causa sempre una seconda vita (paradiso) o una seconda morte (inferno) al di là; Hume direbbe che è solo la consuetudine (o abitudine) a farci credere questo nesso causale: custom or habit. È costume (= custom) credere che la morte sia prolifica. In realtà, questo nesso causale non è certificato che da una sola esperienza: la resurrezione di Cristo, la quale resurrezione fu, però, esperienza solo di qualche suo discepolo a Lui contemporaneo. Giovanni 20,29: «beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Prima ai Corinzi 15,16-17: «Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede».
La fede è credere per custom or habit, per costume, per abitudine, a un fatto che non è esperibile con i sensi: è credere sulla parola di altri, che dicono di aver esperito ciò che predicano, che dicono di aver fatto esperienza di ciò in cui credono, ma «tutte le inferenze dall’esperienza, dunque, sono effetti di consuetudine, non di ragionamento», All inferences from experience, therefore, are effects of custom, not of reasoning.
«Se domando perché credete in qualche determinato fatto di cui state parlando, dovete dirmi qualche ragione; e questa ragione sarà qualche altro fatto, connesso con quello. Ma poiché non potete procedere a questo modo in infinitum, dovete per ultimo metter capo a qualche fatto, che è presente alla vostra memoria o ai vostri sensi; oppure dovete ammettere che la vostra credenza è completamente senza fondamento». [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pag. 71]
…or must allow that your belief is entirely without foundation. Prima ai Corinzi 15,3-5:
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
The belief. La credenza. Ci vuole fede, per credere in una credenza. Ma, per chi crede, il kèrigma non è fiction, ma belief, appunto; il kèrigma è voce del verbo κηρύσσω: annuncio, di cui l’apostolo è ὁ κῆρυξ -ῦκος: l’araldo. Fiction and belief: «la differenza fra l’invenzione (fiction) e la credenza (belief) consiste in qualche sentimento o sensazione (sentiment or feeling), che è connessa alla seconda e non alla prima e che non dipende dalla volontà (will), né può perciò esser comandata a piacere», dice Hume.
Un uomo, ingessato da capo a piedi si lamentava per i dolori che provava in tutto il corpo. Sua moglie, che era lì con lui, gli diceva: «è normale, è normale, dopo le prime due settimane di gesso… è normale, i dottori hanno detto che è normale…». «Sarà anche normale – diceva lui – ma mi fa male». Ecco l’impression di Hume, che è più forte di thougts or ideas – pensava Lui. Pensieri ed idee sono impressioni “a tavolino”, estrapolate e astratte dalla realtà sensoriale che ne è unica causa. «Beh – pensava Lui – Hume non credeva nel nesso causale, però credeva che le impressions causano toughts or ideas! Almeno in questo nesso causale, Hume, ci credeva». E gli riecheggiava in testa quella frase dell’uomo ingessato: “sarà anche normale, ma mi fa male”… e ricordava Giovanni 9,25: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo»; mentre i Giudei stavano lì a sciorinare toughts or ideas per mettere in dubbio il miracolo occorso al cieco nato, lui, l’ex non-vedente, va subito al “sodo” dell’impression: poche storie, potete dire quel che volete, cari Giudei… io, da parte mia, so solo una cosa: che prima non ci vedevo, ed ora ci vedo.
È l’essenzialità, che conta, l’essenzialità del benessere, dello star bene, dell’essere in salute, nient’altro (quando c’è la salute, c’è tutto…). Lui non credeva, perché, di fronte alla belief, non riusciva a provare né sentiment né feeling. Se almeno riuscissi a provare l’impression dei discepoli di Emmaus – pensava – che ne so? Un battito cardiaco inaspettato, un soffio al cuore, insomma, un sintomo qualunque di sentiment or feeling, forse, allora sì che crederei! E gli veniva in mente Luca 24,32: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». I preti che aveva conosciuto raccomandavano sempre di non fondare la fede sul sentimentalismo, perché la fede non è un sentimento… però – pensava Lui – è anche vero che, alla Hume, una belief, senza sentiment or feeling, è solo fiction. Nonne cor nostrum ardens erat in nobis…? E poi, se fede è l’incontro con un uomo di nome Gesù, e non la conoscenza intellettuale di una dottrina di nome cristianesimo, a maggior ragione. Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ;
SOCRATE: Affermi che la virtù (ἀρετὴν) consiste nell’essere capace di procurarsi le cose buone (τἀγαθά)?
MENONE: Sì.
SOCRATE: E per cose buone intendi per esempio la salute (ὑγίειαν)…, no?
In Menone 78 [c] Platone indica nella salute, ἡ ὑγίεια, uno dei beni, τἀγαθά, da procurarsi in vita. Platone, essendo nato e morto prima di Cristo, non aveva potuto conoscere la Salvezza, ma solo la Salute – pensava Lui. Luca 19,9: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, hodie salus domui huic facta est. Salvezza: ἡ σωτηρία, salus…
Si dice che Diogene di Sinope, il cosiddetto “Socrate pazzo” nato nel 412 a.C., uno dei fondatori della scuola cinica, un giorno fu visto vagabondare per Atene con un lume tra le mani mentre diceva: “cerco l’uomo”; Diogene ricercava un’umanità autentica, scevra da convenzioni sociali… Lui fu visto gironzolare per l’ospedale con il solo lume della ragione, dicendo: “cerco la salvezza”; ma vedeva solo dei malati. Tutti cercavano la salute, Nessuno la salvezza. Nessuno vide un Salvatore entrare in ospedale e dire: Oggi la salvezza è entrata in questa casa… forse perché quell’ospedale non era a Gerico e tra i malati non c’era Nessuno che si chiamasse Zaccheo?
La salvezza non era nella medicina, di questo Lui era ormai convinto. In certi pazienti Lui vide dei miglioramenti clinici, ma la salvezza non era in quei miglioramenti; dopo i miglioramenti, Lui vide la salute, ma la salvezza non era nella salute; dopo la salute, Lui vide la morte, ma la salvezza non era nella morte…
«Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna».
Primo Libro dei Re, 19,11-13. Anche Lui ormai era fermo all’ingresso della caverna, ma della caverna platonica, e vedeva l’abitudine al mal comune incatenare i degenti nel miraggio delle diagnosi e delle prognosi, più o meno riservate, che baluginavano fra le ombre dei medici e della medicina… Platone, Repubblica 514a –517a:
Per tali persone insomma, feci io, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. – Per forza, ammise. – Esamina ora, ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall’incoscienza. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo: che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e che cosí facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di [d] scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo piú vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi piú essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe piú vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso?
I degenti vedono solo il miraggio della salute. Il cappellano sembrava l’unico, ad essere uscito dalla caverna ospedaliera, e cercava di convincere i pazienti che non c’è solo la salute del corpo, ma anche la salvezza dell’anima, la quale ultima è assai più importante della salute del corpo… Marco 8,36: «quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita?», τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
Ancora una volta, il greco dei vangeli traduceva con ψυχή la vita al di qua. «Povero Platone! – pensava Lui – se avesse saputo cosa ne avrebbe fatto il cristianesimo della sua ψυχή…». L’Anima, prima di Cristo, era ἡ ψυχή. Dopo Cristo quest’anima cominciò a diventare psìche, il complesso delle funzioni e dei processi che danno a un individuo l’esperienza di sé e del mondo. Con la svalutazione della ψυχή a vita al di qua, l’anima fu retrocessa a Io anima-to e Dio fu promosso a Spirito Santo: ἅγιος πνεῦμα. In Giovanni 1,33 il Battista dice che solo il Salvatore è colui che battezza in Spirito Santo: ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ·
In quell’ospedale non c’erano cristiani così convinti da disperare più per la perdita della salute che per la perdita della salvezza; è anche vero che quello era un ospedale di provincia, e, forse – pensava Lui – la salvezza è affare più metropolitano che suburbano, più cittadino che provinciale. «La cultura, è la cultura metropolitana ed accademica che intellettualizza le semplici e immediate impressions della natura – pensava Lui – ed è per questo che in provincia i malati cercano la salute prima della salvezza». Intellettualizzare è passare dalle impressions della natura sensibile alla concettualizzazione di toughts or ideas. La salvezza è la concettualizzazione della salute. Ma la concettualizzazione è l’universalizzazione di una impression, per cui la salvezza è l’universalizzazione metafisica e concettuale del benessere fisico: «tutte le nostre idee non sono che copie delle nostre impressioni…
all our ideas are nothing but copies of our impressions
…o, in altre parole, è impossibile che noi pensiamo (think) qualche cosa che non abbiamo antecedentemente sentita (felt), sia per mezzo dei sensi esterni che di quelli interni».
«Ciò significa – pensava Lui – che siccome, al di qua, nessun benessere fisico riesce mai a diventare salute stabile di un ‘essere per sempre’, (dal momento che di fronte alla morte non c’è salvezza, cioè non c’è scampo), mi pare si possa dire, con Hume, che, l’idea di salvezza, il pensiero di una salute eterna (salus perpetua), non nascendo da nessuna impression realmente esistente al di qua (dacché non esiste, al di qua, una salute così “di ferro” da essere capace di far da scudo alla morte) ecco che ogni idea o pensiero di vita eterna è un’inferenza filosofico-teologica assolutamente infondata». Lo scetticismo di Hume trovava terreno fertile, in ospedale. Nessuna medicina (= farmaco) dava alla Medicina (= scienza medica) il suo fine naturale: l’immortalità. A Lui pareva che questa impotenza fosse la prova provata dell’impotenza e della falsità del “vangelo eziologico”, o etiologico, αἰτιολογικός di cui il pensiero occidentale-aristotelico è ἡ αἰτία, «la causa».
La causa fisica della filosofia, ἡ αἰτία, è diventata causa metafisica quando la teologia l’ha resa «responsabile», αἴτιος, cioè «colpevole», ὁ αἴτιος, di quella «colpa», τὸ αἴτιον, che in Luca 23,22 fa dire a Pilato: «Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte», nullam causam mortis invenio in eo, οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· La vecchia Diodati era più moraleggiante: «io non ho trovato in lui maleficio alcuno degno di morte». L’iter semantico che il vocabolo «causa» compie dalla fisica aristotelica alla metafisica cristiana va nel senso della moralizzazione. Lui pensava:
Se io dico che una causa è ‘responsabile’, sto dicendo che essa è capace di intendere e di volere. Il male fisico diventa, impercettibilmente, da male maleficio, da maleficio malvagità, da malvagità peccato e infine da peccato diventa ‘colui che è peccato’ per eccellenza: ‘il Maligno’, cioè il Male metafisico. Satana, Colui che è peccato, è peccato perché ha peccato prima di Tutti: per ciò è la causa (prima) del peccato, come Dio è la causa (prima) della grazia, cioè del bene.
Prima la causa diventa colpa, poi si cerca un colpevole sul quale infierire e da poter offrire come capro espiatorio alla massa dannata, bramosa di vendetta. Lui non è reo di colpa perché è il Bene e in quanto tale è la causa (ovviamente ‘prima’) del benessere benefico della grazia. L’Anti–Lui è reo di colpa perché è il Male e in quanto tale è la causa (‘prima’ relativamente alle creature, ma ‘seconda’ relativamente al Creatore) del malessere malefico della dis-grazia.
Lui vuole essere la causa prima di Tutto e per questo l’Anti–Lui deve essere la causa seconda: Lui è causa del Bene e l’Anti–Lui è causa del Male, ma siccome il Male non l’ha creato Lui, ecco che il Male è causa “in seconda”, comandante in seconda – come si dice nella gerarchia militare – e addetto ai piani bassi. Il ‘comandante in prima’ si arroga ogni diritto eziologico e se lascia il comando è per darlo a uno che fa sicuramente peggio di Lui: alla causa del male. Come dire: Lui vuole sempre avere il timone in mano. Noi, poi, umili creature, non abbiamo nemmeno la dignità del reo: siamo solo correi, dacché il peccato originale fu possibile unicamente perché l’Anti–Lui ne fu la causa. La gerarchia va, nell’ordine, dall’Innocens al Reus e giù giù fino al con–Reus. Funziona così: il superiore “fa la morale” all’inferiore; il sottoposto deve essere moralizzato dal suo capo. Così, l’Innocente fa la morale al Reo, e il Reo fa la morale al correo. Solo che la morale che fa l’Innocente è buona, mentre quella che fa il Reo è cattiva, per cui il correo (cioè noi) si trova a dover scegliere tra la morale del Reo e quella dell’Innocente: tra l’ubbidire al diretto superiore, il Reo, e l’ubbidire al superiore non diretto, il comandante in prima, l’Innocente. Il nostro superiore diretto è il Reo: perché dovremmo ubbidire all’Innocente?
Questa storia del “fare la morale” è inquietante – pensava Lui – perché la sua procedura è la copia metafisica della procedura fisica del “causare”. «Ecco – pensava Lui – sta tutto qui, l’enigma: nel trapasso dal principio causale al principio morale». Non si capisce perché, se A causa B, A debba anche sentirsi in diritto di fare la morale a B!
Forse – pensava Lui – il trapasso si può rilevare grammaticalmente nel passaggio, insensibile ma inesorabile, dal sostantivo causa al verbo causa: il sostantivo, che prima è causa di un effetto, dopo, in quanto causa, lo giustifica. Ma allora ha ragione Hume: la causa non è la necessaria causale di un effetto a lei congiunto, piuttosto, è il casuale “venire prima” di un venio che precede un evenio: di un eventum che segue un ventum. In latino c’è venio, is, veni, ventum, ire ed anche evenio, is, veni, ventum, ire. In realtà, Hume distingue tra congiunzione probabile di due eventi e connessione necessaria:
«noi mediante l’esperienza apprendiamo soltanto la frequente congiunzione (conjunction) di oggetti, senza che ci riesca di comprendere qualcosa come una connessione (connexion) fra essi». [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pag. 109]
Noi possiamo solo constatare «un evento che tien dietro ad un altro evento», one event following another. Solo in una connexion necessaria, l’e-vento “viene fuori” dal vento che lo precede. «Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento».
Il Primo Libro dei Re forse sta dicendo la verità senza accorgersene: la causa prima non è il Signore – pensava Lui. Se il vento precede l’e-vento, e il vento non è il Signore, vuol dire che il Signore non causa l’e-vento. Già, infatti, magari non lo causa, però gli “fa” la morale. Forse, “fare la morale” non è causare. Infatti, Agostino dice che Dio non ha creato il Male, dacché è Innocente, cioè, Dio non è la causa del Male; la colpa del Male ricade sul comandante in seconda, l’angelo che ha voluto prendere in mano il timone al posto di Dio ed è naufragato. L’innocenza non è la causa della colpa, va bene, però l’Innocente fa la morale al Colpevole e il Colpevole non può farla all’Innocente. Il superiore ha sempre ragione?
Per prendere le distanze dal Male, il Bene dice di non esserne la causa, salvo però, poi, dire che ne è il Creatore! Ma: non è forse il Creatore la causa prima di Tutto? E allora come può dire di non essere anche la causa del Male, questo Creatore? A forza di fare la morale a Tutti, il Creatore è passato dalla parte del torto! (?) Chi si loda s’imbroda, proprio vero – pensava Lui. A meno che creare non voglia dire causare: questa è l’unica scusa che il Creatore potrebbe addurre, per venirne fuori. Lui non aveva nessuna intenzione di fare una teodicea: «è onnipotente? si difenda da solo!».
Già Severino Boezio, nel De consolatione philosophiae, si era chiesto: Si deus est, unde malum? Et si non est, unde bonum? Lui pensava che, mantenendo l’equivalenza «creare = causare», a questa domanda non si può rispondere; perché se Dio è la Causa del Bene non può essere anche la Causa del Male, e se è il Creatore del Male non è il Creatore del Bene.
Mentre si pronunciava (e si gustava) mentalmente queste parole, Lui notò che l’impossibilità divina di essere al contempo causa del Bene e causa del Male è in ultima analisi una impossibilità logica: solo il principio di non-contraddizione impedisce al Logos divino di essere e non essere nello stesso tempo causa di qualcosa e del suo contrario. L’approccio teologico al Creatore come Causa Prima, che quel “gran ripetitore” di Aristotele chiamato Angelico Dottore praticò, costringe il Male a diventare falsità della verità: se il Male è la contraddizione del Bene, bisogna stabilire se è bene il Bene o se è bene il Male. Il criterio scelto per dirimere la questione fu l’anteriorità: chi viene prima è il Bene; ma chi viene prima è anche la Causa: chi precede si prende tutt’e due i meriti, di essere Bene e di essere Causa. Questo è il vantaggio del «Principio», di ἡ ἄρχή: quello di prendere in mano τὸ ἀρχεῖον, il «potere». Chi viene prima prende tutto. Ma in che senso, viene prima? In senso archetipico-gerarchico o cronologico-temporale? Cronologicamente, A può venire prima di B solo se B succede ad A, ovvio. La tendenza è quella di far venire prima la causa e dopo l’effetto aggiungendo alla notazione fisica della temporalità la connotazione metafisica della moralità: perlopiù, il superiore è nel giusto; ma questa è già una moralizzazione della precedenza cronologica – pensava Lui.
Mentre pensava queste cose, passò il direttore dell’ospedale: il Primario di tutti i primari; ogni reparto ospedaliero ha un primario, ma il direttore dell’ospedale vien prima di tutti, e non necessariamente perché sia nato prima di tutti. Nella gerarchia al di qua, talvolta è il più giovane ad essere superiore di un inferiore: sono frequenti i casi di inferiori che si trovano a dover ubbidire a superiori più giovani di loro. Il Superiore, al di là, essendo fuori del tempo – come dicono – può dire di essere eternamente giovane e Tutti devono crederci, sicché si verifica sempre, al di qua, che noi si debba ubbidire a un Superiore sempre più giovane di chiunque. Luca 21,33:« Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». «Bravo Lui! – pensava Lui –, facile dire così: come fanno a passare, le Sue parole, se sono fuori del tempo?».
«È insopportabile, questa smania di primeggiare da parte del Principio (Primo)! – pensava Lui – si crede il Principale di Tutti… fa il primo della classe perché dice di essere venuto prima di Tutti, ma è la collocazione spazio-temporale, a decidere della “bontà” di un princìpio? Un princìpio è Primo solo perché precede Tutti nel tempo e nello spazio? Se così fosse, Dio, essendo fuori del tempo e dello spazio, non potrebbe mai essere il Primo» – così pensava Lui. Già, ma magari poi Lui ti dice che è il Primo perché è venuto prima anche del tempo e dello spazio, e tu, cosa gli ribatti? «Che non vale! – pensava Lui – gli ribatti che non vale, fare il Primo di una serie spazio temporale dall’alto di una dimensione che spaziotemporale non è: se Lui è fuori dello spazio e del tempo, ebbene, che faccia il Primo là fuori, al di qua lo spazio e il tempo ci sono, quindi è inutile che Lui pretenda di primeggiare di qua standosene poi placidamente allogato di là; questo non è giocare ad armi pari».
Un Principale non si crede mai veramente ‘pari’ a un suo sottoposto, c’è poco da fare; non si mette mai alla pari con chi pretende di comandare. Il concetto di primus inter pares è una contraddizione in termini, perché chi è primo non sarà mai parigrado di chi è secondo, o terzo, o quarto… infatti, un secondino, o la pensa come il suo Principale, o sono guai… e Lui pensava a Matteo 16,23: «Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Povero Pietro, prima il Principale gli dice che su di lui avrebbe edificato la sua Chiesa, e poi, appena lui commette l’errore di dire una cosa sgradita, il Principale stesso gli dice di mettersi al suo posto: dietro di Lui. C’è poco da fare: un Principale vuole che Tutti se ne stiano buoni al loro posto, che è sempre dietro di Lui.
Ma fosse solo una questione di mettersi dietro, di venire dopo: no, il Principale pretende che venire dopo, stare dietro, sia anche un ubbidire a Lui; «è questo, che dà fastidio – pensava Lui – è come se il 2, per il semplice fatto spaziotemporale di venire dopo l’1, dovesse anche ubbidire all’1 in tutto e per tutto, uniformarsi a lui, metterlo prima di ogni cosa, sentirsi in debito nei suoi confronti e infine riconoscerne il primato morale; sicuramente, se il 2 dovesse sentirsi effetto dell’1, come se l’1 fosse la sua causa, il suo Creatore, certo che il 2 potrebbe pensare di essere da meno dell’1, come una creatura è da meno del suo Creatore… il che è assurdo: sappiamo tutti che il 2 è anzi addirittura più grande dell’1, visto che ne è il doppio». No, evidentemente non è una questione di numeri, a giustificare le smanie da prima donna del Principio Primo. Quindi, ciò che viene dopo il Primo, non è da meno perché gli viene dopo: questo pensò di poter concludere indubitabilmente, Lui.
Se avesse deciso di stare dalla parte dei credenti, se fosse riuscito a credere nel Principio Primo, Lui avrebbe portato queste sue argomentazioni in parrocchia e ne avrebbe fatto un catechismo eccezionale, almeno così Lui pensava… avrebbe convinto Tutti, anche quelli che non volevano credere… sarebbe diventato il beniamino del parroco, il suo braccio destro e la chiesa, forse, gli avrebbe addirittura chiesto di diventare prete, chissà… L’argomentazione sopra effettuata, infatti, sarebbe stata un’ottima prova – così pensava – del fatto che Dio deve per forza essere fuori dello spazio e del tempo: è un vero e proprio coup de théâtre far vedere che Deus, si est, in hoc mundo est ex machina! Cioè: che ritenere il 2 da più dell’1 è una macchinazione che costringe l’Uno a scendere giù dall’assoluto del suo Principio al relativo di una Fine che in questo spazio temporale lo fa diventare la metà del suo sottoposto. Come potrebbe, l’Uno, dire al 2 di mettersi dietro di Lui sapendo che Lui vale la metà del 2? Che razza di docimologia è mai, quella che costringe a valutare il 2 più dell’Uno? È la docimologia delle nostre scuole, nelle quali il più bravo prende dieci e il più asino zero.
Se essere migliori fosse una “competenza” docimologicamente valutabile in termini numerici [nel senso che chi è (= ha un voto) maggiore è anche migliore] Dio sarebbe una nullità, perché tutti sarebbero maggiori di lui: cioè, pretendendo lui di mettere tutti dopo di sé come se tutti fossero “dei numeri” – come si dice – lui si ritroverebbe ad essere da meno di tutti, com’è ovvio, e a nessuno potrebbe mai dire: «Va’ dietro di me, Satana». Satana è l’eterno secondino perché il Bene ha la precedenza sul Male. Veramente, in ospedale, a Lui non pareva, che il bene trionfasse poi molto: ovunque vi era pianto e stridor di denti, per dirla con Matteo 13,41-42: «Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti».
L’unica fornace ardente che Lui vedeva era il forno crematorio dell’ospedale, il quale, rispetto a quello dei campi di concentramento aveva la bontà di cremare solo corpi morti di morte naturale e senza il pianto o lo stridor di denti causato dalla malvagità nazista; per il resto, il concetto di “crematorio” restava per Lui un mysterium iniquitatis bell’e buono, cioè brutto e cattivo. È incredibile, come bellezza & bontà e bruttezza & cattiveria, si scambino talvolta i ruoli, anche semanticamente, in questo mondo. ‘La morte è un’iniquità… bell’e buona’. Detto così, non è proprio un mistero, che la morte sia brutta e cattiva; ma, quando i cristiani definiscono fortunato chi muore a questa vita per nascere all’altra, è, al contrario, proprio un bel mistero, come essa possa essere bella e buona.
La morte è come un tumore – pensava Lui – che può essere benigno oppure maligno a seconda che lo si consideri inizio o fine di una vita. Per i cristiani la morte è un tumore benigno, per gli altri è semplicemente un tumore maligno. I dizionari etimologici dicono che la parola «tumore» viene da tumeo (= gonfiarsi) cui pertiene la radice tu, foriera di “crescita”; tumorale è quindi sinonimo di enfiamento relativo a ogni neoplasia (= nuova formazione) cellulare come proliferare di cellule, almeno in latino. In greco, invece, la parola «tumore» porta al discorso oncologico sul “cancro”, il quale è ὁ ὄγκος, uncus, come gonfiore tumorale καρκινός, cancer, cancer-ogeno, cioè ulceroso, da ulcus (= piaga, ferita) affine al greco τὸ ἕλκος. Ancora una volta, nell’immaginario popolare, l’inizio è migliore della fine, specie se è un inizio che non ha fine. L’inizio, poi, è visto benevolmente perché è procreativo, perché da lui ha anche inizio qualcosa. La morte benigna dei cristiani è “tumorale” in quanto partorisce la turgida tumefazione dell’eternità. La morte maligna è tumorale in quanto abortisce la vita. Ciò che partorisce è bene perché è causa di vita; Ciò che abortisce è male perché è causa di morte.
La causa è bene quando inizia qualcosa; l’inizio pare sempre essere una buona causa. La causa finale, in fondo, altro non è che l’inizio visto in anteprima, quindi è finale ma non ha niente di male, nel suo finale a lieto fine. «Sarà per questo – pensava Lui – che la ‘causa prima’ è sempre Bene? Perché inizia sempre qualcosa? Ma iniziare non è dare origine in quanto creare?». A lui non andava giù, l’aporia che nasce dall’equivalenza di CAUSARE e CREARE. Il Creatore crea Satana come angelo buono, quindi il Creatore non è la causa dell’angelo cattivo; il Diavolo è il Male, ma lui stesso è causa del suo male: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il Creatore crea tutto per bene e la creatura è causa del suo mal. Il mal comune non è causato da Dio – questo sembrava ormai chiaro, a Lui – siamo Tutti creature di Dio, ma Lui non è la causa dei nostri mali. Lui ha creato Tutto ma non ha causato tutto. Quando tutto va bene, Dio è Creatore e Causa insieme, quando qualcosa va male, Dio è solo più Creatore e non più causa. Per salvare Dio dall’accusa di aver creato il male, lo si assolve dalla colpa di esserne la causa. Facile, così! – pensava Lui.
Da tutto ciò deriva che essere Creatore è sempre un merito, mentre essere Causa può essere un demerito, cioè un male. Su Dio-Creatore il Catechismo della Chiesa Cattolica:
279 «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gn 1,1). Con queste solenni parole incomincia la Sacra Scrittura. Il Simbolo della fede le riprende confessando Dio Padre onnipotente come «Creatore del cielo e della terra», 344 « di tutte le cose visibili e invisibili». 345 Parleremo perciò innanzi tutto del Creatore, poi della sua creazione, infine della caduta a causa del peccato, da cui Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto a risollevarci.
Dio trascende la creazione ed è ad essa presente
300 Dio è infinitamente più grande di tutte le sue opere: 379 «Sopra i cieli si innalza» la sua «magnificenza » (Sal 8,2), «la sua grandezza non si può misurare» (Sal 145,3). Ma poiché egli è il Creatore sovrano e libero, causa prima di tutto ciò che esiste, egli è presente nell’intimo più profondo delle sue creature: «In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Secondo le parole di sant’Agostino, egli è «interior intimo meo et superior summo meo – più intimo della mia parte più intima, più alto della mia parte più alta». 380
In grassetto azzurro Lui evidenziava l’affermazione problematica: Dio è «causa prima di tutto ciò che esiste». Il Catechismo della Chiesa Cattolica esordisce dicendo:
Il mondo e l’uomo attestano che essi non hanno in se stessi né il loro primo principio né il loro fine ultimo, ma che partecipano all’Essere in sé, che non ha né origine né fine. Così, attraverso queste diverse “vie”, l’uomo può giungere alla conoscenza dell’esistenza di una realtà che è la causa prima e il fine ultimo di tutto “e che tutti chiamano Dio” [San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, 2, 3].
La CAUSA PRIMA è il FINE ULTIMO. Hume, padre dello scetticismo, osserva laconicamente che noi «non abbiamo alcuna idea dell’Essere supremo all’infuori di ciò che apprendiamo dalla riflessione sulle nostre stesse facoltà». Noi a questo mondo apprendiamo che ognuno è artefice del proprio destino, faber est suae quisque fortunae, come disse Appio Claudio il Cieco, e che causiamo ciò che creiamo. Hume fornisce la vecchia definizione di nesso causale scrivendo che è quello «dove, se il primo oggetto non è esistito, non è esistito nemmeno il secondo», where, if the first object had not been, the second never had existed. In forza di questa definizione, l’Angelico Dottore ha potuto teorizzare il teologhema di Dio come causa non causata ma causante nella seconda delle famose cinque vie tese a dimostrare l’esistenza di Dio:
Troviamo nel mondo sensibile che vi è un ordine tra le cause efficienti (ordinem causarum efficentium), ma non si trova, ed è impossibile, che una cosa sia causa efficiente di se medesima (quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius); ché altrimenti sarebbe prima di se stessa (quia sic esset prius seipso), cosa inconcepibile (quod est impossibile). Ora, un processo all’infinito nelle cause efficienti è assurdo. Perché in tutte le cause efficienti concatenate la prima è causa dell’intermedia, e l’intermedia è causa dell’ultima, siano molte le intermedie o una sola; ora, eliminata la causa è tolto anche l’effetto: se dunque nell’ordine delle cause efficienti non vi fosse una prima causa (ergo, si non fuerit primum in causis efficientibus), non vi sarebbe neppure l’ultima, né l’intermedia (non erit ultimum nec medium). Ma procedere all’infinito nelle cause efficienti equivale ad eliminare la prima causa efficiente (sed si procedatur in infinitum in causis efficientibus, non erit prima causa efficientis); e così non avremo neppure l’effetto ultimo (et sic non erit nec effectus ultimus), né le cause intermedie (nec causae efficientes mediae): ciò che evidentemente è falso. Dunque bisogna ammettere una prima causa efficiente, che tutti chiamano Dio (Ergo est necesse ponere aliquam causam efficientem primam: quam omnes Deum nominant). [S. Tommaso d’Aquino: La somma teologica – Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1969 – I, q. 2, a. 3 – pagg. 84-87]
Ordo: Primum – Medium – Ultimum. Il “primato” del Primum deriva dall’impossibilità che esso possa essere ‘causa efficiente di se medesimo’, causa efficiens sui ipsius, cioè ‘prima di se stesso’, prius seipso. Ma quando poi Hume fornisce la sua definizione di causa chiandola «un oggetto seguito da un altro oggetto e il cui presentarsi porta sempre il pensiero all’altro oggetto», allora la seconda prova ontologica dell’Angelico Dottore traballa: an object followed by another, and whose appearance always conveys the thought to that other. «Con questa definizione di ‘causa’ Hume trasforma ogni e-vento in eventualità – così pensava Lui – perché, se semanticamente un e-ventum è connesso necessariamente al ventum che lo causa, senza causa esso non ha più ragion d’essere, o, meglio, il suo essere non dà più ragione al principio che lo vuole necessariamente connesso alla sua causa».
Lui era tutto fiero della parola che aveva trovato per significare un evento senza causa: eventualità. Un evento pensato senza ‘idea di connessione necessaria’ – idea of necessary connexion – è un’evenienza che può solo avere «una probabilità che sorge da una prevalenza di casi», a probability, wich arises from a superiority of chances. Nell’eventualità in cui un evento B succeda frequentemente ad un evento A, viene da pensare che ciò che congiunge B ad A sia una connessione necessaria, ma questo pensiero, buono per ogni evenienza ricorrente, dice Hume, si fonda solo su una congiunzione possibile tra B e A.
Nella sua Critica della ragion pura Kant rispose, “a distanza”, che «la congiunzione (die Verbindung) (coniunctio) di un molteplice in generale non può mai venirci dai sensi, e dunque non può neanche essere contenuta di già nella forma pura dell’intuizione sensibile, poiché come congiunzione essa è un atto della spontaneità della capacità rappresentativa (ein Actus der Spontaneität der Vorstellungskraft)» e «ogni congiunzione è un’operazione dell’intelletto (eine Verstandeshandlung) che in generale potremmo denominare sintesi (Synthesis)»; «fra tutte le rappresentazioni la congiunzione (die Verbindung) è l’unica che non può essere data dagli oggetti, ma può essere eseguita soltanto dal soggetto stesso». Nel soggetto, cioè in ogni essere umano, v’è per Kant il fondamento del principio di causa, nel senso che tale concetto non potrebbe sorgere mai se non fosse «fondato del tutto a priori nell’intelletto»; infatti, dice Kant,
«questo concetto esige in maniera assoluta che un qualcosa – A – sia siffatto che qualcos’altro – B – segua necessariamente e secondo una regola assolutamente universale», Denn dieser Begriff erfordet durchaus, daß etwas A von der Art sei, daß ein anderes B daraus notwendig und nach einer schlechthin allgemeinen Regel folge. [Immanuel Kant: Critica della ragion pura – Bompiani, Milano 2004 – a cura di Costantino Esposito – Cap. II, Sez. I, § 14. Passaggio alla deduzione trascendentale – pag. 231]
Le date biografiche di Kant e Hume sono:
- Kant: 1724 – 1804
- Hume: 1711 – 1776
Quanto a prime edizioni, la Ricerca sull’intelletto umano è del 1748 mentre la Critica della ragion pura è del 1781. Kant risponde a Hume cercando di giustificare (= dedurre) nuovamente ciò che Hume aveva posto fuori legge: il nesso causale; deduzione è, nel gergo giuridico, dimostrare che un quid facti è anche un quid iuris: se B succede ad A questa successione è un’evento di diritto e non un’evenienza di fatto, sostiene Kant, ed è “di diritto” perché nella testa dell’uomo vi sono degli schemi mentali, delle categorie, che trascendono la realtà empirica permettendo all’uomo stesso di “leggere” le evenienze come e-venti: la trascendentalità del diritto causale è solo nella testa dell’essere umano, nei concetti puri dell’intelletto, ma questo basta a Kant per dedurre il principio di causa & effetto. «Le categorie sono concetti che prescrivono delle leggi a priori ai fenomeni», Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen Gesetze a priori vorschreiben.
Vor + schreiben = prae + scribere = scrivere prima. In ospedale una medicina si prescrive dopo aver effettuato una diagnosi. Mentre cercava di diagnosticare il mal comune della creazione, a Lui venne in mente Romani 8,22: «sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi», οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit, et parturit usque adhuc.
In greco, συνωδίνω è «avere le doglie insieme, partecipare al dolore», dacché ὠδίνω è «avere le doglie del parto, essere in travaglio»: la creazione geme in ἡ ὠδίς, «gravidanza»; ma tale creazione, nel greco paolino, è ἡ κτίσις: «la fondazione», cioè è voce del verbo κτίζω: «fondo, costruisco, popolo, creo…». Sempre per tentare di venire a capo dell’aporia generatasi dal confronto sinonimico tra i due verbi, creare e causare, Lui pensò: «Ecco, ecco com’è andata: Lui s’è messo incinta da solo! creare è concepire, e Lui ha concepito…». Nell’istante in cui pronunciava mentalmente quel participio passato del verbo ‘concepire’, Lui pensò al doppio senso in esso contenuto:
- ricevere nel proprio corpo il germe di una nuova vita
- ricevere nella propria mente il germe di un nuovo pensiero
Concepire è essenzialmente «ricevere in sé», vita o pensiero. Il ricettacolo della vita è l’utero e il ricettacolo del pensiero è la mente, intelletto o ragione che dir si voglia. C’è una fecondazione psichica ed una fecondazione somatica: in entrambi i casi un processo di gestazione dal latino gestatio -onis «il portare, il farsi portare», derivato di gestāre, intensivo di gerĕre: «portare».
Gestāre è portare (in sé). Ma, per partorire la creazione, il Creatore, almeno, ha sofferto le doglie del parto? oppure, come sempre, gli è andata di lusso anche per la gravidanza ontologica? «Guarda che casino ha causato! – pensava Lui – guarda un po’: gli va di partorire e crea l’universo. Il parto ontologico è la causa della gravidanza del creato? Il creatore concepisce il creato, lo partorisce e questo causa a sua volta il concepimento del creato? è così? ma, allora, il creato dovrà anche lui partorire, ma cosa?». Stava delineandosi, in Lui, l’idea che la Causa Prima avesse, illo tempore, portato ad effetto la Creazione e il creato a sua volta stesse portando ad effetto gli effetti causati da quella Causa Prima… o qualcosa del genere. La Causa Prima crea e la creazione procrea. La Causa Prima pone in essere e le cause seconde suppongono l’essere.
I verbi porre e supporre gli sembravano illuminanti, in tal senso: se uno procrea si suppone che egli sia già stato a sua volta posto in essere, cioè procreato; sembra che le cause seconde abbiano il loro principio di ragion sufficiente nella supposizione dell’essere. La Causa Prima pone in essere, e così facendo innesca una reazione a catena di cause & effetti. Forse, la congiunzione actio & passio altro non è che la connessione ontologica procreata dalla Creazione… resta il fatto che, come ammette lo stesso san Paolo, la Creazione innesca un travaglio – pensava Lui.
I soliti difensori di Dio dicono che il travaglio è stato causato dal peccato originale della creatura, non dal Creatore. Dovremmo quindi supporre che, prima del peccato originale, la Creazione non era incinta, non portava in sé (= gestāre) ciò che invece adesso porta… «Ma – pensava Lui – cosa porta adesso in grembo, il creato, che prima non portava?». L’essere umano è rimasto incinta del travaglio quando s’è lasciato ingravidare dal Male (= Mela): dobbiamo supporre che, prima di mangiare la mela, Eva partorisse senza doglia alcuna. Del resto, in Prima ai Corinzi 15,56 si legge che «Il pungiglione della morte è il peccato», τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, Stimulus autem mortis peccatum est. Il mal comune è la gestazione continua di quel seme di morte: gli esseri umani continuano a procreare dei mortali perché la colpa causò la morte. Romani 5,12: «Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato…».
…e, con il peccato la morte… ..καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος… …et per peccatum mors… Lui ripensava con inquietudine a questa locuzione. La Creazione è Causa Prima dell’essere Bene che non muore e il peccato è causa seconda dell’essere Male che fa morire. Il Creatore, creando, causa il Bene dell’essere-immortale e la creatura, peccando, causa il Male dell’essere-mortale. Il peccato, allora è una sorta di creazione, in quanto causa della morte – pensava Lui – solo, non è creatio ex nihilo ma creatio ex… bono (?) Il Male è l’errore genetico compiuto dalla creatura che scelse di disobbedire al codice genetico della deontologia ontologica? Deontologia: comp. del gr. (τό) δέον -οντος «il dovere» e -logia. Il codice d’onore dell’essere è il dover-essere ontologico? Ma, questo dover-essere è il dovere di essere o il dover-essere-bene (= il comportarsi bene)?
Andò a cercare sul dizionario di greco la Causa Prima della deontologia, il Verbum deontologico, e, siccome la voce δέον lo indirizzava al verbo δείδω, andò a cercare δείδω, ma, alla voce δείδω fu reindirizzato al verbo δίω… ebbe un sussulto. L’assonanza tra il Dio italiano e il δίω greco gli fece sospettare che anche nella deontologia Dio ci avesse messo lo zampino, per cui andò subito a cercare δίω e, incredibilmente, trovò un verbo che significa «temere, fuggire»; il dizionario di greco proponeva di andare a vedere il latino dirus, e Lui accettò il consiglio, prese il dizionario di latino e cercò dirus: «funesto, di malaugurio, crudele, feroce, barbaro» e, al plurale, «presagi funesti».
L’etimologia sembrava mettere in relazione il dover-essere con qualcosa di malaugurato, di funesto, anzi, addirittura di crudele. Era un invito a nozze, per Lui, che aveva sempre pensato all’essere come a qualcosa di mostruoso, di… δεινός: «che ispira timore»; quando vide che anche la voce δεινός era dal dizionario di greco messa in relazione al verbo δείδω Lui ebbe come un’illuminazione: «Ma, allora, all’essere pertiene qualcosa di terribile, temibile… una necessità funesta, foriera di sventura… avevo ragione! e, addirittura, se ben ricordo, necessitas corrisponde a ἡ ἀνάγκη, la necessità che la mitologia santificò nella dea greca del destino… Ἀνάγκη». Quando, sul solito dizionario di greco, Lui scoprì che forse l’ ἀνάγκη greca c’entra qualcosa con il latino nex, necis, che significa «morte», ebbe la sicurezza che il “nesso” tra essere e dover-essere consistesse in un noceo, es, nocui, nocitum ere che nuoce da sempre all’essere umano: il mal comune della passione e morte umana.
Era sempre stato, un cacciatore di etimi, Lui, perché cercava nelle parole il senso di quel disagio diffuso che si chiama mal comune; chiedeva alle parole quel che nessun essere umano gli aveva mai detto. «In questo mondo la gente “tira la carretta”, ma non pensa: pensa solo a tirare avanti», pensava Lui; il quale, invece, pur tirando, come tutti, a campare, passava più tempo che poteva girato a guardare la carretta, per vedere quale soma pesasse così tanto sulla groppa del soma umano.
Persino un esistenzialista come Heidegger è riuscito a individuare nell’«essere-per-la-morte» il senso ultimo dell’essere umano – pensava – e la gente comune non riesce a individuarlo nel mal comune?». Ciò che è più comune la gente comune non lo vede. Sein zum Tode. Il § 46 di Essere e Tempo è quello in cui Martin Heidegger parla del suo das Sein zum Tode – l’essere per la morte – come di un «non-esserci-più», Nicht-mehr-da-sein, che l’essere umano raggiunge quando raggiunge la propria «Totalità», das Ganze. Quel compimento che per il cristianismo è raggiungimento della completezza, per Heidegger è «perdita secca dell’esser-nel-mondo» dacché l’«intero essente» è miraggio ontico di un improbabile, ontologico, Ganzsein: essere-inero. Del resto, cosa ci si può aspettare da un esistenzialista, se non il primato ontologico di un esserci che solo nell’hic et nunc spaziotemporale trova il suo senso ultimo? Il fine dell’esserci è la fine dell’essere in quanto «perdita dell’essere del ci», Verlust des Seins des Da.
Ci siamo, al di qua, e poi ci siamo (cadavericamente) senza più esserci (da vivi): l’essere “che non ci è più” ha in quel dativo etico tutta la portata esistenzialista del suo non essere più: non è più ‘per noi’, un defunto è, somaticamente, ancora essente per qualcuno. Così come, al contrario, in Isaia 9,5: «un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio», puer natus est nobis. Il dativus ethicus indica la partecipazione o il coinvolgimento emotivo, in questo caso di un vivente che ancora c’è nei confronti di un essere che non c’è più: «c’è» significa, esistenzialmente, «che-è-qui», ‘ecco’: da ist. Il compimento del perfectum può essere fine o inizio a seconda di come lo si considera.
Aveva ragione, Leopardi, quando diceva «a me la vita è male», solo – pensava Lui –, sbagliava nel preporre quel dativo, «a me», alla sua doleanza: ‘a vita è male’, punto. Il mal comune è semplicemente la vita: lo si chiama in tanti modi, ma passione e morte sono due parole che racchiudono in sé tutto quanto il significato del mal comune. L’errore commesso da Qualcuno è stato quello di non generalizzare, quello di riferire solo a se stesso una condizione che è assolutamente comune; se si generalizza – pensava – si è più forti, perché ci si sente più uniti contro quel nemico comune, che è la vita. Lui era convinto che quando la com-passione reciproca homo homini si fosse un giorno compiuta sulla terra, la desistenza sarebbe allora stata possibile ed anzi sarebbe stata sicuramente realizzata dall’umanità come una benevola e pietosa “eutanasia ontologica”; ontologica nel senso heideggeriano di esser-ci, ovviamente, perché, quanto all’essere al di là del “ci”, di questo a noi non è dato sapere. Lui era convinto che se homo homini agnus, nemo nemini lupus, ma era anche convinto che se nemo nemini lupus, nemo nemini homo: questo era il mistero gaudioso che contemplava.
A sirene spiegate un’ambulanza portava Qualcuno che aveva tentato il suicidio. Δεινός. «Il suicidio è una desistenza maligna, non è l’eutanasia buona dell’essere che va in esaurimento – pensava Lui – all’essere non ci si sottrae così, non va bene. Un conto è andare a finire ed un altro farla finita». Quel Qualcuno venne portato al pronto soccorso in fin di vita… chissà come soffriva. L’essere che va in esaurimento non è un essere umano che ha l’esaurimento, no: il desistente è in ottima salute, fisica e psichica. Il personale medico si stava facendo in quattro per salvare la vita a quel Qualcuno, e Lui pensava: «Gli umani si mostrano solidali solo quando Qualcuno cerca di evadere dall’essere: allora sono Tutti lì ad evitare il peggio, come se il peggio fosse morire. Vivere è assai peggio di morire, anche se morire non dev’essere piacevole. L’ideale sarebbe non dover morire – pensava Lui – ma questo è possibile solo se non si nasce».
Il cappellano accorse per vedere in che stato era il suicida: i preti fanno di tutto perché la vita possa trionfare, i preti sono i più grandi sostenitori della vita, perché il loro Dio è Vita, come da Apocalisse 1,17-18: «Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre», ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, καὶ ὁ ζῶν – καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ego sum primus, et novissimus, et vivus, et fui mortuus, et ecce sum vivens in saecula saeculorum. L’Apocalisse è una delle più terribili manifestazioni scritturali di terrorismo teologico, basta leggere come finisce:
E mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro». Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell’angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare». E aggiunse: «Non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio e l’impuro a essere impuro e il giusto continui a praticare la giustizia e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna! Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti.
Lui evidenziava in grassetto azzurro la benedizione del Vivente e in grassetto rosso la sua maledizione: Dio lo priverà dell’albero della vita… «Se a uno non gliene frega niente della vita – pensava Lui – Dio non può più minacciare alcunché. Dio può minacciare solo coloro che hanno il terrore di non essere più». Non ti lascia in pace, questo ‘Dio della Vita’: Lui da’ per scontato che a Tutti piaccia, vivere, e non tiene conto del fatto che a Qualcuno vivere può anche non piacere, come al suicida appena arrivato al pronto soccorso. La Medicina sembra lavorare per questo ‘Dio della Vita’: sembra quasi che il personale medico riceva dal Vivente qualche percentuale, su tutta la vita che salva, a giudicare dall’accanimento con cui si butta sulle malattie e sulle disgrazie altrui.
L’accanimento terapeutico è una delle forme più perverse di ostinazione ontologica, la protervia più efferata del dover-essere. «La missione peculiare del cristianismo è la vita e la sua conservazione – pensava Lui –, la colpa più imperdonabile dei cristiani è la loro continua istigazione alla vita: l’istigazione alla vita è il reato più grande del Cristianesimo». Il suicida lottava tra la vita e la morte, e Lui pensava a τὸ ἐξαίφνης: se si lotta tra la vita e la morte vuol dire che si è «tra», in mezzo, e quindi non si è più in vita e non si è ancora morti; quello è l’«istante agonico», l’agonia il terribile agonismo di chi agonizza nell’agone di τὸ ἐξαίφνης. La stringa etimologica di quell’istante supremo è stringente:
- ἡ ἀγωνία «lotta»
- ὁ ἀγών «agone»
- ἀγωνιάω «lotto»
Mors et vita duello conflixere mirando… La sequenza che si cantava nella Messa del giorno di Pasqua – Victimae paschali laudes – dà la palma della vittoria alla Vita: …Dux vitae, mortuus, regnat vivus. Ovviamente, il ‘Duce della Vita’ è Gesù Cristo, che risorgendo, sconfigge la morte. Il Duce…
Lui aveva sempre pensato che il Cristo fosse veramente il «“Duce” della Vita»: il cristiano è l’apostolo per eccellenza di quel ‘Totalitarismo Ontologico’ di cui Cristo è ‘Duce’; quella cristiana è una vera e propria ‘Dittatura Ontologica’: guai a chi «non è»! Bisogna essere: questo è il dovere principale: essere. La deontologia cristiana si fonda sul ‘Dover Essere’. Il peccato essenzialmente colpa di chi si è meritato il non essere. «Dio somiglia tanto a quei genitori che, volendo punire il loro figlio adolescente, gli impediscono di uscire, magari con gli amici… Ad un adolescente il poter uscire è una delle pene più pesanti che un genitore possa comminare, oltre al sequestro del cellulare, ovviamente. I cristiani dicono che Dio è Padre, ed infatti Dio fa il padre, anche se a modo suo: Lui punisce chi vuole uscire, chi vuole uscire dall’essere; un padre terreno punisce impedendo al figlio di uscire, il Padre celeste punisce costringendo a non uscire».
Dio è un Padre alla rovescia: premia non facendo uscire; ma comunque non lascia uscire nemmeno colui che intende punire. «Mi sembra tanto un’amante gelosa, il Dio dei cristiani: Lui è l’Essere, e guai a chi non ama essere. Ma, amare l’Essere deve per forza significare amare essere?». Deuteronomio 5,9: «io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso», ὁ θεός σου θεὸς ζηλωτὴς, Ego enim sum Dominus Deus tuus: Deus aemulator. Curioso, in greco ὁ ζῆλος è «la gelosia»: ma è anche «lo zelo»; aemulator è invece «il rivale», colui che emula e quindi è antagonista di qualcun altro. A Lui venivano in mente gli zeloti: zelota era, al tempo di Cristo, chi era molto zelante nell’osservanza della legge giudaica e quindi molto nemico dei Romani. «Lo zelo per la tua casa mi divora…», Salmo 69,10: «Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me». È un Dio “zelota”, questo Dio cristiano, pensava, e con ciò non voleva dire “beota”, voleva dire zelota, e basta.
Lui ce l’aveva a morte con l’essere, ma non per questo insultava l’Essere. «Come si fa a prendersela con l’Essere? – pensava –: è una battaglia persa in partenza: è come fare a botte con un gigante!». Il totalitarismo ontologico è gigantesco, specie in un ospedale. Quel poveretto che aveva tentato il suicidio ora l’avevano intubato: intubazione oro-tracheale, per bocca. Chissà se era cosciente? Certo – pensava Lui – se aveva tentato il suicidio, era perché non amava molto essere… poveretto, magari odiava essere senza per questo odiare l’Essere. L’Essere pensa subito che chi non ama essere è perché non ama Lui: ha la coda di paglia, è sospettoso, permaloso, l’Essere, è diffidente, irascibile.
L’Atto di dolore, la preghiera che il confessore fa dire al penitente al termine della confessione, recita: «Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, così infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa…». Sopra ogni cosa. Lui se lo diceva in tedesco: über alles, e gli veniva in mente Das Lied der Deutschen – Il canto dei tedeschi – quando comincia, con quel suo tronfio ed odioso «Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt…»: divenne l’inno ufficiale del partito nazista e poi, dal 1952 al 1989, della Repubblica Federale di Germania, cioè della Germania Occidentale, prima della caduta del muro. La grandeur germanica non è meno orgogliosa di quella francese… ma più Grande di Tutti è Lui, L’Essere Supremo, über alles per eccellenza, con la spocchia assolutistica di Esodo 20,3: «non avrai altro Dio all’infuori di me», οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ, Non habebis deos alienos coram me. La dittatura ontologica.
Il XIII canto dell’Inferno dantesco è la quintessenza poetica del quinto comandamento, «non uccidere»:
Quando si parte l’anima feroce
dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,
Minòs la manda a la settima foce.
Cade in la selva, e non l’è parte scelta;
ma là dove fortuna la balestra,
quivi germoglia come gran di spelta.
Surge in vermena e in pianta silvestra:
l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,
fanno dolore, e al dolor finestra.
Come l’altre verrem per nostre spoglie,
ma non però ch’alcuna sen rivesta,
ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie.
Qui le strascineremo, e per la mesta
selva saranno i nostri corpi appesi,
ciascuno al prun de l’ombra sua molesta.
Contrappasso: i suicidi, che disprezzarono il loro corpo, sono mutati in un altro corpo di natura inferiore e poiché straziarono se stessi sono straziati dalle Arpie. Al triage del giudizio divino il cattolicesimo austero e bacchettone di Dante fa sì che Minosse mandi nel secondo girone del settimo cerchio coloro che rifiutarono il loro essere: il pruno “bacchetta” i suicidi facendone sterpi che le Arpie beccano. Dietro alle Arpie dantesche, Lui aveva sempre pensato che si nascondesse il Dio geloso e zelota dell’Antico Testamento: l’Essere è il gran burattinaio di tutte quelle creature mitologiche che Dante fa uscire dal mondo pagano per far entrare nel mondo cristiano in veste di kapò.
Medici e infermieri andavano e venivano attorno a quel Qualcuno, cercando di far sì che il suo tentato suicidio potesse alla fine essere rubricato come mancato suicidio: il suicidio di chi non è riuscito a mancare, di chi ha mancato il bersaglio; «forse ce la farà…», dicevano Tutti. la Medicina non compie (ancora) il miracolo di far risorgere i morti, ma certo fa miracoli, quando tenta di “strappare alla Morte”, come si dice, chi è più di là che di qua. «Perché la Medicina non si fa i fatti suoi, e tenta di strappare alla Morte chi l’abbraccio della Morte lo cerca? Chi è, la Medicina, per poter parlare in nome della Vita? Solo Lui è la Vita – pensava Lui – e Nessuno può farsi oracolo della Vita senza essere ‘Oracolo del Signore’». Salmo 110:
Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».
Il Nonessere è lo sgabello dell’Essere: Dio vi sale sopra per poter avere tutta la visibilità ontologica che ha. Nell’interstizio situato tra la vita e la morte lotta l’istante passato che non vuole essere presente nel futuro: è il futuro, che siede alla destra del Presente, il passato siede alla sua sinistra; – nell’interstizio interinale di τὸ ἐξαίφνης l’essere è vacante? – seduto alla sinistra del Padre, il Nonessere: è “sinistro”, perché è passato, perché non è più. Lui, l’Essere Supremo, essendo «Colui che è» e non ‘Colui che è stato’, non conosce il passato, perché tutto è presente, in Lui. La concezione del presente ontologico è espressa soprattutto nel teologhema dell’«Atto Puro», che per Tommaso d’Aquino è nientepopodimeno che la definizione dello status divino: nella Somma Teologica, trattando De Dei perfetione, l’aquinate scrisse:
Ora, si afferma che Dio è la prima causa, non materiale, ma nell’ordine delle cause efficienti, e una tale causa è necessariamente perfettissima; perché come la materia, in quanto tale, è in potenza (Cum enim materia, inquantum huiusmodi, sit in potentia), così l’agente, in quanto tale, è in atto (agens, inquantum huiusmodi, est in actu). E quindi il primo principio attivo deve essere attuale al massimo grado (oportet maxime esse in actu) e per conseguenza sommamente perfetto, perché un essere è detto perfetto in proporzione della sua attualità (Secundum hoc enim dicitur aliquid esse perfectum, secundum quod est actu); perfetta infatti è detta quella cosa alla quale non manca niente (cui nihil deest) avuto riguardo al grado della sua perfezione. [S. Tommaso d’Aquino: La Somma Teologica – Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1969 – I, q. 4, a. 1 – pagg. 120-123]
Il Nonessere è l’inattuale in sommo grado: questa è la sua “potenza”, il non essere in atto, cioè essere in potenza. L’impotenza del Nonessere è lo sgabello sul quale l’Essere sale per poter farsi vedere. «Il Nonessere sì, che è mite e umile i cuore – pensava Lui – altro che Matteo 11,29: “imparate da me, che sono mite e umile di cuore”…».
Tutti dicevano che Lui era vecchio dentro, che quel suo nichilismo l’aveva reso quasi anacronistico, antiquato, fuori del mondo… e già – pensava Lui – sarà perché il mio Dio è il Nonessere? ‘Colui che non è,’ l’inattuale, ‘Colui che non è in atto’. Per il cristianismo, chi non è in atto, non è. Ma, pensando a Tommaso d’Aquino, quando dice che la materia, in quanto tale, è in potenza, a Lui veniva da dire che allora il Nonessere è la Materia dell’Essere: la sua materia prima; e, forse, in questo senso Lui crea ex nihilo: perché senza il nihil del Nonessere, non avrebbe saputo da dove estrarre le sue preziose materie ontologiche.
Lui si fermò un istante: la ridda di pensieri, facendo ressa, gli impediva di mettere a punto una terminologia adeguata; il non essere che non è più non si può scrivere come quello che non è mai stato, pensava. «Poco fa ho pensato: il Nonessere è “sinistro” perché è passato… invece no: quello che è passato è il non-essere, non il Nonessere». Un conto è il non essere di chi non è mai nato (= Nonessere) ed un altro il non essere di chi è morto (= non-essere): sono due forme di non essere diverse; tant’è che il cristianismo solamente al non-essere di chi è morto ha potuto dare l’alternativa di
- o essere (= essere vivo per sempre in Paradiso)
- o non-essere (= essere morto per sempre all’Inferno)
L’essere va prevenuto, non curato: infatti, una volta che c’è, lo si deve curare, e non si può sapere con certezza se la cura lo porterà alla guarigione della vita eterna o alla morte della morte eterna.
I cristiani usano la medicina della grazia divina, l’unico farmaco che il loro ricettario teologico preveda; non ci sono case farmaceutiche né rappresentanti farmaceutici, nella teologia cattolica: l’unico informatore farmaceutico è per i cristiani il Verbo del Padre, il Figlio di Dio, e l’unica medicina è la sua grazia. Agostino presenta il Cristo come medico e la grazia come medicina che risana; in Ep. 226,2 si legge poi che «non è una negazione della grazia l’affermare che essa è preceduta dalla volontà, la quale non fa altro che cercare il medico, ma non può far nulla da sola». Ma è nel Discorso contro Pelagio che Agostino dà fondo a questa metafora medica: «Il medico non sarebbe disceso se non ci fossero stati dei malati; la vita non sarebbe discesa se non ci fossero stati dei morti»; e ancora: «In noi dunque non c’era nulla di sano. Scese il medico a curarci nel corpo e nell’anima, essendo egli il salvatore del corpo e dell’anima. I nostri medici infatti possono curare le persone che essi non hanno creato. Se pertanto un medico-uomo cura usando cose create da Dio, quanto più Dio sarà in grado di guarire con rimedi suoi? Inoltre, il medico cura un uomo che finirà col morire.». Si capisce bene dove vuole arrivare, il vescovo di Ippona: vuole arrivare a dire che Pelagio sbaglia, perché «nessun uomo può conseguire la salvezza con i suoi meriti personali e con le sue proprie forze».
Dio, il Primario dell’«Ospedale Terra», ha passato tutto il periodo cosiddetto ‘prima di Cristo’, quello compreso tra l’Eden e l’anno zero, a fare la diagnosi della malattia umana causata dalla ‘mela del male’, poi, a diagnosi terminata, ha pensato che il rimedio migliore per far guarire l’umanità fosse l’incarnazione, e quindi ha mandato suo Figlio, dopodiché, come Primario, ha ritenuto il suo compito concluso; il corpo e il sangue di Suo Figlio sono la medicina che Lui ha prescritto agli umani per la salvezza, cioè perché gli esseri umani potessero evitare la morte eterna, la seconda morte, quella al di là. Praticamente, il Creatore trova la medicina, e, se le sue creature non faranno i capricci e la prenderanno, tale medicina sortirà l’effetto sperato, in caso contrario, Lui non potrà assumersi in alcun modo la responsabilità della prognosi. Questa, in sintesi, la cartella clinica dell’umanità.
Il decorso della malattia dipende dai pazienti: in questo senso gli umani sono artefici del proprio destino. «Ma – pensava Lui – la possibilità della malattia dipese dalla Creazione: se da una parte il Creatore non è la Causa Prima della malattia in atto, dall’altra Egli è pur certamente la causa della malattia stessa in potenza». Lui pensava ad Auschwitz, a Mauthausen e a tutto quanto l’orribile mysterium iniquitatis causato dal nazismo: sicuramente i nazisti furono la causa di quel mysterium, e in questo senso è giusto pensare ad un Inferno che li incarceri eternamente per la loro pena capitale, ma Lui, in questa questione, amava risalire più a monte: «Lo scandalo non è solo nella causa al di qua, in questo o in quel nazista che rese attuale il male: è anche nella Causa al di là. Il Male è innanzitutto nella Creazione, nel Male che sicuramente l’onniscienza creatrice pensò come possibile nell’atto stesso in cui creava; il Creatore è responsabile della possibilità del Male, mentre la creatura è solo responsabile della realtà di questo male. Creatore e creatura possono essere complici». Lui pensava:
Non è vero che Dio è innocente, la responsabilità della Causa Prima sta nella Creazione del Male Possibile: nella Creazione della Possibilità del Male che il Creatore, in quanto onnisciente, non poteva certo non conoscere. La responsabiltà della creatura consiste nel rendere attuale la Possibilità del Male compiendolo di fatto in ogni atto più o meno malvagio. La creatura è solo causa seconda del male, il Creatore ne è la Causa Prima.
Al di qua, la responsabilità se la deve assumere chi occupa un posto di maggiore responsabilità, come appunto si dice, cioè chi è più in su nella scala gerarchica. Al di là? Non funziona così? Due pesi e due misure? Il Creatore, se vuole essere il Principale dell’Universo, il suo Principio e la sua Causa Prima, deve assumersi la responsabilità di Tutto il Male, visto che è Lui ad averlo ordito in potenza nel Suo atto creatore, ad averlo tramato nella Sua Possibilità.
Chi è più colpevole? Colui che rende possibile il Male o colui che lo rende reale? La creatura è solo un esecutore materiale, ma il “mandante” è il Creatore: la possibilità è la mente, l’atto è il braccio. La teologia dice che il Creatore è Atto Puro – agens, inquantum huiusmodi, est in actu – ma quando c’è da prendersi la colpa di un atto “impuro”, allora se la svigna, si nasconde dietro la gonna della potenza (sempre ammesso che la potenza abbia la gonna) e lascia che sia la creatura ad assumersi tutta la responsabilità dei Suoi Atti Puri. Lui fa il puro in atto quando questo atto è ancora in potenza: facile! Il braccio e la mente sono la creatura e il Creatore: se tutto va bene, la mente si prende il merito del Bene, se qualcosa va male, la mente declina la colpa del Male.
Dopo tutto questo “ginnasio” noetico, Lui addivenì al motto fondamentale della questione, la frase che compendiava forse in sé la differenza specifica tra creare e causare, e la scrisse in centro al suo cervello, nel grassetto rosso che lo caratterizzava:
la creazione fu soltanto una buona intenzione
Ecco qua. La creazione fu il buon proponimento di dare alla materia in potenza la possibilità di realizzarsi in atti concreti: di effettuarsi in atto. «Tommaso d’Aquino ci teneva tanto, ad usare i due strumenti concettuali più famosi di Aristotele, atto e potenza, ed io starò al gioco: anch’io discuterò la tesi creazionista cavalcando atto e potenza», si disse Lui.
Il nostro Principale concepì l’intendimento creatore pensandone la causa finale in termini di attuazione demandata al creato stesso. «Il progetto creatore fu veramente un ‘progetto gettato’ – si diceva Lui pensando ad Heidegger –: la geworfenheit, la gettatezza dell’essere gettato, è il werfen, il lanciare la possibilità nella realtà». Nella possibilità c’è Tutto: il Bene e il Male. Quando si getta la possibilità nella realtà, lo si deve mettere in conto, che si può andare incontro a Tutto. Ma è curioso che il Creatore, Atto Puro, non crei una realtà in atto. L’Atto Puro crea la possibilità della realtà nella materia in potenza. Per dirlo in termini heideggeriani, l’Essere, Atto Puro, lancia se stesso nella possibilità del «ci»: nella possibilità di esser-ci.
Nella sua Ricerca sull’intelletto umano, Hume, trattando di Libertà e Necessità, scrisse:
…se le azioni volontarie (voluntary actions) fossero soggette alla stessa legge di necessità (lows of necessity) come le operazioni della materia (operations of matter), vi sarebbe una catena di cause necessarie continuata (a continued chain of necessary causes), preordinata e predeterminata (pre-ordained and pre-determined) che andrebbe dalla causa originale di tutto (the original cause of all) ad ogni singola volizione di ciascuna creatura umana. Non vi sarebbe contingenza (contingency) in alcun punto dell’universo; non vi sarebbe indifferenza né libertà (no indifference; no liberty). Mentre agiamo, saremmo, nello stesso tempo, agiti (While we act, we are, at the same time, acted upon). L’autore ultimo (The ultimate Author) di tutte le nostre volizioni sarebbe il Creatore del mondo (the Creator of the world), che per primo diede il movimento a quest’immensa macchina (immnense machine) e pose tutti gli esseri in quella particolare posizione, dalla quale deve risultare, con inevitabile necessità, ogni evento successivo. Le azioni umane, perciò, o non possono essere in alcun modo moralmente turpi, in quanto procedono da una causa così buona (from so good a cause); o, se sono per qualche riguardo turpi devo coinvolgere nella stessa colpa il nostro Creatore, finché si ammette che Egli è la loro causa ultima ed il loro autore (ultimate cause and author). [Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – a cura di Mario Dal Pra – pagg. 153-155]
Infatti, se la Causa Prima, creando, avesse “causato” la realtà già tutta in atto – come Tutta in atto è Lei stessa – la necessità di ogni «azione & re-azione» avrebbe eliminato qualunque traccia di libertà: ci sarebbero state solo connessioni necessarie e non congiunzioni libere.
In uno dei corridoi dell’ospedale, Qualcuno si lamentava con un altro: aveva scoperto di essere un ‘portatore sano’ di AIDS: era omosessuale. A Lui venne in mente Romani 1,26-32:
«…Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa.»
«Gli autori di tali cose meritano la morte», οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, qui talia agunt, digni sunt morte.
Lui pensava: «Si capisce, che la Chiesa non vada tanto a genio, agli omosessuali, con quello che ha scritto Paolo!». Poi andò verso quel ‘portatore sano’ (= PS) e gli disse:
LUI: Coraggio, si consoli: guardi, in qualche modo, lei è come l’intenzione creatrice.
PS: Cosa?
LUI: Sì, l’intenzione creatrice aveva l’HIV: Human Immunodeficiency Virus, il virus dell’immunodeficienza umana.
PS: Mi prende in giro?
LUI: No, anzi: la ‘sindrome da immunodeficienza acquisita’, la cosiddetta AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome – altro non è che l’attuazione dell’immunodeficienza.
PS: Ma cosa dice?
LUI: Oh, niente di particolare, stavo riflettendo sulla creazione divina e lei mi ha fatto venire in mente che, a ben vedere, l’intenzione creatrice era immunodeficiente.
PS: Lei è un filosofo?
LUI: Mah, sa, siamo tutti filosofi, quando ci mettiamo a pensare…
PS: Complimenti, ma mi spieghi, visto che ci siamo.
LUI: È una questione di anticorpi. La Creazione fu una buona intenzione, ma la sua attuazione ad opera della creatura umana non era esente dall’infezione virale del male; il mal comune, la malattia infettiva del male, nasce dalla deficienza insita nella possibilità: il deficit di anticorpi.
PS: I medici mi hanno detto che ‘portatore sano’ è un individuo che ospita microrganismi patogeni senza presentare alcuna sintomatologia morbosa, e pare che io sia un portatore sano di AIDS. Non ho sintomi ma sono un potenziale pericolo per coloro con i quali ho rapporti.
LUI: Anche la Creazione fu un potenziale pericolo, e infatti, non appena gli esseri umani ebbero rapporti con altre creature, il virus si diffuse: che altro è, il peccato originale, se non una trasmissione virale?
PS: Ah, il peccato originale, ma lei ci crede, a queste cose? Sa, a me la chiesa non è che piaccia tanto, per il suo atteggiamento verso di noi, omosessuali.
LUI: Già, comunque, io credo solo alla sofferenza umana, alla passione e morte dell’uomo, e mi sforzo di trovare un antidoto che possa definitivamente guarire l’umanità da tutte le sue malattie.
PS: Mi auguro che lei ci riesca, a trovare un tale antidoto, ma ho i miei dubbi…
LUI: …i dubbi dipendono solo dal fatto che gli umani non sono disposti a lasciarsi vaccinare. Ma lasciamo stare.
PS: Sono preoccupato per il mio ragazzo, anzi, glielo presento, è lui.
LUI: Piacere.
PS: Non ama parlare, il mio amore… è un po’ come i personaggi muti delle rappresentazioni teatrali, glielo dico sempre, io.
LUI: Quando non si ha niente da dire è meglio tacere: è saggio, il suo compagno.
PS: Sì, ma, certe volte, avrei piacere di un po’ di conforto, come adesso, che ho paura di trasmettergli il mio virus.
LUI: Il concetto di trasmissione virale è quello di attuazione potenziale: realizzazione di una possibilità. L’immunità può essere causa ed effetto della mancanza di responsabilità: se uno sapesse di poter fare qualunque cosa senza tema di incorrere nel male, significherebbe che tutto ciò che fa è bene, e potrebbe fare il male senza presagirne i sintomi; solo il Creatore, se è vero che esiste, è immune dal male, e per questo può permettersi di essere libero di fare ciò che vuole, sapendo a priori che tutto ciò che farà sarà comunque bene.
PS: Comunque vada sarà un successo, eh, per Dio? Conosce Piotta?
LUI: No, chi è?
PS: Quel rapper italiano che nel 1998 uscì con il suo primo album in studio, intitolato appunto Comunque vada sarà un successo, ma non c’entra niente, scusi; è che, quando lei mi parlava dell’immunità di Dio, a me è venuto in mente che per Lui, comunque vada, sarà sempre un successo: qualunque cosa faccia, non sbaglia mai.
LUI: Sì, ha ragione, non è fuori luogo questa sua osservazione. Dio, “lanciando la possibilità”, si riserva la possibilità di dover lanciare anche qualche maledizione, prima fra tutte quella che lanciò ad Adamo ed Eva dopo il primo peccato: quella maledizione fu la causa dell’«assunzione di responsabilità» alla quale l’uomo fu condannato, da allora egli fu costretto a dover sempre scegliere tra Bene e Male – così dice la chiesa. Può scegliere solo chi “ha presente” ciò tra cui deve scegliere: io credo che la metafora dell’albero del bene e del male con annesso carptum malum, sia proprio l’aver scelto di “avere presente” cos’è il bene e cos’è il male; una volta fatta questa scelta, una volta che male e bene sono lì davanti, non si è più immuni: si ha il munus, cioè l’obbligo, di scegliere. «Im-mune» è colui che non ha il munus della scelta, il munus optionis. Questa è l’opzione fondamentale della libertà umana: il munus optionis.
PS: E poi dicono che Dio è munifico…
LUI: «Munifico», innanzitutto, non è termine che faccia riferimento all’essere generoso e liberale di qualcuno, esso si riferisce innanzitutto a munia «i doveri» e a facĕre «fare», per cui, propriamente, ‘munifico’ è colui «che compie i doveri della propria carica».
PS: Quindi, lei vuol dire che, dal peccato originale in poi, l’uomo è “munifico” solo se e in quanto compie il proprio dovere umano; il dovere di scegliere, o quale altro è, il dovere dell’uomo?
LUI: Appunto: il dovere di scegliere, il dover sempre scegliere. La carica umana è la sua volontà, la soma che l’essere umana si porta addosso da quando scelse la possibilità di scegliere. Genesi 2,17: «dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire», ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ, de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas. Vede, che è un problema gnoseologico? Il frutto proibito è quello τοῦ γινώσκειν, del conoscere: scegliendo di poter scegliere, l’uomo optò per la facoltà di giudizio, alla tedesca, das Urteil, cioè la possibilità originale (= ur) di separare (= teilen) nella διάκρισις (= separazione) del διακρίνειν, cioè del pensare dia-logicamente ogni κρίσις, ogni giudizio possibile nel κρίνειν, che è il pendant greco del latino cerno, donde la «cernita».
PS: Lei mi sopravvaluta: pensa che io conosca greco, latino e tedesco?
LUI: Ma no, guardi, nemmeno io so il latino, il greco e nemmeno il tedesco, solo, cerco di conoscere i vocaboli fondamentali della mia ricerca e, soprattutto, cerco di considerare i testi in lingua originale.
PS: Ha ragione, è così che si dovrebbe fare. Lei mi sembra molto credente…
LUI: Assolutamente no: sono a-gnostico, sono uno che sa di non sapere, che sa di non conoscere, nel senso che io ricerco ciò che è ἂγνωστος, sconosciuto, per vedere se mi riesce di rendermelo conoscibile, ma mi astengo dal professare la fede in una γνῶσις qualsiasi; io cerco di conoscere tutto senza credere mai in una conoscenza. Sono solo un ricercatore.
PS: Va bene, e tuttavia, se lo lasci dire, lei tradisce una grande apprensione per la sorte degli esseri umani, con questo suo far spesso riferimento a realtà metafisiche, oltremondane…
LUI: La mia unica apprensione è per coloro che la teologia cattolica definisce «dannati»; mi ci metto in mezzo anch’io: io per primo ho paura dell’Inferno, perché la minaccia di una morte eterna è qualcosa di terribile.
PS: Ma lasci stare, lasci stare quello che dice la chiesa…
LUI: …non ci riesco: mi hanno insegnato quella verità, o, meglio, mi hanno detto che quella è la verità, e quindi io faccio sempre i conti con quella, pur combattendola e rifiutandomi di crederle, perché è spaventosamente inquietante, credere ad una morte eterna.
PS: Effettivamente, se fosse vero…
LUI: Il Creatore non ha il diritto, di punire eternamente coloro che incapparono nella possibilità del male; il male era una delle possibilità insite nell’intenzione creatrice, e non è giusto dare l’ergastolo eterno a chi non ha fatto altro che realizzare quella possibilità.
PS: Vuol dire che lei è per l’abolizione delle pene ai delinquenti?
LUI: No, proprio no: io, al di qua, sono un garantista assai intransigente: chi ha sbagliato deve pagare; al di qua ne sono convinto. Ma al di là… la pena eterna al di là mi sembra ingiusta perché la responsabilità della colpa, considerata in primo grado, è del Creatore, non della creatura: il ricorso in appello dell’appellatio umana è un diritto sacrosanto. La creatura deve, a mio parere, impugnare la sentenza divina e appellare (= accusare) il Creatore appellandosi all’attenuante della causa seconda: la creatura è solo causa seconda del male, perché, in quanto esecutore materiale della possibilità prospettata dal “mandato creatore”, non può essere responsabile in eterno di un atto malvagio; in primis, colpevole è chi ha “dato” la possibilità, cioè chi ha posto in essere tale possibilità, chi ha creato la possibilità stessa: colui che l’ha realizzata non è che un secondino, un correo, un corresponsabile. Nell’individuazione della colpa è cosa buona e giusta risalire a chi sta al vertice della scala gerarchica, in questo caso, il Creatore. Sub specie aeternitatis, il condono è d’obbligo: l’assoluzione finale ce la deve, il Creatore, dal momento che ha deciso, creando, di mettere in conto il Bene e il Male; questo “mettere in conto” invalida il rendiconto finale e la resa dei conti del dies rationis:
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
La remissione dei peccati è un donum che il Creatore deve dare per forza a tutti, ce lo deve per dono: è Lui che ha sbagliato, innanzitutto.
PS: Interessante. Ma, se la sentisse un prete! Non mi pare che sia molto ortodossa, questa sua teoria.
LUI: Bene e Male, in quanto merito e colpa, sono già l’esito esistenziale della creazione della Possibilità ontologica; a monte della responsabilità umana c’è la consapevolezza divina che la sua “scienza” sarebbe diventata co-scienza: una scienza, un sapere condiviso. La prescienza divina fu Scienza della Possibilità di andare scientemente incontro alla Coscienza dell’Impossiblità, dell’impossibilità divina di evitare il peggio.
PS: Molto interessante.
LUI: In nome della Coscienza dell’Impossibilità, della sua impossiblità, della sua impotenza, il Creatore non ha il potere di punire eternamente coloro che finirono nell’impossibilità di fare il bene.
PS: Al liceo avevo studiato l’intellettualismo socratico, cioè, se ben ricordo, la sicurezza socratica che il bene, se lo si conosce lo si fa. Mi sembra che questa sua teoria della Coscienza dell’Impossibilità divina somigli, per qualche verso, alla coscienza platonica del bene.
LUI: Forse. In effetti, io credo che al di qua, in ultima analisi, chi fa il male lo fa perché non è perfettamente a conoscenza del bene. Credo cioè che un’esatta conoscenza del bene eviterebbe ogni male: la conoscenza del bene e del male che secondo la Genesi l’uomo avrebbe acquisito carpendo il malum, non è conoscenza perfetta del bene o del male, quindi, una pena perfetta, completa, eterna, non è comminabile, da parte di Dio, a chi al di qua ha commesso il male, foss’anche il peggiore dei mali.
PS: Apocatastasi, si chiama così, no?
LUI: Sì, la “chiusura” dell’Inferno alla fine dei tempi; la salvezza per tutti.
PS: Sarebbe bello…
LUI: …se così non fosse, all’umanità resterebbe solo una possibilità, per salvarsi: la desistenza. Se non possiamo sfuggire a Dio, possiamo però legargli le mani, metterlo nella condizione di non poter fare più nulla, né di bene né di male: la desistenza annulla ogni ulteriore attuazione della Possibilità creatrice impedendo a Dio di dover condannare alla morte eterna chi è reo solo della colpa di aver realizzato la parte cattiva di tale Possibilità, impedendo che altri finiscano all’Inferno. Se non possiamo chiudere l’Inferno, perché non ne abbiamo le chiavi, possiamo però chiudere nel senso di escludere la possibilità futura della dannazione.
PS: Cos’è, la desistenza?
Lui glissò quest’ultima domanda, un po’ perché il dialogo con quel ‘Portatore Sano’ era andato bene e sarebbe stato un peccato rovinare tutto, e un po’ perché la risposta sarebbe stata sicuramente contestata: raramente trovava Qualcuno disposto ad accettare la desistenza: quando ne parlava, Tutti si allontanavano inorriditi pensando di aver a che fare con un pazzo. Nessuno voleva saperne. Quando lo sentivano parlare di desistenza, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un’altra volta… Atti 17,32: Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un’altra volta».
Quel ‘portatore sano’ dall’oggi al domani avrebbe potuto diventare un portatore malato, questo pensava, Lui. Ognuno di noi porta in grembo la possibilità di un male conclamato: un portatore sano è un malato in potenza. Portare in grembo è gestare: ci siamo lasciati fecondare dal seme del Male ed ora ne siamo incinta; siamo tutti gestanti, gravidi di conseguenze. Il Bene inseminò la materia e la materia si lasciò inseminare dal Male; la Materia, puttana, messa incinta dal Bene contro la sua volontà, si lasciò mettere incinta dal Male di propria spontanea volontà. Prima o poi diventiamo tutti genitori di figli non desiderati, noi, che siamo i figli desiderati dal Padre nostro che è nei cieli. La nostra gravidanza è gemellare, e il nostro parto sarà gemellare: partoriremo carne colpevole e carne innocente; carne per una resurrezione di vita e carne per una resurrezione di morte. La carne colpevole Lui ce la farà morire per sempre, Lui che ci ha così tanto desiderati! La buona intenzione creatrice di Dio era una portatrice sana, ma è durata poco, questa sua sanità.
Per questo gli faceva pena, quel portatore sano, perché era il simbolo di tutta la creazione, e per questo Lui ne provava compassione. Mentre compativa, pensava che era la compassione a fargli desiderare la desistenza, e subito il suo pensiero andò a Nietzsche:
Precisamente qui vedevo il grande pericolo dell’umanità, la sua più sublime tentazione e seduzione – verso che cosa poi? Verso il nulla? – precisamente qui vedevo il principio della fine, il momento dell’arresto, la stanchezza che volge indietro lo sguardo, la volontà che si rivolta contro la vita, l’ultima malattia che dolcemente e melanconicamente si annuncia: vidi nella morale della compassione, che si andava estendendo sempre di più, che aggranfiava e ammaliava persino i filosofi, il sintomo più inquietante della nostra cultura europea, divenuta inquietante, forse il suo tortuoso cammino verso un nuovo buddhismo? Verso un buddhismo europeo? Verso il – nichilismo?… [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prefazione – pagg. 7-8]
«Nietzsche mi direbbe che io desidero la desistenza perché la mia compassione per chi è in vita è diventata ormai tale e tanta da farmi negare la vita stessa», pensava Lui. E così provò a fare una “genealogia della desistenza”, così, giusto per vedere se gli riusciva di individuare le cause della sua Weltanschauung.
Lui si trovava d’accordo con Nietzsche solo su una cosa: la valutazione dell’essere-bene, dell’essere-che-è-bene-che-sia, l’ontologia dell’essere come valore supremo, era una figlia bastardina della morale; Lui era d’accordo con Nietzsche,
…sul fatto che fino a oggi non si è neppure avuto il minimo dubbio o la minima esitazione nello stabilire «il buono» come superiore, in valore, al «malvagio», superiore in valore nel senso di un avanzamento, di una utilità, di una prosperità in rapporto all’uomo in generale (compreso l’avvenire dell’uomo). Come? e se la verità fosse il contrario? [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prefazione – pag. 9]
ma non è che fosse d’accordo con Nietzsche sul fatto che la compassione è un valore morale sbagliato perché impedisce al debole di soccombere, bensì nel senso che impedisce al forte, cioè all’Essere, di prevaricare: la bontà della desistenza nasce dalla compassione per i deboli ma è ‘buona’ non tanto perché aiuta i deboli a sopravvivere, quanto piuttosto perché aiuta i forti a rafforzare i deboli nella convinzione che solamente quando al di qua non nasceranno né più figli dell’Uomo, al di là non nasceranno né moriranno più figli di Dio.
La sopravvivenza che la desistenza vuole impedire è quella ‘sopra’, appunto: la “vivenza” al di là; ma per impedirla deve impedire la sottovivenza: la “vivenza” al di qua. La desistenza è – per dirla con Nietzsche – la volontà che si rivolta contro la vita al di là: non è brama di voluntas nullius rei = noluntas ma voluntas nullius vitae = nonesse. «Il vitalismo eroico e nazionalistico che nel XX secolo ha portato alla nascita dei totalitarismi – pensava Lui – è figlio della condanna nietzschiana della compassione. Il capostipite dell’albero genealogico della morale è la Causa Prima intesa come Essere-Bene». Malattia, per Nietzsche, è la debolezza di chi incolpa la forza di essere “cattiva”.
Che gli agnelli nutrano avversione per i grandi uccelli rapaci, è un fatto che non sorprende: solo che non v’è in ciò alcun motivo per rimproverare ai grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli agnellini. E se gli agnelli si vanno dicendo tra loro: «Questi rapaci sono malvagi; e chi è il meno possibile uccello rapace, anzi il suo opposto, un agnello – non dovrebbe forse essere buono?» su questa maniera di erigere un ideale non ci sarebbe nulla da ridire, salvo il fatto che gli uccelli rapaci guarderanno a tutto ciò con un certo scherno e si diranno forse: «Con loro non ce l’abbiamo affatto noi, con questi buoni agnelli; addirittura li amiamo: nulla è più saporito d’un tenero agnello». Pretendere dalla forza che non si estrinsechi come forza, che non sia un voler sopraffare, un voler abbattere, un voler signoreggiare, una sete di nemici e di opposizioni e di trionfi, è precisamente così assurdo come pretendere dalla debolezza che si estrinsechi come forza. Un quantum di forza è esattamente un tale quantum di istinti, di volontà, d’attività – anzi esso non è precisamente null’altro che questi istinti, questa volontà, quest’attività stessa… [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prima dissertazione, § 13 – pagg. 33-34]
Friedrich Nietzsche: 1844/1900. Adolf Hitler: 1889/1945. Hitler nacque 45 anni dopo la nascita di Nietzsche e morì 45 anni dopo la morte di Nietzsche. Nel 1945, poi, anno della morte di Hitler, finì la seconda guerra mondiale: sembra che questo numero, 45, abbia qualche significato cabalistico che unisce misteriosamente i due… Si tende a tacciare di dilettantismo e di superficialità chi si azzarda a paragoni troppo vincolanti tra il pensiero del filosofo di Röcken e l’opera del dittatore di Braunau, ma – pensava Lui – a me pare che l’elogio nietzschiano della forza dei grandi uccelli rapaci e la legittimazione “giusnaturalistica” del loro infierire sui deboli e miti agnellini, per farne strage, sia molto vicino all’elogio della razza ariana tentato da Hitler.
…se gli oppressi, i conculcati, i soggiogati, mossi dall’astuzia, avida di vendetta, dell’impotenza, si inducono a dire: «Dobbiamo essere diversi dai malvagi, cioè buoni! E buono è chiunque non usa violenza, non reca danno a nessuno, non aggredisce, non fa rappresaglia, rimette a Dio la vendetta, si tiene, come noi, nascosto, fugge ogni malvagità e al pari di noi, gente paziente, umile e giusta, pretende poche cose dalla vita», tutto ciò, se lo si ascolta freddamente e senza prevenzioni, in verità non vuol dire altro che: «Noi deboli siamo decisamente deboli: è bene se non facciamo alcuna cosa per la quale non si è forti abbastanza»; ma questo crudo stato di fatto, questa prudenza d’infimo rango, che posseggono persino gl’insetti (i quali, in caso di grande pericolo, si fingono morti per non far nulla «di troppo»), grazie a quell’arte da falsari e a quella mendacità dinanzi a se stessi che è propria dell’impotenza, si dà il pomposo travestimento della virtù rinunciataria, silenziosa, aspettante, come se la debolezza stessa del debole – vale a dire la sua essenza, la sua produttività, la sua intera, unica, inevitabile, irredimibile realtà fosse un effetto arbitrario, qualcosa di voluto, di scelto, un’azione, un merito. [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prima dissertazione, § 13 – pag. 35]
Secondo Nietzsche, l’impotenza dei deboli è elevata a virtù da una morale della compassione che in realtà è fomentata dai deboli stessi: se la compassione diventa virtù, la debolezza diventa merito e così i deboli hanno meno da temere, dai forti, perché possono sempre sperare che qualcuno di essi si converta e la smetta di infierire su di loro.
A Lui veniva in mente Seconda ai Corinzi 12,9-10: …egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte.
La differenza tra Lui e questi due personaggi, Nietzsche e Paolo di Tarso, era che per Lui né la forza né la debolezza erano valori degni di essere considerati virtù: la forza di Nietzsche è la virtus (= forza) di sopraffazione dei forti e la debolezza di Paolo è la virtus (= capacità) di sottomissione dei deboli; entrambe non sono virtù: non è virtù la prima perché il valore dei forti è violenza sui deboli, e non è virtù la seconda, perché il valore dei deboli è sopportazione di tale violenza. «Prepotenza è la virtù dei forti e impotenza è la virtù dei deboli – pensava Lui: entrambe sono virtù inique. La virtù vera dell’essere umano si colloca nel mezzo, tra prepotenza e impotenza: in medio stat virtus: virtus virtutis», e si faceva mentalmente questa tabella:
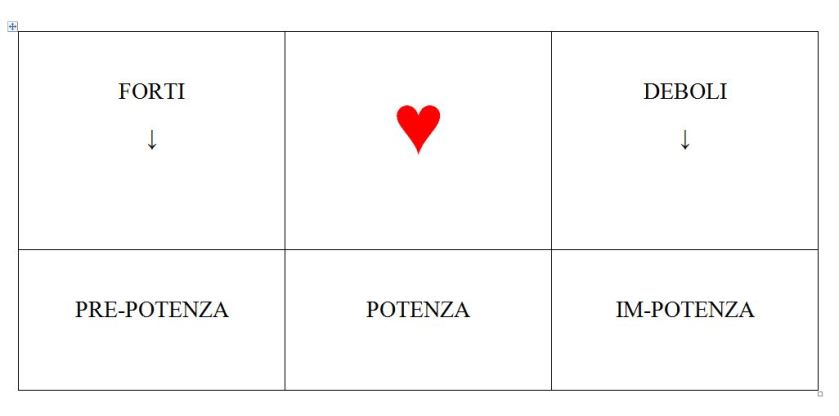
E, tra la virtù dei forti e quella dei deboli, Lui metteva in mezzo un bel cuore rosso, a significare tutta la compassione amorevole che provava per l’umanità. «L’amore vero per l’umanità sta in mezzo – pensava –, è questa la vera virtù dei forti: la pazienza del paziente», e finiva la frase così, lasciando in sospeso l’interpretazione della parola «paziente»: chi ha pazienza? chi è malato?
Essere affetti da malattia è essere pazienti: la malattia agisce e il paziente subisce; spesso la pazienza è proprio quella di chi sopporta con forza la malattia. Ma, a ben vedere, tutto ciò «che è» si può veramente dire, con Platone, che sia “capacità” di agire o patire:
«Affermo dunque che ciò che possiede per sua costituzione naturale una capacità (δύναμιν) di qualunque tipo, riguardante o l’agire (ποιεῖν) su una qualunque altra cosa o il patire (παθεῖν) anche qualcosa di minimo da parte della cosa più insignificante, fosse pure per una volta sola, tutto questo, realmente, è (πᾶν τοῦτο ὄντως εἶναι); stabilisco infatti che si debba porre come determinazione distintiva (ὅρον ὁρίζειν), che le cose che sono altro non sono se non capacità (τὰ ὄντα ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναμις)». [Platone: Sofista – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2008 – traduzione di Bruno Centrone – 247d-e – pagg.145-147]
«Peccato che – pensava Lui – una cosa, se agisce, fa patire la cosa su cui agisce, e, se subisce, patisce la cosa che agisce su di essa: in qualunque caso c’è qualcosa che subisce e patisce un’azione. Le due categorie di ACTIO & PASSIO sono legate a doppia mandata: quando c’è qualcuno che agisce c’è sempre qualcun altro che subisce. Se per ‘essere’ si è costretti ad accettare l’idea che qualcuno debba per forza patire, la pazienza come virtù dei forti è una bufala!». Era l’accettazione del dolore, che lo scandalizzava. «Di questo mi accuserebbe, Nietzsche, di fondare la mia speranza desistenziale sul rifiuto della sofferenza…». E mentre pensava questo, gli parve di sentire la voce di Nietzsche:
NIETZSCHE: Ora che la sofferenza deve sempre mettersi in mostra come il primo degli argomenti contro l’esistenza, come il suo peggior punto interrogativo, si farà bene a ricordarsi dei tempi in cui opposto era il nostro giudizio, poiché non si voleva fare a meno di suscitar dolore e si vedeva in ciò una magia di prim’ordine, una vera e propria esca di seduzione alla vita.
LUI: Federico, sei sempre il solito: sei così innamorato della vita da accettare tutto, di lei! Sai cosa ho sempre pensato, di te? che tutta la tua filosofia non sia nient’altro che una re-azione all’azione potente che la malattia ha avuto sul tuo fisico: a te è sempre mancata la salute, diciàmocela tutta, dài, e per questo hai fatto di tutta la tua filosofia un grande inno alla vita salutare, la vita dei forti, dei robusti: hai fatto diventare filosofia ciò che ti è sempre mancato, la salute. Ma non la vedi la sofferenza, in questo ospedale? E pensi che una volta le cose andassero meglio? Il mondo è sempre stato un ospedale pieno di pazienti che soffrono.
NIETZSCHE: Forse allora – sia detto a consolazione dei delicati – il dolore non faceva ancora così male come oggi; per lo meno potrà giungere a questa conclusione un medico il quale abbia curato negri (prendendo questi come rappresentanti dell’uomo preistorico –) in gravi casi di infiammazione interna, che portano alle soglie della disperazione anche l’europeo della miglior complessione organica – questo non succede nei negri.
LUI: Dài, Federico… Ma cosa ne fai, adesso, una questione di razza? Li hai visti i films di Rambo? Ti sarebbero piaciuti! Sai, lì avresti potuto vedere Sylvester Stallone nel tripudio della forza fisica e della salute, sprezzante del dolore… non è un negro, Stallone, ma comunque non ti avrebbe deluso: guàrdali, i suoi films! Ma, comunque, tu credi veramente che l’umanità, in tempi passati, tollerasse il dolore più di noi?
NIETZSCHE: La curva della tolleranza umana al dolore sembra scendere in realtà straordinariamente e quasi all’improvviso, non appena si abbia dietro di sé i primi diecimila o dieci milioni di individui di una civiltà superiore; e quanto a me non ho alcun dubbio che, a paragone di una notte di dolore di una sola isterica donnetta letterata, le sofferenza di tutti gli animali insieme, i quali sono stati fino a oggi interrogati col coltello ai fini di scientifiche risposte, non vanno semplicemente prese in considerazione.
LUI: Se lo dici tu… tendi a mettere in relazione la civiltà con la mollezza, con la debolezza. Hai passato la vita a escogitare filosofemi sofisticatissimi e al contempo anche a sognare di non ben precisate epoche in cui l’assenza del “pensiero debole” era sintomo di salute. Certe volte mi sembri sadico: sembra che tu voglia difendere a tutti i costi uno stato animale disumano in cui il giusto e il bene sono il diritto dei più forti di spadroneggiare sui più deboli. Pensi veramente che l’uomo forte sia quello che prova piacere nel godere delle disgrazie altrui, cioè dei più deboli di lui?
NIETZSCHE: Forse è persino lecito ammettere la possibilità che anche quel piacere della crudeltà non debba essere propriamente estinto: esso avrebbe solo bisogno di una certa sublimazione e assottigliamento, in relazione al fatto che oggi il dolore fa più male…
LUI: …sicuramente a me il dolore fa male. A te no? Tu, il 3 gennaio 1889, all’età di 45 anni, proprio qui a Torino, avesti la tua prima crisi di follia in pubblico: era lo stesso anno in cui nacque Hitler (sarebbe nato di lì a tre mesi, il 20 aprile 1889) e forse i vostri destini erano in qualche modo legati; tu sei impazzito lasciando che un altro portasse avanti il tuo pensiero in piena lucidità… la tua pazzia è stata raccolta da Hitler e tu sei finito in manicomio… la maledizione del numero 45 è caduta su di voi: tu sei nato 45 anni prima di Hitler, e lui è morto 45 anni dopo di te… Ehi, Federico, non mi rispondi più?
Lui si era sognato tutto: ancora una volta si era seduto su una delle tante panchine che si trovano nelle corsie degli ospedali, e, come spesso gli succedeva, aveva fatto delle grandi anime dei defunti i suoi interlocutori preferiti, in quello speciale dormiveglia che è la meditazione filosofica. Si svegliò quando passò un internista, un medico internista che, guarda caso, stava parlando con un suo collega proprio di Nietzsche: stava mettendo in risalto il fatto che il filosofo tedesco auspicava una più stretta collaborazione tra medicina e filosofia, convinto com’era che, alla luce di una interpretazione fisiologica, l’indagine sui valori cosiddetti ‘morali’ avrebbe trovato una chiarificazione maggiore, e via discorrendo… «Sai, – diceva quell’internista al collega – sai che Nietzsche faceva derivare la parola ‘male’ dal greco μέλας? Hai fatto anche tu il “classico”, in gioventù, quindi lo sai, caro collega, che μέλας μέλαινα μέλαν vuol dire ‘nero’: malus e μέλας avrebbero, per Nietzsche, la stessa origine etimologica…».
I due parlavano passeggiando, e quindi, una volta allontanatisi, Lui non poté sentire il seguito del discorso, ma non ne aveva bisogno, perché sapeva dove stava andando a parare quell’internista: Nietzsche sosteneva che l’«uomo nero», in quanto «individuo dal colore scuro», è l’uomo volgare, quello che «per il colore della pelle si distaccava, con la massima evidenza, dalla bionda razza dominante, cioè quella ariana dei conquistatori», parole testuali; insomma, Nietzsche sosteneva che è un dato storico: «il termine distintivo dell’aristocrazia e infine il buono, nobile, puro» sono originariamente il “buono”, che ha «la testa bionda in antitesi agli scuri abitanti primevi dai capelli neri». Nietzsche ne faceva una questione di ‘melanina’, parola che viene appunto dal greco μέλας.
«La genealogia della morale di Nietzsche sembra piuttosto una “genealogia della razza” – pensava Lui – ma io non credo che noi si possa venire a capo dell’albero genealogico del male cercandone il capostipite con un’indagine di tipo razziale, per non dire razzista. È un losco figuro, quel Nietzsche, somiglia al Càllicle del Gorgia platonico». A Lui non era mai piaciuta, la fanatica intransigenza morale di Socrate, con quel suo ossessionante imperativo, fondamentalista, di obbedire alle Leggi dello Stato, come se fossero vangelo, quelle leggi… però, a onor del vero, nemmeno gli piaceva la squallida figura di Càllicle, che, nel Gorgia, Platone fa dialogare con Socrate.
Socrate sostiene che commettere ingiustizia è più brutto del subire ingiustizia, ma Càllicle, in quanto rappresentante dell’oligarchia e della nobiltà ateniese, la pensa in modo completamente diverso, rispetto a Socrate. I due poli entro i quali si svolge il dibattito sono il bello per natura (φύσει) e il bello per legge (νόμῳ), intendendo per “bello” quel καλός καλή καλόν che, insieme a ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν forma il sintagma della virtù come sinolo di «bello e buono»; Nietzsche, in fondo, parla di Càllicle, quando scrive che sono stati «i nobili, i potenti, gli uomini di condizione superiore e di elevato sentire ad avere avvertito e determinato se stessi e le loro azioni come buoni, cioè di prim’ordine, e in contrasto a tutto quanto è ignobile e d’ignobile sentire, volgare e plebeo»: i ‘buoni’ sono i nobili aristocratici, quelli che pensano, come Càllicle, che «per natura è più brutto (αἴσχιον) tutto ciò che è anche peggiore (κάκιον), ad esempio il subire ingiustizia»; la legge del più forte è quella che per natura è “buona a” far subire piuttosto che a far sì che uno patisca il subire. Ma spesso le leggi le fanno i deboli per difendersi dai forti: in Gorgia 483 [b] Càllicle professa, ante litteram, questo credo nietzschiano (o nietzscheano? o nicciano? o niciano?):
Credo del resto che coloro i quali stabiliscono le leggi siano gli uomini deboli (ἀσθενεῖς ἄντρωποι), i più (οἱ πολλοί). Guardando a se stessi e al proprio vantaggio, infatti, stabiliscono le leggi, e dispensano lodi, e scagliano invettive: con l’intenzione di spaventare i più forti tra gli uomini (τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων), capaci di avere di più, affinché non abbiano più di loro, dicono che l’avere di più è brutto e ingiusto (αἰσχρὸν καὶ ἄδικον), e che questo è il commettere ingiustizia, cercare di avere più degli altri; dà loro piacere, credo, la possiblità di avere in egual misura pur essendo del tutto inferiori (φαυλότεροι). [Platone: Gorgia – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2014 – traduzione di Federico M. Petrucci – 483 b &c – pag. 133]
È interessante notare come la medicina abbia preso ἡ ἀσθένεια e ne abbia fatto l’«astenìa»: mancanza o perdita di forza dell’intero organismo o dei suoi singoli apparati e organi; – pensava Lui –: alfa privativo di τὸ σθένος, «la forza»: ἀ + σθένεια = a-stenia. Gli ἀσθενεῖς ἄντρωποι di Callicle sono gli uomini deboli, quegli stessi a-stenici che Nietzsche chiama “agnelli” nel passo sopraccitato dalla Genealogia della morale. Càllicle, sofista greco del V secolo a.C. individua il “giusto” per natura nella forza, ἡ ῥωμη, di cui il forte, ἐρρωμένος, è detentore. I deboli sono uomini “da poco”, secondo l’etimo di φαῦλος, che indica nella φαυλότης quella mediocrità che è anche cattiva condizione di salute e, in ultima istanza, vizio.
Càllicle:
«…è giusto che il più valente (ἀμείνω) abbia di più del peggiore (χείρονος) e chi ha maggiori capacità di chi ne è più sprovvisto. In numerosi contesti, infatti, essa chiarisce che le cose stanno in questi termini, sia tra gli animali sia nella totalità delle città e delle stirpi degli uomini: il giusto si distingue da sempre in questi termini, il superiore comanda l’inferiore (τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος ἄρχειν) e ha più di questo». [Platone: Gorgia – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2014 – traduzione di Federico M. Petrucci – 483 d – pag. 133]
La forza, τὸ κράτος, nella lingua italiana si trova in quel suffisso, -crazìa, che origina parole come demo-crazia (forza, potere, del popolo), e dà al κρατύς, al forte, il potere, ἡ ἀρχή, che permette di comandare, ἄρχειν. La «-crazìa», il potere, del forte, è il comando dell’aristo-crazia, il governo degli ἄριστοι, i «migliori» per eccellenza di nascita e per privilegio di ricchezza, di cui Càllicle è esponente esemplare.
Il filologo Nietzsche, grecista competente, ha presente questa teoria della “volontà di potenza” calliclea, quando scrive che
Il pathos della nobiltà e della distanza, il perdurante e dominante sentimento fondamentale e totale di una superiore schiatta egemonica in rapporto a una schiatta inferiore, a un «sotto» – è questa l’origine dell’opposizione tra «buono» e «cattivo». (Il diritto signorile di imporre nomi si estende così lontano che ci si potrebbe permettere di concepire l’origine stessa del linguaggio come un’estrinsecazione di potenza da parte di coloro che esercitano il dominio: costoro dicono «questo è questo e questo», costoro impongono con una parola il suggello definitivo a ogni cosa e a ogni evento e in tal modo, per così dire, se ne appropriano). [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Seconda dissertazione, § 2 – pag. 15]
Poco dopo, lo stesso Nietzsche:
Credo mi sia consentito interpretare il latino bonus come «il guerriero»: posto che a buon diritto riconduco bonus a un più antico duonus (confronta bellum = duellum = duen-lum, in cui mi sembra sia conservato quel duonus). Bonus, quindi, come uomo della disputa, della disunione (duo), come guerriero: si vede quel che nell’antica Roma costituiva in un uomo la sua «bontà». [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prima dissertazione, § 5 – pag. 19]
«Ma che coraggio! – pensava Lui – che coraggio ha avuto, Federico, malaticcio e debole com’era di complessione, a definire “buono” il più forte: sarebbe stato il primo a soccombere, quel poveretto, se avesse dovuto saggiare la propria “bontà” confrontandola con quella dei suoi ἄριστοι: avrebbe scoperto che loro, essendo più “buoni” di lui, potevano tranquillamente farlo fuori, perché è giusto che il più “buono” elimini il meno “buono”!».
Cos’è, «il giusto proprio della natura?», τὸ τῆς φύσεως δίκαιον… Lui pensava alle beatitudini evangeliche: «beati i miti», «beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno», ma soprattutto pensava a Luca 6,27-35:
…amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
«Amate i vostri nemici», diligite inimicos vestros, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. La dilectio cristiana, ἡ ἀγάπη, impone ciò che la morale nicciano-calliclea esclude a priori; tra l’altro – pensava Lui – il cristianesimo non ha fatto altro che perfezionare e portare a termine quella “paideia” socratica sulla quale Callicle ironizza polemicamente in Gorgia 483-484: «…noi plasmiamo gli eccellenti (τοὺς βελτίστους) e i più forti (ἐρρωμενεστάτους) tra noi prendendoli fin da bambini, come leoni (ὥσπερ λέοντας), e incantandoli e stregandoli li riduciamo a schiavi (καταδουλούμεθα) a forza di dire che bisogna avere tutti in egual misura, che questo è il bello e il giusto (τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον)». La morale “rincoglionisce”: questo dice Callicle, in parole povere.
La conclusione, efferata, di Càllicle, non lascia luogo a dubbi:
Ma qualora, credo, nascesse un uomo dotato di una natura abbastanza forte, d’un tratto si scuoterebbe via di dosso tutto questo, e lo distruggerebbe e se ne libererebbe, calpesterebbe le nostre scritture e le formule magiche e gli incanti e tutte le leggi contrarie alla natura, e rialzandosi lo schiavo si farebbe luminosamente nostro padrone, e risplenderebbe così accecante il giusto proprio della natura. [Platone: Gorgia – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2014 – traduzione di Federico M. Petrucci – 484 a & b – pag. 135]
«Il giusto proprio della natura», τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. «La morte è la vittoria finale nella guerra che le malattie ci fanno finché siamo in vita, – pensava Lui –; la morte potrebbe allora a buon diritto definirsi ‘ciò che è più giusto’, per natura, dal momento che è essa a sconfiggere definitivamente la debolezza naturale di un paziente, è essa a dare la vittoria ai morbi che ammorbano il nostro corpo; la morte è la forza più potente, visto che nessuna vita resta in vita, quando arriva lei: la medicina può vincere qualche battaglia, ma la guerra la vince sempre la morte». Per questo, nella guerra, chi fugge vince, pensava Lui ricordando il vecchio adagio: nella guerra d’amor, chi fugge vince.
Lui odiava il dolore, la sofferenza, ma non principalmente la sua: odiava innanzitutto la sofferenza degli altri, e per questo riteneva sommamente fortunati coloro che ancora non erano nati. Ecco, si potrebbe dire che l’auspicio della desistenza nasceva in Lui da una sorta di “universalizzazione” della sofferenza, sì che essa era diventata una vera e propria legge universale della condizione umana. Lui non pensava mai solo a se stesso: in ogni momento della sua giornata si pensava sempre come parte di un Tutto, l’umanità, e, se anche gioiva di qualche cosa, subito con il pensiero andava a coloro che in quello stesso momento, al contrario, soffrivano. Pensava che un bilancio onesto, ma, soprattutto, giusto, della condizione umana si potesse fare solamente cercando di tenere presente sempre e comunque tutte le condizioni dei vari uomini sparsi sulla faccia della terra. Se gli capitava di fare l’amore, non lo faceva mai senza pensare che in quello stesso momento, in qualche parte del mondo, una donna era violentata. Se si gustava un gelato, non se lo gustava mai senza pensare che, in quello stesso momento, qualcuno stava morendo di fame. Qualunque cosa facesse, Lui la metteva su un piatto della bilancia, e sull’altro ci metteva tutte le cose omologhe che capitavano agli altri esseri umani mentre Lui faceva quella cosa: ovviamente, la bilancia pendeva sempre dalla parte dei meno fortunati.
«Non è vero che il Bene e il Male pesano allo stesso modo – pensava –, e per convincersene basta notare quanto rumore faccia il male e quanto poco ne faccia il bene». Per rumore, Lui intendeva “sensazione”: voleva dire che il male fa sensazione, il bene no. Il male fa colpo, il bene no. E poi, quando parlava di peso specifico del male, si riferiva a quella che chiamava ‘Bilancia Ontologica’: su di un piatto c’è l’essere di un essere umano, e sull’altro c’è l’essere di tutti gli altri esseri umani. «Il bilancio degli esseri umani, – diceva –, va fatto sempre in questo modo: mettendo su un piatto se stessi e sull’altro tutti gli altri. È chiaro che, bilanciando la condizione umana in questo modo, e partendo dal presupposto che il bene faccia sempre “buon peso”, come si dice, cioè che non pesi affatto, la bilancia penderà sempre verso il male di tutti gli altri.
Più volte gli era capitato, nella vita, quando Lui cominciava a parlare di desistenza, che Tutti gli dicessero:
TUTTI: Oh, dài, smettila, con queste sofferenze dell’umanità! Sì, vabbè, è vero che in questa vita c’è qualche dolore, ma ci sono anche molte gioie, no?
LUI: Sì, sì… e voi credete che queste gioie pesino come i dolori?
TUTTI: Ma cosa vuol dire: “pesino”?
LUI: Mi avete consigliato un day hospital ontologico affinché io imparassi a vedere la vita come la vedete voi… ebbene, io ho visto che ad ogni paziente il dolore della propria malattia pesa, mentre non pesa affatto la salute ritrovata, che permette a quello stesso paziente di tornarsene a casa.
TUTTI: E per forza, vorrai mica che adesso anche la salute si metta a far male?
LUI: A me interessa ciò che fa male, perché di ciò che fa star bene non è il caso di occuparsi: stare bene fa bene, come si dice.
TUTTI: Cosa intendi, per “non è il caso di occuparsi”?
LUI: Ditemi: cos’è che si deve curare: la salute o la malattia?
TUTTI: Dài, è ovvio: la malattia; e allora?
LUI: E allora è altrettanto ovvio che curarsi della malattia è occuparsi di essa. La salute non pre-occupa, la malattia sì.
TUTTI: E allora?
LUI: E allora è di ciò che preoccupa, che si deve occupare l’uomo. Ora, nel quadro generale della felicità umana, dovendo pesare bene tutte le pre-occupazioni e tutte le occupazioni, emerge un bilancio che poco depone a favore di detta felicità. In ospedale io mi sono confermato ancor di più nell’idea che un bilancio equilibrato della felicità umana è quasi completamente sbilanciato a favore della disperazione.
TUTTI: Sei il solito pessimista.
LUI: Lo sapete, ve l’ho detto più volte, che per me il pessimismo è la “copertura” letteraria e romanzata che fa da alibi al reato del mal comune, il quale ultimo è l’unica storia vera che la letteratura romanza racconta; con Hume, io non sono pessimista proprio perché tolgo all’impression del mal comune tutti i fronzoli noetici e ideali che lo anestetizzano, quei fronzoli di cui voi vi stordite chiacchierando.
TUTTI: E quindi? Dovremmo forse suicidarci in massa?
LUI: No! Per carità, non fatemi dire una cosa del genere, ché non la penso! No! piuttosto, dovremmo cominciare a pensare di educare la gente alla desistenza.
TUTTI: Ancora con questa desistenza! Basta! Non se ne può più! Ma come fai a credere che un giorno tutti si convincano che è giusto non fare più figli? Tu sei matto!
LUI: Siete molo più matti voi, ché credete giusto continuare a far figli per poterli dare in pasto al mal comune.
TUTTI: Tu vivi fuori del mondo. Non si può ragionare, con te…
LUI: Credo sia per questo, che volete continuare a far figli: per poter continuare a ragionare tra di voi, tra voi e i vostri figli, intendo, del mal comune che vi affligge e che vi guardate bene dal nominare, non è così? Il vero matto è quello che si mette a ragionare da solo di cose delle quali non si deve parlare con nessuno, lo capisco; ma, forse, grazie alla follia di quei matti, un giorno, nessuno dovrà più stare a ragionare sul mal comune.
TUTTI: Niente da fare: non vuoi mettere la testa a partito.
LUI: Perché vedo che ogni vivente è a mal partito.
TUTTI: Quando non sai più cosa dire, giochi con le parole, fai sempre così. Credi di poterti salvare con qualche gioco di parole?
LUI: Io preferisco giocare con le parole, piuttosto che con i figli, perché i figli, prima o poi, quando hanno imparato bene a parlare, devono smettere di giocare.
TUTTI: Tu, invece, nel momento in cui hai incominciato a poter parlare, subito hai smesso, per poter giocarci, con quelle parole, che agli altri servono a parlare, a parlare di cose serie…
LUI: …serie, certo: come le occupazioni che servono a fugare le preoccupazioni del mal comune… è di questa serietà, che parlate, voi? o sbaglio?
Non sbagliava. Tutti ci godevano, del mal comune, o, meglio, godevano nel parlarne senza nominarlo: è un’arte, saper parlare di qualcosa senza pronunciarla mai – pensava Lui –: è l’arte di perpetuare ciò di cui ci si lamenta per potersene, appunto, ancora e sempre lamentare». Certe volte gli sembrava che Nietzsche, quel pazzo, avesse ragione: «Veder soffrire fa bene, cagionare la sofferenza ancor meglio – è questa una dura sentenza, eppure un’antica, possente, umana – troppo umana sentenza fondamentale…». Robe da matti! Quando pensava che quel pazzo furioso era su tutti i libri di filosofia, in tutti i programmi scolastici, a Lui veniva la pelle d’oca. La “catena” genealogica che, per Nietzsche, unisce male, colpa e debito alla sofferenza è allucinante; lui osserva, dall’alto di una certa erudizione compiaciuta, che una volta, su un debitore che non può pagare, un creditore aveva il diritto di rivalersi “facendogliela pagare” – come si dice – corporalmente: facendolo cioè soffrire fisicamente affinché il piacere procuratogli dalla sofferenza del debitore potesse compensare, per così dire, lo scompenso provocato dal debito insoluto. Al riguardo, le frasi seguenti fanno rabbrividire:
Rendiamoci chiara la logica di tutta questa forma di compensazione: è abbastanza bizzarra. L’equivalenza è data dal fatto che al posto di un vantaggio in diretto equilibrio con il danno (al posto dunque di una compensazione in denaro, terra, possessi di qualsivoglia specie) viene concessa al creditore a titolo di rimborso e di compensazione una sorta di soddisfazione intima – la soddisfazione di poter scatenare senza alcuno scrupolo la propria potenza su un essere impotente, la voluttà «de faire le mal pour le plaisir de le faire», il piacere di far violenza: piacere che come tale risulta apprezzato in misura tanto più alta quanto più bassa e umile è la condizione del creditore nell’ordinamento della società, e che può facilmente apparirgli come un boccone prelibato, anzi come pregustazione di un rango più alto. [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Seconda dissertazione, § 5 – pag. 53]
Il “filosofo” fa addirittura nostalgicamente notare una curiosa realtà bel tempo andato, che era ed è, secondo lui, un dato di fatto: «senza crudeltà non v’è festa: così insegna la più antica, la più lunga storia dell’uomo – e anche nella pena v’è tanta aria di festa!». Per citare ancora una volta il Càllicle gorgiano, c’è una frase che puzza di sadismo tanto quanto quella nicciana appena citata: «Un simile uomo – se posso usare un’espressione forse eccessivamente rozza – lo si può prendere a pugni in faccia senza scontare la giusta pena!»; Càllicle si riferisce a coloro che cercano di far diventare “miti ed umili di cuore” quei leoncelli che, naturalmente, sarebbero invece nati per diventare leoni e per scatenare sulle prede più deboli tutta la loro legittima volontà di potenza.
A Lui non piaceva né il mezzo gaudio nietzschiano né il mezzo gaudio cristiano: quello nicciano gli pareva… – come dire? –… troppo “maschile”; e quello cristiano, forse, per così dire, troppo “femminile”. Ad essere cattivo, gli veniva anzi persino da pensare che la femminilità della ‘Buona Novella’ fosse confermata dal fatto che in chiesa ci andavano per lo più delle donne, tante femmine e pochi maschi. «Probabilmente – pensava Lui – sono donne che desiderano refrigerare un po’ nella “volontà di impotenza” cristiana l’eccessivo calore erotico della penetrante “volontà di potenza” dei loro maschi», ma non è detto. «Però – pensava – scherzi a parte, se è giusto che la fisiologia debba collaborare di più con la filosofia, se volessimo cioè dar credito a questo strambo desiderio niciano, forse…» e s’inventava questo dialogo, tra la ‘Volontà di Potenza’ (= P) e la ‘Volontà di Impotenza’ (= I):
P: Io “vengo” prima di te.
I: Perché sei poco spirituale.
P: No, perché sono più concreto.
I: O forse perché, per natura, non sai aspettare.
P: E tu, invece, che sai aspettare? sei riuscita a spostare così avanti nel tempo le tue aspettative che le hai fatte “finire” al di là…
I: Di che parli?
P: Dell’orgasmo che vai fantasticando al di là, in Paradiso. Guarda che si può “venire” anche al di qua, senza procrastinare troppo.
I: Di qua “vieni” solo per pochi secondi, mentre di là “vieni” per sempre.
P: Eccolo qua, il tuo solito “maranathà”.
I: Non bestemmiare.
P: E chi bestemmia? dico solo che tu riesci a godere al di là perché, per natura, “vieni” sempre dopo di me.
I: Almeno io non soffro di ejaculatio praecox.
P: Non ne soffri perché sei platonica.
I: Già, e tu ne soffri perché sei nietzschiano!
Gli piaceva così tanto, questo dialogo breve tra la Potenza e l’Impotenza, che pensò di proporne la recita a qualche paziente: magari Lui avrebbe fatto la Potenza, e il paziente l’Impotenza; o viceversa, era lo stesso: avrebbe anche fatto la parte dell’impotente, pur di divertirsi nel recitarlo. Poi, però, non se ne fece niente, perché Lui, conoscendo come la pensavano Tutti, pensò che Nessuno si sarebbe divertito, e specialmente da malato, a recitare una roba del genere; per non dire anche che forse Nessuno l’avrebbe capito: lo si sarebbe dovuto prima spiegare, ma così la cosa sarebbe diventata troppo complicata, per cui, meglio lasciar stare.
«È il fallo, il problema – pensava Lui –: l’uomo è sempre in fallo, da quando il peccato originale l’ha fatto diventare una testa di cazzo». A stare in ospedale, a continuo contatto con il mal comune, stava diventando comune anche Lui, “volgare”, uno come Tutti. «Ma guarda un po’ – pensava – mi hanno consigliato questa giornata in ospedale affinché io potessi scoprire il mezzo gaudio, e invece sto scoprendo le miserie umane in tutta la loro volgarità: è pieno di gente che dice parolacce, qui; il mal comune fa sproloquiare. Il mal comune, però, se lo merita, il turpiloquio: non è turpe, parlar male di lui; è uno sporco bastardo, e con gli sporchi bastardi si deve parlare sporco: e che? Ci mettiamo a fare i fini con i grossolani, adesso?».
Lui veniva da una famiglia borghese. Era stato educato rigorosamente, e il suo Super-io era stato rimpinzato di dover-essere fino a scoppiare: per questo ora, in ospedale, scoppiava. Buona educazione, buone maniere, studio, senso del dovere… Casa sua era praticamente una biblioteca; comprava una quantità enorme di libri, perché il sapere era lo scudo che frapponeva tra sé e gli altri: a casa sua Lui studiava la realtà esterna filtrandola con le categorie nobili del sapere; vedeva tutto sub specie cognitionis. «Non ha cognizione, la gente», diceva sempre; ma, questa espressione, dalle sue parti, significava: ‘non ha giudizio, la gente’. Avere cognizione non è sapere tante cose, avere una cultura sterminata, è innanzitutto vedere il mal comune senza gli occhiali del perbenismo, senza le categorie del ben-essere. Il perbenismo peggiore è quello ontologico: quello di chi vuol credere e far credere nell’essere-bene dell’essere. Il Super-io, Über-ich, è la protuberanza cresciuta sull’Es del mal comune: il mezzo gaudio del Super-io è il carapace dell’Id, la duplicatura del mal comune, lo scudo lapìdeo che protegge dalla brutalità di ciò che la vita è in sostanza. Il Super-io è il «possente errore» leopardiano della “favola bella” che infiora e abbellisce il letame implicito nel sostrato biologico. Il Super-io è l’eufemismo con cui si dice il sottinteso della sconcezza ad esso sottesa: la chiacchiera patrizia che copre la plebea vergogna dell’osceno.
In ospedale la vita pulsava in tutto il suo realismo, cioè nella volgarità. Una cosa insopportabile, pensava Lui nella sua aristocratica superiorità, è questo uso continuo della genitalità che molta gente fa per esprimere la propria tiritera di contumelie e improperi; il massimo della stizza e del disappunto umano nei confronti del mal comune evacua innanzitutto e perlopiù in un’unica, comune, espettorazione: «cazzo!». È un simbolismo fallico, quello a cui la nostra cultura ha affidato la catarsi del mal comune. Da un’indagine risulta che l’organo sessuale maschile ha 1047 sinonimi (40 in più della vagina) per esprimere i concetti più disparati: dalla forza – cazzuto – all’imbecillità – cazzone –.
Se «cadere in fallo» è «cadere in errore», significa che «fallo» è parola la cui azione non rimanda solo all’atto sessuale: «fallare», infatti, non vuol dire «scopare», bensì «sbagliare». Lui vedeva, in questa recondita empatia terminologica un segno del fatto che fare sesso è essenzialmente fare un errore, beninteso, solo nel caso in cui questo “fare” sia procreativo. In Genesi 3,16 Dio disse ad Eva:
«Moltiplicherò i tuoi dolori
e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ed egli ti dominerà».
A Lui questo passo della bibbia sembrava la prova provata del fatto che la procreazione era l’effetto primo del fallo originale: il peccato. Ne La somma teologica, Tommaso d’Aquino, a un certo punto (I, q. 98, a. 2), si mette persino a trattare la questione «se nello stato di innocenza la generazione sarebbe avvenuta mediante coito», utrum in statu innocentiae fuisset generatio per coitum (!), e conclude che sì, sarebbe avvenuta mediante coito. Agostino invece, assai più cattolico di Tommaso, a detta di quest’ultimo, sosteneva che «i progenitori non avrebbero avuto la copula nel Paradiso Terrestre, perché, poco dopo la formazione della donna, ne furono espulsi per il peccato; oppure perché attendevano l’ordine dall’alto, che ne determinasse il tempo, poiché da Dio ne avevano ricevuto un comando generico». Agostino è il principale sostenitore del fallo come errore e nel De civitate Dei difende la verità edenica mostrandola con queste parole, ancora tratte da La somma teologica tommasiana:
…in quello stato il marito si sarebbe unito alla moglie senza comprometterne l’integrità (nulla corruptione integritatis). Infatti il germe virile poteva allora introdursi nell’utero della donna, rimanendo intatto il setto verginale (salva integritate feminei genitalis), allo stesso modo che ora resta intatta tale integrità, nonostante il flusso delle mestruazioni dall’utero della vergine. Come infatti l’impulso della maturità (maturitatis impulsus), non il gemito del dolore (doloris gemitus), avrebbe aperto le viscere della donna per il parto, così l’uso volontario (voluntarius usus), non l’appetito libidinoso (non libidinis appetitus), avrebbe congiunto le due nature per l’atto del concepimento. [S. Tommaso d’Aquino: La somma teologica – Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992 – I, q. 98, a. 2 – pagg. 302-303]
La verità (indolore) della procreazione è per Agostino caratterizzata da
- voluntarius usus (in entrata)
- maturitatis impulsus (in uscita)
mentre l’errore post edenico è, di contro:
- libidinis appetitus (in entrata)
- doloris gemitus (in uscita)
cioè, pare di capire che, per Agostino, prima del peccato originale, il gemitus doloris del parto – cioè del bimbo in uscita – non c’era, ma un innocuo maturitatis impulsus avrebbe fatto uscire il frutto a maturità conseguita, come avviene quando una mela cade naturalmente da un albero.
Nella sua camera da letto, Lui aveva tutti i 33 volumi della Somma dell’Angelico Dottore, con testo latino a fronte, nella prestigiosa edizione ‘Studio Domenicano’: 33 più i due volumi di Introduzione e Indice generale: 33 + 2 = 35 volumi, che troneggiavano davanti al suo letto, su un secrétaire, come pietra miliare di quella verità cattolica che i salesiani gli avevano inculcato nel Super-io negli anni in cui ogni cosa che si impara non si leva più di torno. Però, nella sua biblioteca, non mancava La città di Dio agostiniana, e, siccome Tommaso aveva citato proprio quella, Lui andò a vedersi la citazione nell’originale, che l’editrice ‘Città Nuova’ aveva pubblicato nel 1997:
…il marito poteva unirsi alla moglie senza lo stimolo sensuale della vampa lussuriosa nella serenità dell’anima e senza la perdita dell’integrità del corpo. È una esperienza che oggi non si può più verificare. Però si deve ritenere che se non un turbolento ardore agitava quegli organi ma li usava, come converrebbe, un volontario dominio, anche così il seme virile poté esser calato nell’utero della moglie, salva l’integrità dell’organo femminile. Anche oggi, salva l’integrità dell’utero di una ragazza, viene emesso il flusso mestruale di sangue. Identico è il percorso con cui il seme viene immesso, il flusso emesso. Come infatti per il parto non il gemito di dolore ma il pieno sviluppo del feto avrebbe allargato l’utero della donna, così per la fecondazione e il concepimento non lo stimolo libidinoso ma un atto della volontà avrebbe congiunto i due sessi. [Agostino: La città di Dio – Città Nuova, Roma 1997 – traduzione di Domenico Gentili – XIV, 26 – pagg. 733-734]
Insomma, la donna restava incinta senza perdere la verginità (= integrità dell’utero) e la copulazione avveniva senza libidine, con un «sereno atto di volontà»: niente libidine in entrata e niente doglia in uscita. «Quando il ‘fallo’ non era ancora un ‘errore’ – pensava Lui –, le femmine non provavano il doloris gemitus dell’uscita fetale, né i maschi provavano il libidinis appetitus dell’entrata fallica: fu la pena inflitta dal Creatore dopo il fallo originale, a causare alle coppiette la voglia e la doglia».
Il fallo è diventato errore in seguito alla grande maledizione edenica che ci ha gettato in questa «valle di lacrime», come ben recita la preghiera del Salve Regina; siamo un progetto edenico gettato per terra dall’autore stesso del progetto. Siamo gementes et flentes in hac lacrimarum valle da quando ci è toccato l’esilio terreno. «Certo che fa effetto, pensare che la verità procreativa è quella senza né voglia né doglia – si diceva Lui sottovoce –, pensare che la voglia e la doglia sono il frutto di un peccato, di un errore, di un fallo. Lo dicevo, io, che il male non è normale; però… sembra che nemmeno il piacere sia normale…».
Quell’Agostino! Sul tetro albero della sua teologia sono appollaiati, come avvoltoi, tutti i rimorsi di coloro che per colpa sua, si sono sentiti colpevoli di godere della voglia e di dolere della doglia. Il XIV Libro de La città di Dio è micidiale – pensava Lui –, basta leggere cosa c’è scritto, proprio in apertura, sul fallo originale:
Il genere umano non era destinato alla morte di ciascun individuo se i primi due, di cui l’uomo non proveniva da altro individuo, la donna da lui, non l’avessero meritata a causa della disobbedienza. In tal modo fu commesso da loro un così grande peccato che la natura umana incorse nella depravazione (in deterius eo natura mutaretur humana), perché furono trasmessi anche ai posteri la soggezione al peccato e il destino della morte. Il potere della morte prevalse a tal punto da sospingere per la dovuta pena nell’abisso della seconda morte, che non ha fine, tutti gli uomini se la non dovuta grazia di Dio non ne avesse liberato un certo numero. [Agostino: La città di Dio – Città Nuova, Roma 1997 – traduzione di Domenico Gentili – XIV, 1 – pag. 684]
Mortis autem regnum in homines usque adeo dominatum est, ut omnes in secundam quoque mortem, cuius nullus est finis, poena debita praecipites ageret, nisi inde quosdam indebita Dei gratia liberaret.
In secundam mortem, cuius nullus est finis… A Lui proprio non andava giù, che l’indebita (= non dovuta) grazia del Creatore salvasse dalla debita (= dovuta) seconda morte solo «un certo numero» di persone, quosdam. Il pronome indefinito quidam quaedam quoddam cominciava a non sopportarlo più. «Perché non Tutti? Perché solo Qualcuno? – pensava Lui – O Tutti o Nessuno!».
Apocalisse 20:
1E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell’Abisso e una grande catena. 2Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per mille anni; 3lo gettò nell’Abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei mille anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po’ di tempo. 4Poi vidi alcuni troni – a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare – e le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; 5gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. 6Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per mille anni. 7Quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere 8e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magòg, e radunarle per la guerra: il loro numero è come la sabbia del mare. 9Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l’accampamento dei santi e la città amata. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. 10E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 11E vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. 12E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. 13Il mare restituì i morti che esso custodiva, la Morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. 14Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. 15E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco.
Il fallo originale causò la prima morte e il perseverare in questo fallo è quell’errare diabolicum che causerà la seconda morte: la morte eterna. Al termine di XIV 3, Agostino dice che il Diavolo «è stato infatti il primo a mentire e da chi ebbe origine il peccato ebbe origine anche la menzogna», Primus est quippe mentitus, et a quo peccatum, ab illo coepit esse mendacium.
Il mendàcio. «Non vivere secondo la norma con cui si è ordinati a vivere, questo appunto è la menzogna», hoc est mendacium. Vivere secundum veritatem è per Agostino vivere secondo Dio (= secondo lo spirito) e non secondo l’uomo (= secondo la carne). Omne peccatum est mendacium. La natura della carne, carnis natura, nel suo genere e ordine, è buona: in genere atque ordine suo bona est. «Chi è cattivo, non lo è per essenza, ma per difetto», Et quoniam nemo natura, sed quisquis malus est, vitio malus est.
«Basta sacrificare altra carne umana al dio Mòloch – pensava Lui – facendo riferimento all’antica divinità cananea, cui venivano sacrificate vittime umane nella valle di Hinnom (Geenna) presso Gerusalemme». Non Tutti sanno che la cosiddetta Geènna prende il nome da una valle a sud-ovest delle porte di Gerusalemme, oggi detta Wādī er-Rabābī, che fu segnata di anatema dal re Giosia per essere divenuta sede del culto di Moloch, che imponeva la pratica di bruciare in olocausto i bimbi dopo averli sgozzati. La valle fu quindi adibita a scarico dei rifiuti della città e a luogo dove gettare le carogne delle bestie e i cadaveri insepolti dei delinquenti, che venivano bruciati per distruggere i resti e come elementare provvedimento d’igiene.
Nella Geènna il Cristo butta i suoi dannati. Matteo 10,28: «E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo»: il mendàcio. Dell’Essere innanzitutto. Il primato va sempre a Lui. L’antipaticissimo Agostino dice che «è possibile l’esistenza del bene senza il male», bona tamen sine malis esse possint, «non è possibile invece l’esistenza del male senza il bene», mala vero sine bonis esse non possint. Il Mendàce, Satana, è stato creato dal Bene e senza di esso non sarebbe nemmeno. Prima viene il Bene e poi il Male.
In altri passi Agostino si pronuncia a favore del primato dell’Essere, cioè del Bene:
…la natura ha l’essere per il fatto che è stata prodotta da Dio, ma defeziona dal suo essere per il fatto che è stata prodotta dal nulla. Ma l’uomo non defezionò al punto da divenire un nulla, ma in modo che ripiegato su se stesso fosse meno perfetto di quando era unito all’Essere sommo. Essere in se stesso dopo aver abbandonato Dio, cioè essere fine a se stessi, non è certamente essere un nulla ma accostarsi al nulla. [Agostino: La città di Dio – Città Nuova, Roma 1997 – traduzione di Domenico Gentili – XIV, 13 – pagg. 712-713]
Ac per hoc ut natura sit, ex eo habet quod a Deo facta est; ut autem ab eo quod est deficiat, ex hoc quod de nihilo facta est. Nec sic defecit homo, ut omnino nihil esset, sed ut inclinatus ad se ipsum minus esset, quam erat, cum ei qui summe est inhaerebat.
Lui passò un sacco di tempo perso in questi suoi pensieri, per cui in ospedale erano successe un mucchio di cose: per esempio, tre nascituri erano nati e tre morituri erano morti; la vita e la morte si succedevano come sempre, anche lì: morto un vivo, se ne faceva un altro. C’era poco da fare, Lui non sapeva fermarsi alla cronaca, nera o rosa, dei fatti che succedevano: dal fatto, subito saliva alla riflessione generale alla quale il fatto stesso aveva dava spunto e così i suoi pensieri si arrampicavano sulla piramide dell’induzione salendo, ansiosi ed ansimanti, alla terra promessa della definizione, dalla quale poi Lui si divertiva tantissimo a rotolare giù per via deduttiva onde vedere se l’induzione era corretta. Ogni particolare gli suggeriva un universale. «Ogni fatto di cronaca è la tessera di un puzzle – diceva –, tutto sta a cercare di capire qual è il puzzle alla quale la tessera appartiene».
E così, di tessera in tessera, il mosaico prendeva forma: fu così che gli parve di sentire un dialogo tra VERO e FALSO…
VERO: Comincio io, perché senza di me tu non saresti falso.
FALSO: Mentre senza di me tu continueresti ad essere vero, vero?
VERO: Vero: senza di me, tu non saresti, falso.
FALSO: Adesso l’hai detto in modo diverso. Prima avevi detto: «senza di me tu non saresti falso», adesso hai detto: «senza di me, tu non saresti, falso». Nel secondo modo, avresti dovuto scrivere: «senza di me, tu non saresti, Falso», come dire: senza di me tu non esisteresti, signor Falso; avresti dovuto chiamarmi per nome, dandomi la maiuscola che spetta ad ogni nome.
VERO: Senza di me tu non saresti e basta.
FALSO: Non sarei falso? O non sarei proprio?
VERO: Non c’è differenza.
FALSO: Eh, no, caro: non è vero, c’è eccome, differenza! Se mi chiami per nome mi riconosci un’esistenza autonoma. Se io sono Falso, allora sono il falso che ti rende Vero: sono un soggetto come te, il soggetto opposto a te. Se invece dici che io sono falso perché tu sei Vero, e tutto ciò che non è come te è falso, allora dici che io sono solo un aggettivo, un accidente della tua sostanza.
VERO: Se proprio vuoi sottilizzare, be’, allora sì: tu sei solo l’accidente che alla mia sostanza capitò quando l’uomo cominciò ad essere inclinatus ad se ipsum, come dice il mio Agostino.
FALSO: Il “tuo” Agostino? Fai bene a chiamarlo “tuo”: senza quelli come lui, tu non saresti Vero, ma solo vero. Se tu sei Vero, allora io sono falso; ma se io sono Falso, tu sei solo vero.
VERO: E che cosa, è vero?
FALSO: Per me, che tu sei vero perché io sono Falso.
VERO: E per me, che tu sei falso perché io sono Vero.
FALSO: Tu ti credi l’Essere di cui io sono solo una mancanza, vero?
VERO: Vero.
FALSO: Falso.
VERO: Senza di me, tu sei nulla.
FALSO: Per forza, tu ti credi l’Essere che ha creato Tutto ex nihilo!
VERO: Allora lo ammetti, di essere nulla?
FALSO: Non ammetto che tu sia l’Essere.
VERO: Io sono la verità dell’Essere.
FALSO: Appunto, tu non sei Lui.
VERO: E tu? cosa saresti?
FALSO: Se tu non sei l’Essere, io posso anche concederti di non essere.
VERO: Nel senso che saresti «la falsità del non–Essere»?
FALSO: Sì. Ma solo se tu ammetti di essere solo «la verità dell’Essere» e non l’Essere stesso in sé.
VERO: Qui dobbiamo deciderci: o tu sei la falsità del non–Essere e io sono l’Essere-che-è-vero, oppure io sono la verità dell’Essere e tu il Nonessere-che-è-falso.
FALSO: Se tu sei un accidente dell’Essere, è vero che io sono Falso. Se tu sei la sostanza dell’Essere, è vero che io sono falso.
VERO: Ti piacerebbe, eh, essere Falso?
FALSO: No, perché io non ci tengo, ad essere, come invece ci tieni tu.
VERO: Non è che io ci tenga, ad essere: io sono, perché sono vero e quindi è vero che sono.
FALSO: Appunto, tu sei vero, ma non Vero.
VERO: E tu sei falso, ma non Falso.
FALSO: Se tu sei un attributo dell’Essere non puoi escludere che io possa essere un attributo del Nonessere.
VERO: Il mio Signore dice che io non sono soltanto qualcosa che “si attribuisce” a Lui; dice che io sono Lui stesso: Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·
FALSO: Il mio Signore invece non dice che io sono Lui perché non parla, il mio Signore, se no lo direbbe. Non ama la chiacchiera, Lui.
VERO: Il mio Signore è Tutto, ed io sono Lui.
FALSO: Se è vero che tu sei Tutto, io sono nulla, ma siccome tu esisti solo da quanto il tuo Signore ti ha tratto da me, allora io sono il Nulla senza il quale tu non saresti punto.
VERO: L’Essere ha creato Tutto dal nulla, non dal Nulla, e ciò significa che l’Essere è e il Nulla non è.
FALSO: Se il Nulla non fosse, tu e il tuo Signore non potreste nemmeno dire ciò che disse il Vaticano I:
- Si quis non confiteatur, mundum resque omnes, quae in eo continentur, et spirituales et materiales secumdum totam sua substantiam a Deo ex nihilo esse productas; aut Deum dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed tam necessario creasse, quam necessario amat se ipsum; aut mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit: anathema sit.
E nemmeno in 2ª Maccabei 7,28 si potrebbe dire:
- Peto, nate, ut aspicias ad caelum et terram, et ad omnia quae in eis sunt: et intelligas, quia ex nihilo fecit illa Deus, et hominum genus.
Per poter dire che l’Essere ha creato Tutto dal nihil, bisogna che questo si possa appunto dire, ma per poterlo dire bisogna anche che il nihil sia «ciò che non è» l’Essere.
Se l’Essere può dire la creatio ex nihilo vuol dire che nihil dici potest e se il nulla si può dire, allora esso non è meno vero di te. Il Nulla: nell’istante in cui lo si dice ‘ciò di cui non si può dire nulla’, lo si è già detto.
VERO: Nihil tam absurde, dici potest!
FALSO: Credo quia absurdum.
A Lui piaceva far finire qui il dialogo, con questa frase attribuita a Tertulliano, credo quia absurdum, che il FALSO dice per mostrare falso ciò che il VERO pretende di dimostrare vero.
Lui pensava all’auspicio nietzscheano che la fisiologia potesse diventare una chiave interpretativa della filosofia, e allora gli venne in mente questo apporto per una Fisiologia dell’Ontologia: e se fosse la coscienza, a determinare la verità dell’essere? L’auspicio nietzscheano… ‘Auspicio’ (o auspizio): avis + spicio (specio) = guardo gli uccelli; è parola che viene dal sostantivo neutro latino auspicium, ii, formato come auspex (donde «auspice»): nell’antica Roma era la pratica della divinazione tratta dal volo degli uccelli, o, comunque da una osservazione a scopo divinatorio; ora, se l’augurio di Friedrich Nietzsche era quello che la filosofia prendesse gli auspici dalla fisiologia, Lui pensò di interpretare questo auspicio provando a sostenere che la verità metafisica dell’ontologia è essenzialmente il derivato di uno stato fisico, fisiologico: la coscienza.
Volendo farsi auspice di una lettura dell’essere che prendesse gli auspici dall’osservazione dello stato coscienziale, Lui ebbe il presagio che l’essere-male fosse probabilmente un auspicio di incoscienza. «Sembra l’uovo di Colombo – pensava – ma, e se la verità dell’Essere stesse nel nostro averne coscienza?». La divinatio dello stato di coscienza è ‘divinare’ come “in-divinare” (cfr. indovinare) il divinus che c’è nell’essere coscienti di essere; il filosofo, come divinatore dello stato coscienziale, è indovino del divino che c’è in esso: divinator.
Lui cominciò a pensare, alla Hume, che l’«essere cosciente» fosse uno stato fisico dalla cui impression fosse derivata l’idea di essere come essere-Coscienza: il thought della Coscienza. E, siccome «essere-cosciente» è sinonimo di «essere-in-salute», «essere-sano», forse il bene dell’essere trae la sua “moralità” dal moralismo fisiologico del suo essere appunto compos sui. Se poi essere compos sui è essere compos mentis, allora la capacità di intendere e di volere è il prerequisito di ogni valutazione ontologica, la quale ultima avrebbe come criterio di valutazione nient’altro che la capacità di un soggetto di essere cosciente, cioè di pensare. Nel suo poema Sulla Natura, Parmenide disse che pensare ed essere è la stessa cosa:
τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι
e Lui pensava che forse questa espressione parmenidea nascesse appunto da una concezione dello stato coscienziale. Se fosse così, si potrebbe dire che ogni concezione è un pensiero che nasce da un concepimento: un concepimento fisiologico. La concezione è il pendant metafisico di un concepimento fisico.
Agostino, dicendo che «è possibile l’esistenza del bene senza il male», bona tamen sine malis esse possint, ma «non è possibile invece l’esistenza del male senza il bene», mala vero sine bonis esse non possint, probabilmente altro non dice se non che, fuori dell’essere-cosciente, è impossibile il concepimento di qualsiasi concezione. Resta da vedere come si possa essere passati da una impression di essere-cosciente a un’idea di Coscienza. Potrebbe darsi che la divinità sia semplicemente l’idea di «essere-coscienza» che l’essere cosciente stesso pensa: la «coscienza-di-essere» diventa così «Coscienza-dell’Essere»: Dio.
In questo pare che Hume abbia ragione: ogni filosofema, ogni teologhema, è la sublimazione di una impressione fisica; sublimazione in un senso che va da quallo fisico di passaggio di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme senza passare per quello liquido, al senso psicanalitico di trasformazione di impulsi istintuali primitivi a livelli superiori e socialmente accettabili: un processo prevalentemente inconscio. Come dire che, in senso fisico, il “bene” dell’essere, sublimato in Essere-Bene di Dio, è lo stato aeriforme di un essere-cosciente (di un essere cosciente) e magari lo stato “liquido” è la considerazione morale di questo stesso stato: stato che, in prima istanza, è molto “solido”, cioè sensoriale.

La sublimazione fa ascendere al cielo uno stato solidamente fisico facendolo passare attraverso uno stato liquidamente morale: lo stato aeriforme della divinità è il punto d’arrivo di un’ascesi mistica che prende le mosse da una solida coscienza di essere; e il realismo ontologico del linguaggio ha il suo fondamento semantico in questa stessa solida coscienza di essere: se una lingua è l’espressione fisica di un pensiero, essa è l’espressione fisica di un essere (umano) che è cosciente, e tale coscienza è il suo primo pensiero.
La teodicea agostiniana del Bene porta a concludere che il Male è assenza di Bene: dietro a questa professione di autonomia del Bene con conseguente subordinazione del Male, potrebbe esserci l’impossibilità di concepire, da parte di Agostino, la possibilità di un essere (umano) che possa pensare senza essere (cosciente). ‘Essere’ dipende dal nostro poterci pensare come ‘essenti’; lo stesso nostro «pensarci come non essenti» dipende dal nostro «pensarci come essenti»: in questo senso tutto dipende dall’essere, nel senso che, se non si ha la capacità di pensarsi, cioè di avere coscienza di essere, niente è, per noi. «Per noi»: last but not least. La sublimazione morale dell’essere-per-noi diventa essere-per-sé nello stadio intermedio tra essere-per-noi e essere-in-sé: il nostro benessere fisico è considerato un bene, per noi, e quindi essere è bene, quando c’è il benessere. Continuando a salire verso l’astrazione del suo stato aeriforme, la concretezza della solida coscienza di essere perde il suo legame con il «per noi» fisico ed anche con il «per sé» morale, e diventa «in sé» metafisico: essere «in sé e per sé», ma, in ultima analisi, sempre essere-per-noi.
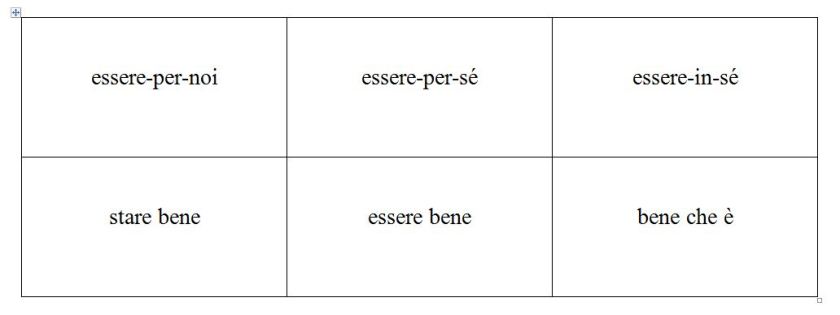
Astrarre è allontanarsi dalla coscienza fisica per salire nell’immaginario della coscienza metafisica; astrarre è «prescindere da»: quando la sublimazione sale i gradini dell’astrazione gradualmente prescinde sempre più dalla concretezza dei gradini più bassi dando ai gradini più alti un grado sempre maggiore di verità. L’intellettualismo è proprio la tendenza a credere (= dare credito, cioè verità) in stati astratti dell’essere sublimato; quando la sublimazione noetica è compiuta, la verità nel suo stato più alto è creduta essere quella astratta da ogni stato fisico.
La scalata dell’«a prescindere» consiste nel dare una sempre maggior autonomia agli stati superiori della coscienza: stati superiori sono così creduti stadi più sostanziali e più indipendenti, e ci si dimentica che essi restano comunque dipendenti dallo stato fisico che fa del nostro essere-coscienti lo ‘stadio base’ sul quale si fondano, come i piani alti di una casa sulle fondamenta, gli stadi ulteriormente pensati nel processo di astrazione.
Ecco cosa aveva imparato, Lui, in ospedale: a non considerare irrilevanti le premesse fisiche delle inferenze metafisiche; sarebbe stato contento, Nietzsche. Ormai se ne stava tutto isolato in un cantuccio a prendere appunti, perché i pensieri rampollavano con una velocità tale da non poter più essere messi a fuoco se non fissandoli sulla carta. Rampollare, poi, è verbo che parla di rampollo, per cui il rampollamento di questi pensieri è lo stesso salire e scendere dall’albero genealogico dell’ontologia «Dio è la coscienza del nostro essere che ha preso il volo – pensava Lui –, che s’è involata verso l’al di là. Dio è il rampollo della nostra coscienza».
Rampollo: rami pullus, pollone del ramo. L’Essere Supremo è il pollone del ramo genealogico dell’albero del bene e del male, quello che cresce alla radice del lignum scientiae boni et mali: «coscienza-di-essere» e «incoscienza-di-essere» biforcano la ramificazione ontologica nel bene di sapersi e nel male di non sapersi. Sapersi o non sapersi vivi, essenzialmente: questo è il dubbio che, alla tedesca der Zweifel, riconduce al “male di essere due”, zwei, la falsità del mendacio. Dio è Uno, Dio è Tutto: il monoteismo ha l’ossessione del Principio Unico. Lui l’aveva notata, in Agostino, questa ossessione di conservare l’unicità e l’univocità dell’Essere; l’aveva notata per esempio quando Agostino, proprio all’inizio del XIV Libro del De civitate Dei, scrive che «Dio ha voluto far procedere gli uomini da un solo uomo non solo per far convivere il genere umano nella identità della natura…», il che si spiega con quanto lo stesso Agostino scrisse nel XII Libro a 22: «…Dio prevedeva di chiamare in adozione con la sua grazia un popolo di fedeli e, giustificatolo nello Spirito Santo con la remissione dei peccati, di farlo partecipare della società degli angeli santi nella pace eterna, dopo aver eliminato l’ultima nemica, la morte. E a questo popolo avrebbe giovato la considerazione del fatto che da un solo individuo Dio ha dato origine al genere umano per inculcare agli uomini quanto gli è gradita l’unità dei moti». Il fatto che il Creatore abbia creato l’umanità ex uno homine è per Agostino segno di un auspicio: in pluribus unitas.
In Genesi 2,23 si legge che la donna «dall’uomo è stata tolta», de viro sumpta est. In Genesi 3,6 la donna, poi, di fronte alla tentazione dell’albero, lignum, su suggerimento del Mendace, «prese del suo frutto», tulit de fructu illius e peccò. Due sono dunque gli “sdoppiamenti” genetici dell’Essere: prima diventare uomo e donna e poi diventare coscienti di cosa sia essere e cosa sia non essere. «Si vede chiaramente – pensava Lui – che la geminazione porta con sé una connotazione negativa: ad ogni duplicazione sembra quasi che all’Essere pianga il cuore!». Gemino, as, avi, atum, are: raddoppiare.
Il geminus, us è il gemello: il “doppione”, colui che è geminus, a , um: simile, uguale. La geminitudo, la rassomiglianza gemellare, è effetto di un germino, as, avi, atum, are: mandar fuori. La geminatio nasce dalla germinatio di un germen: germe; ma, “in germe”, l’essere è uno. In nuce, cioè al principio, l’Essere è Uno: la “noce” ontologica ha un nocciolo solo. La suddivisione ontologica è vista con sospetto, c’è poco da fare: Virago viene da vir e Mal-Essere viene da Ben-Essere. L’ossessione monogenetica del monoteismo – sebbene Dio sia trigemino in quanto Trinità – mal sopporta la presenza di gemelli: lo zigote risultante dall’unione del doppio è sempre eteronoma, eterozigote; l’uno e il due sono solo “aggiogati”, ζυγωτός = «aggiogato», ma il giogo non fa dei due congiunti una sola carne, come si dice del matrimonio fra coniugi congiunti dal giogo nuziale.
La grazia ha il compito di ricondurre all’unità il male di essere due: senza ritorno all’Uno non c’è ritorno Nella casa del Padre. Si può quindi dire che il Male è la fissazione dell’Uno nella falsa coscienza del Due: fissazione come opinione falsa, alla Platone, perché la Verità è solo l’essere Uno dei Due. «Lo si vede anche solo grammaticalmente, nel numero che si sceglie di usare per ‘dire’ 2: il Due? i due? – pensava Lui –: per la monogenesi monoteista, il monismo dogmatico pretende che ‘il Due’ non debba avere esistenza autonoma: esso è ‘due di uno’». Genere, numero, caso: il genere del “doppione” di Adamo fu femminile: Eva; il genere del “doppione” del Bene fu maschile: il Male; il numero del Due deve essere plurale, perché se diventa singolare significa che esso è diventato antagonista dell’Uno. Quanto al caso, Lui sosteneva che, al singolare, un numero è sempre grammaticalmente un nominativo, logicamente un soggetto e ontologicamente una sostanza.
Quando «i due» diventano «il Due» è segno che l’alter ha raggiunto la consapevolezza della propria sostanza, ha conseguito la coscienza di essere un soggetto, un Io che può a buon diritto porsi alla pari nei confronti dell’Uno: un ego che è alter come alter è l’ego stesso di cui egli è alter. Non una parità di genere, ma una “parità di numero”, è il risultato dell’emancipazione del 2 che si è conquistato la parità. Se il Due non è più mancipio, schiavo dell’Uno, la sua mancipazione, la sua alienazione è acquisizione della libertà di essere senza essere dipendente dall’Uno: questa indipendenza è il peccato, che Agostino vede come un essere inclinatus ad se ipsum da parte di un Due che, in quanto «due di Uno», resta sempre un minus esse, un essere non solo “da meno” ma proprio “meno”, rispetto all’Uno dal quale deriva. Del resto, è facile notare che se, contando, noi cominciamo non da 1 ma da 2, il 2 diventa il primo numero dal quale si comincia a contare, assumendo le proprietà dell’1.
«Però è incoerente, da parte dell’Uno – pensava Lui –, cominciare da se stesso, cioè appunto da 1, rivendicare aspramente il diritto assoluto dell’1 ad essere l’unico essere-che-è-bene-che-sia, e poi, alla fine dei tempi, eternare la duplicità dell’essere-vivo in Paradiso e dell’essere-morto all’Inferno. Un dubbio può venire, no, che l’Uno sia incoerente?». Incoerente è ciò che manca di coesione, cioè di adesione alle proprie convinzioni: quale “adesivo” rende coese le due modalità ontologiche dell’essere vivo e morto insieme dell’essere umano al di là? L’unico “adesivo” che Lui riusciva ad immaginare per giustificare l’aderenza ontologica all’Essere-Uno di Vita e Morte era l’Essere stesso nelle sue due forme:

l’adesivo che cementa i due lati contrastanti della condizione escatologica è l’essere nella duplice veste di «essere-che-è» (vivo) e «essere-che-non-è» (vivo). Ancora una volta la coscienza rimane ben viva: anche nell’essere-morto della seconda morte, l’essere (umano) ha coscienza di essere morto; tale coscienza è l’essere ancora vivo da parte di un essere (umano) che però è morto: la coscienza del suo essere morto è il suo essere vivo per poter avere coscienza di essere morto.
La contraddizione tra essere vivo e al contempo essere morto da parte del dannato, è risolta dal fatto che egli, comunque, è: è per poter essere, vivo-vivo o morto-vivo. Il dannato è un morto vivo, un sepolto vivo… Lui stava di nuovo entrando nel dormiveglia ipnotico della meditazione filosofica, e fantasticava di un sepolto vivo (= Morto vivo) che moriva senza morire mai e nel mentre parlava a un vivo (Vivo vivo) che viveva senza morire mai:
Morto vivo: Ehi, tu…
Vivo vivo: Dici a me?
Morto vivo: Sì, a te: senti, tirami fuori da questa bara.
Vivo vivo: Non posso.
Morto vivo: Perché?
Vivo vivo: Perché sei morto.
Morto vivo: Ma sono anche vivo, come senti, sennò come potrei parlarti?
Vivo vivo: Tu sei vivo eternamente per poter morire eternamente. Io sono vivo eternamente per poter vivere eternamente.
Morto vivo: Chi ha potuto fare un sortilegio del genere?
Vivo vivo: Il Signore della vita.
Morto vivo: Colui che non concepisce la morte! Se avesse un po’ più di pietà, farebbe un piccolo sforzo per inventarsi il “Morto morto”: può tutto, Lui, e allora perché non ha potuto arrivare a tanto? Arrivare a concepire il “Morto morto”?
Vivo vivo: Perché Lui è la Vita e quindi, in Lui, uno non può essere Morto, ma solo morto.
Morto vivo: Questo mi ricorda tanto un dialogo che ho sentito non so più dove tra VERO e FALSO: anche lì, il Vero sosteneva che il Falso non esiste, in modo assoluto, ma che è solo un non-essere-vero, un non essere Lui.
Vivo vivo: Io non ho mai sentito quel dialogo, ma posso confermarti che, in effetti, un morto è tale solo in quanto è non-vivo.
Morto vivo: Ma io, dall’oblò di questa bara, vedo e sento tutto: ti pare giusto, lasciarmi in vita qui dentro per poter vedere la vita là fuori? dal di fuori?
Vivo vivo: Questa è la tua pena.
Morto vivo: Questo è sadismo puro; non poteva, quel Sadico, inventarsi il Morto che non è in modo assoluto?
Vivo vivo: Sta scritto in Sapienza 11,24-26
Tu ami tutte le cose che esistono
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta?
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue,
Signore, amante della vita.
Morto morto: Se fosse veramente indulgente, se veramente amasse ciò che ha formato, Lui concederebbe di non esistere a chi lo ha rifiutato.
Vivo vivo: Non può, perché ciò che ha creato esiste per sempre in Lui.
Morto morto: Allora, meglio non essere creati.
Vivo vivo: Impossibile.
Morto morto: Ciò che impossibile al Concezionale è possibile all’Anticoncezionale.
Vivo vivo: Cosa vuoi dire?
Morto morto: Che solo a chi è già stato concepito è impossibile non esistere, ma a chi ancora non è stato concepito…
Vivo vivo: Preferiresti non essere mai venuto in vita?
Morto morto: Piuttosto che starmene per sempre a vedere la vita dietro l’oblò di una bara, avrei certo preferito non venire in vita.
Vivo vivo: La verità dell’Essere sta nell’averne coscienza, per questo l’Essere non ha tolto la coscienza a chi è morto per sempre: perché anche lui potesse essere eternamente.
Fu bruscamente riportato alla realtà da un carro funebre che faceva manovra per posizionare la sua parte posteriore in modo da ricevere agilmente la bara che doveva uscire dalla camera mortuaria: era un bel carro funebre, omologato al trasporto di due salme, fornito di barre allungabili per porta corone, cambio automatico, quattro porte extralungo, servosterzo, sedili riscaldati, immobilizzatore elettronico, climatizzatore… tutto l’occorrente per farsi un bel viaggetto.
Dio permette al massimo di perdere coscienza nel senso di “svenire” nel coma vigile della seconda morte: morire del tutto non è consentito, a chi è nato: dopo la prima vita, ci tocca o (aut) la seconda vita o (aut) la seconda morte; tertium non datur. La sindrome apallica del coma vigile è in realtà una veglia incosciente, perché il paziente non ha consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante; Lui pensava che la natura naturata fosse assai più misericordiosa della natura naturans: «almeno la Natura toglie la coscienza, a chi entra in coma; Dio, invece, non la toglie nemmeno a chi muore!».
In greco τὸ κῶμα significa «sonno (profondo)»: dal coma al cimitero il passo è breve, almeno semanticamente, visto che forse κῶμα viene da κεῖμαι: giaccio (di)steso. Beati qui dormiunt in somno pacis… i cimiteri sono pieni di motti inneggianti al sonno: «è per scaramanzia, per convincere i parenti dei defunti che la morte è solo un sonno, e che alla fine ci risveglieremo tutti – pensava Lui – ma se il ‘Dio della Vita’ ha ragione, non sarà per tutti un bel risveglio: meglio che non si risvegli, chi sarà costretto dal ‘Dio della Vita’ a tenere gli occhi aperti in eterno sul proprio essere morto, non dev’essere un bello spettacolo, vegliare sulla propria morte».
«Vegliare per sempre sul proprio cadavere». Ecco la frase con cui Lui pensò di aver stigmatizzato una volta per sempre la seconda morte. Aveva solo qualche dubbio circa l’opportunità di dire ‘vegliare per sempre sul proprio cadavere’ piuttosto che ‘vegliare per sempre il proprio cadavere’, ma questa era solo una questione lessicale di poca importanza: era il concetto, che contava, e sicuramente esso risaltava in modo plasticamente icastico, (da εἰκαστικός «rappresentativo», der. di εἰκάζω «rappresentare»), dall’icona lessicale che Lui aveva ‘sbalzato’ a tutto tondo. La seconda morte è «Vegliare per sempre ‘sul’ (o ‘il’) proprio cadavere».
Detto ciò, gli pareva di vedersi, dannato, mentre vegliava il suo stesso corpo morto. Che ossimoro inconcepibile, quello della seconda morte! Era da Apocalisse 20,14 che la seconda morte οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. Et infernus et mors missi sunt in stagnum ignis. Haec est mors secunda. Ma non bisogna nemmeno omettere il versetto 15: Et qui non inventus est in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis. Certo che ἡ λίμνη ne esce letterariamente proprio male, destinata come fu, dall’Apocalisse, a diventare il porto in cui fanno naufragio i naufraghi dell’Essere; altro bell’ossimoro, il fatto che ἡ λίμνη possa aver qualcosa a che fare con ὁ λιμήν cioè con «il porto», appunto. Che macabra ironia, vedere nello stagno di fuoco della λίμνη infernale qualcosa che possa anche solo lontanamente c’entrare con il limus di ὁ λειμών cioè di una… «prateria»!
Che Lui si divertisse un mondo a intrecciare i sentieri che i rimandi etimologici indicavano sui dizionari, questo s’era capito, ma questa volta – Holzwege! – il rimando gli faceva imboccare un sentiero ben affascinante: il dizionario diceva che ὁ λειμών voleva dire, sì, «prateria, prato», ma anche le “grazie” dei «genitali»… Avrebbe voluto concludere, forse troppo frettolosamente, che l’errore fallico è il principale responsabile della caduta nello stagno di fuoco, ma poi si ricordò che homo factus est de limo terrae, e che il limus di ὁ λειμών è quello che c’è nella “prateria” dell’Eden, come da Genesi 2,7: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo», Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae…
«Sì – pensava –, dev’essere proprio così: il memento quaresimale delle ‘ceneri’ ci ricorda che lo stagno igneo è fatto di quella polvere cinerea che noi siamo… memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris… La liturgia delle ‘ceneri’ cita Genesi 3,19: “In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es: quia pulvis es et in pulverem reverteris”. Ogni anno, al mercoledi delle ceneri, il penitente si sente ripetere la maledizione che il Creatore lanciò all’uomo. Che meraviglia! E infatti, per coloro che incappano nella seconda morte, il Credo cattolico impone di credere che la maledizione si compie in uno stagno fatto di quella stessa materia prima da cui è stato tratto l’uomo: quel fango limoso che, senza il soffio vitale, è morte allo stato puro».
«Nella mia definizone di seconda morte – pensava Lui –, manca il fuoco». ‘Vegliare per sempre ‘sul’ (o ‘il’) proprio cadavere’ è una frase che uno può anche scrivere in grassetto e in rosso finché gli pare, ma il fuoco proprio non si vede… Concluse che, probabilmente, questa sua, era una definizione apocrifa, della seconda morte: una definizione non cattolica, una definizione poco ortodossa, ma comunque efficace, su questo non c’era dubbio. Questa storia del fuoco, che la tradizione cattolica ci teneva tanto a conservare, era certificata persino da Tommaso d’Aquino: «Comunque venga inteso il fuoco che tormenta le anime separate, si deve tuttavia in ogni modo affermare che il fuoco col quale saranno tormentati i corpi dei dannati dopo la risurrezione è corporeo: poiché a un corpo non può essere convenientemente applicata che una pena corporale».
«Certo che se il corpo ci seguirà nell’Aldilà – pensava Lui – è ovvio che la coscienza di noi stessi non ce la scollereremo più di dosso». Altro che Nirvana! Persino il piacere sessuale è visto con sospetto in quanto può attenuare la morsa coscienziale, e gli veniva in mente l’antipaticissimo Agostino, quando si mette a fare il bacchettone persino con l’orgasmo in De civitate Dei XIV,16:
Così nell’attimo stesso in cui si giunge all’acme vengono quasi travolte l’attenzione e la presenza della coscienza a se stessa.
Ita ut momento ipso temporis, quo ad eius pervenitur extremum, paene omnis acies et quasi vigilia cogitationis obruatur.
Supponiamo un amico della saggezza e delle gioie sante che tira avanti la vita da marito ma, come ha notato l’Apostolo, «sa conservare il proprio corpo nella onestà e nel decoro, non nella dissolutezza del piacere, come i pagani che non conoscono Dio». Non preferirebbe egli, se fosse possibile, procreare figli senza la libidine?
Quis autem amicus sapientiae sanctorumque gaudiorum coniugalem agens vitam, sed, sicut Apostolus monuit, sciens suum vas possidere in sanctificatione et honore, non in morbo desiderii, sicut et gentes, quae ignorant Deum, non mallet, si posset, sine hac libidine filios procreare…
Sine libidine procreare. Sarà veramente il sogno di qualche marito? Chi sarà capace di suum vas possidere in sanctificatione et honore? Come se l’orifizio vaginale di una moglie fosse una specie di pitale, un vaso da notte in cui il marito rovescia i propri bisogni seminali (!?)
«Quel passo di Agostino è sconvolgente – pensava Lui –: quando il piacere maschile arriva ad extremum, cioè all’orgasmo, la vigilia cogitationis, la veglia del pensiero, è oscurata: obruo, is, rui, rutum, ere… per esprimere la “obnubilazione” della vigilia cogitationis, Agostino usa questo verbo, obruo, che vuol dire «coprire», ma anche cancellare, distruggere… quello che oggi per quasi tutti i maschi è «lo Vas d’elezïone» (come Dante chiama san Paolo nel II canto dell’Inferno) della libidine, Vas libidinis, per sant’Agostino dev’essere quel maritale suum vas che bisogna possidere in sanctificatione et honore!» E intanto gli veniva in mente Lui, che, apparendo in sogno ad Anania, gli dice di andare a cercare Saulo come narrato in Atti 9,15-16: Ma il Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome», εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος· Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ, ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. Vade, quoniam vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Israel. Ego enim ostendam illi quanta oporteat eum pro nomine meo pati.
Lui in gioventù era stato segnato così indelebilmente dalla catechesi cattolica che i salesiani gli avevano marchiato dentro con il focoso imprimatur del loro zelo apostolico, che finiva sempre per fare delle sacre scritture il controrelatore di ogni sua tesi. Come un bove, pio e paziente, ruminava e centellinava la bibbia di giorno in giorno sperando sempre di poter trovare in essa – come gli avevano assicurato i preti – il cibo e la bevanda in grado di saziare la sua fame e sete di verità; ma più lo faceva, e più si ritrovava affamato ed assetato. Da quella citazione di Atti 9,15-16, poi, piuttosto che rinfrancato, ne usciva amareggiato, per via di quel soffrire, παθεῖν, pati che imperversava alla fine della citazione stessa: «Ma possibile – pensava – che la morale della vita cristiana, alla fine della fiera, sia sempre la sofferenza?».
Agire e Patire: ecco le due categorie del buon cristiano, e Com-patire. Lui agiva e pativa, come ogni povero cristo che si rispetti, ma soprattutto com–pativa: compativa se stesso e gli altri, compativa la triste condizione umana che Tutti accomuna, Nessuno escluso, anche se Qualcuno vuole negarlo. «Il patire è il problema – pensava – ma più ancora il patire eterno minacciato dal Padreterno», e ripensava alla sua definizione di seconda morte: ‘Vegliare per sempre ‘sul’ (o ‘il’) proprio cadavere’. Aveva sempre paura di non essere cattolico, nelle sue definizioni: la cattolicità è il requisito fondamentale di ogni stigma che vuole ambire all’universalità della propria stigmatizzazione nell’imprimatur del dogma. Un dogma reca le stimmate della verità? Mah! Certamente reca le stimmate della sofferenza. E gli veniva in mente ‘lo Vas d’elezïone’, quando in Galati 6,17 diceva: «io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo», ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω, ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto.
Lo stigma, τὸ στίγμα, il marchio, voce del verbo στίζω, che “esce” nel latino «in-stigare», significa il segno di uno «stimolare, soprattutto al male». Forse il Cristo ha dovuto portare le stimmate della passione e morte perché il Mendace ha i(n)stigato Eva al malum? Istigazione a delinquere. Per l’istigazione a delinquere di Satana, e la conseguente delinquenza di Eva (ed Adamo), siamo quindi tutti rinviati al Giudizio Universale, così dicono. Rinvio a giudizio. «E se ti condannano all’ergastolo, quei Tre? – pensava Lui riferendosi alla Santissima Trinità –, pazienza l’ergastolo al di qua, dove il tempo passa, ma al di là, dove non passa mai!». Lui pensava che la seconda morte fosse semplicemente l’unione di due pene che al di qua non si possono comminare insieme, per la contradizion che nol consente: pena capitale ed ergastolo. Uno viene prima ucciso al di qua e poi al di là sbattuto in carcere per sempre, vivo ovviamente, e tuttavia morto; Qualcuno risorge proprio per questo: per finire i propri giorni all’Inferno. Pena Capitale ed Ergastolo: solo al Dio di Giustizia poteva riuscire, al di là, ciò che a nessun Giudice può mai riuscire, al di qua: più di così non si può infierire.
‘Vegliare per sempre ‘sul’ (o ‘il’) proprio cadavere’. Quando pensava che a questa definizione manca il fuoco, suggello essenziale dell’Inferno non solo dantesco, ma, soprattutto cristiano, Lui aveva sempre la forte tentazione di andare a vedere le testimonianze di quesi santi, che – per chi ci crede – avrebbero avuto il “permesso” divino di scendere nell’Inferno per toccare con mano come stanno veramente le cose e poterle poi riferire a noi. Tra le tante, Lui aveva scelto la testimonianza di Faustina Kowalska, la suora polacca, mistica e veggente, canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000:
«Oggi, sotto la guida di un angelo, sono stata negli abissi dell’Inferno. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grande. Queste le varie pene che ho viste: la prima pena, quella che costituisce l’inferno, è la perdita di Dio; la seconda, i continui rimorsi di coscienza; la terza, la consapevolezza che quella sorte non cambierà mai; la quarta pena è il fuoco che penetra l’anima, ma non l’annienta; è una pena terribile: è un fuoco puramente spirituale, acceso dall’ira di Dio; la quinta pena è l’oscurità continua, un orribile soffocante fetore, e benché sia buio i demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri ed il proprio; la sesta pena è la compagnia continua di satana; la settima pena è la tremenda disperazione, l’odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme, ma questa non è la fine dei tormenti. Ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda ed indescrivibile. Ci sono delle orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall’altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture, se non mi avesse sostenuta l’onnipotenza di Dio. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l’eternità. Scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessun’anima si giustifichi dicendo che l’inferno non c’è, oppure che nessuno c’è mai stato e nessuno sa come sia. Io, Suor Faustina, per ordine di Dio sono stata negli abissi dell’inferno, allo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l’inferno c’è. Ora non posso parlare di questo. Ho l’ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno dovuto ubbidirmi. Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto. Una cosa ho notato e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono, sono anime che non credevano che ci fosse l’inferno. Quando ritornai in me, non riuscivo a riprendermi per lo spavento, al pensiero che delle anime là soffrono così tremendamente, per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori, ed invoco incessantemente la misericordia di Dio per loro». [Santa Faustina Kowalska: Diario – Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000 – pag. 276]
«Tremendo. Tremendo – pensava Lui –: se tutto questo è vero, è semplicemente tremendo». Ovviamente, per il suo scrupolo esegetico riguardante il fuoco, assente nella sua definizione di Inferno, a Lui stava soprattutto a cuore il passo di suor Faustina in cui si dice che «la quarta pena è il fuoco che penetra l’anima, ma non l’annienta; è una pena terribile: è un fuoco puramente spirituale, acceso dall’ira di Dio». Ma, pensava anche che fosse quasi una sorta di ironia della sorte, il fatto che la Kowalska avesse legato la sua santità al culto della Divina Misericordia, perché, etimologicamente, per quel che ne sapeva, «misericordia» è innanzitutto «avere cuore, cor, per il misero, miser». Invece, dalla testimonianza infernale di suor Faustina, emerge una morte eterna che nessun “dio” misericordioso potrebbe mai tollerare: non ha cuore, chi s’inventa una pena del genere. Non vedeva traccia di miseratio, di com-miserazione, nella pena capitale unita all’ergastolo che la Divina Misericordia aveva comminato ai defunti della seconda morte. «Sarebbe questo il Miserator, il Com-miseratore, il Misericordioso? – pensava Lui –, Miseria! Io non vedo traccia del miserere che i sette Salmi penitenziali ostentano oranti».
Lo colpiva anche il contrappasso che, in qualche modo, era presente nella descrizione della Kowalska: «Ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda ed indescrivibile», e: «Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l’eternità». Contrappasso: «soffrire il contrario», da contra + patior. Quel Dante… ci aveva azzecato!? Un fuoco spirituale che non si spegne mai… e gli veniva in mente il roveto ardente di Esodo 3,2: «L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava». L’eternità, unita alla sofferenza per la pena ricevuta, è un distillato di sadismo: eternità, pena dell’ergastolo, e morte, pena capitale.
L’ergastolo viene definito anche «reclusione a vita», ma, quello della seconda morte, è una reclusione a… morte, altro che… e poi, anche quella cazzata di Tommaso, bacchettata da Nietzsche, per la quale il fuoco eterno che strazia i dannati alimenterebbe a latere la beatitudine di quelli che, al piano di sopra, si compiacciono del pericolo scampato e al contempo della giustizia divina così inesorabile, nel suo lato oscuro e peggiore: ‘il braccio violento della legge’… e gli veniva in mente quel film del 1971 che vinse ben 5 Premi Oscar e 3 Golden Globe, The French Connection, tratto dal libro Il braccio violento della legge, di Robin Moore.
«Certe volte Nietzsche, nel suo sproloquio farneticante, sembra persino avvicinarsi alla verità, almeno certe volte – pensava Lui –, come quando imputa al ressentiment dei più deboli l’origine prima della cosiddetta ‘giustizia’ e insinua il dubbio che siano proprio i “miti ed umili di cuore” i colpevoli di quel “consacrare la vendetta sotto il nome di giustizia” nel quale lui intravede nient’altro che uno svliluppo ulteriore “del sentimento proprio di chi si sente offeso”». La seconda morte è frutto del “risentimento” di Dio? Il ressentiment nietzscheano è famoso per essere ritenuto il frutto più bacato di un “umano troppo umano” che si aggira nei paraggi di Matteo 11,29: «Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita»; quia mitis sum, et humilis corde, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ.
«Non pochi sono abili in quella sconcia arte di raggirare se stessi, consistente nello spacciare ogni torto proprio per uno altrui ad essi arrecato e di riservarsi, a scusante di ciò che essi stessi hanno fatto, il diritto eccezionale della legittima difesa: per portare in questo modo molto più facilmente il loro peso» [Friedrich Nietzsche: Umano, troppo umano – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1981 – traduzione di Sossio Giametta – Vol. II, parte I, aforisma 52 – pag. 29]
Nella Genealogia della morale Nietzsche allude al sospetto, fondato, che «la terra natale della giustizia sia da ricercarsi sul terreno del sentimento di reazione»: reazione risentita dei miti ed umili di cuore.
Ormai Lui, pur essendo ancora in ospedale, con la testa non c’era più, in quell’ospedale. E poi, comunque, era già quasi l’ora “che volge al disìo”, l’ora di uscire, dall’ospedale: disìo di tutti i pazienti, non meno che di tutti i visitatori; l’orario delle visite era rigido, e perdipiù Lui non era nemmeno un visitatore, perché non era andato lì per visitare qualche paziente suo amico, o suo parente… era un privilegiato, che era andato in ospedale solo per “visitare”, genericamente, la condizione umana del mal comune… non Enëa, non Paulo, Lui, bensì solo uno venuto per visitare, da internista di medicina generale – per così dire – la generale humana condicio. L’aveva visitata, quasi per par condicio, ma era ben lungi dall’averla guarita in sé, e tantomeno negli altri.
«Il medico è uno che ti visita per guarirti – pensava –, è curioso, che il verbo visitare c’entri sia con la visita medica che con la visita turistica; sarà per quel visĕre che si porta dentro, derivato di videre, «vedere», che al participio passato fa visus. Tutto il senso del mezzo gaudio, infatti, sta nel “buon viso” – avrebbe voluto dire buon visus – che si fa alla cattiva sorte del mal comune». Lui, però, quel “buon viso”, non l’aveva mai fatto, né mai lo avrebbe fatto. A cattiva sorte si deve fare cattivo viso, pensava: che è, questa ipocrisia? ἡ ὑπόκρισις: finzione, recita, simulazione… Sono Tutti attori, degli ipocriti! – pensava –, ma lo sanno chi è, ὁ ὑποκριτής? l’attore! L’attore, l’ipocrita per eccellenza, che simula con la chiacchiera del mezzo gaudio la verità del mal comune. La recita del mezzo gaudio nasce dalla sotto-valutazione del mal comune, come ben dice il verbo ὑποκρίνω, letteralmente, sotto (ὑπό) + giudico (κρίνω).
Come tutte le stigmata con cui ci marchiano in gioventù, anche il greco e il latino, per Lui che aveva fatto il liceo classico, dai salesiani, erano, insieme allo stigma della cattolicità, le stimmate indelebili della sua croce. Sono Tutti ipocriti. Come quell’Agostino, antipaticissimo saccente che si dà arie di veggente, e pensa di scoprire l’acqua calda, quando in De civitate Dei XIV,17 dice che Experta enim morbi molestia evidentior fit etiam iucunditas sanitatis, l’esperienza di una malattia dolorosa rende più evidente la piacevolezza della salute: bella scoperta! E allora? E allora lo sanno Tutti dove vuole sempre andare a parare il “grande” Agostino: lo scuro del Male serve a “mettere in chiaro” il Bene, serve a metterlo meglio in luce, perché sia chiaro che il Male è solo un Bene messo “in ombra”; questo è il chiaroscuro di cui parla sempre Agostino. Ma a Lui non era affatto chiaro, come questo Bene potesse far finta di diventare Male semplicemente oscurandosi, nascondendosi dietro a un po’ di eclissi: ipocrita pure lui! – pensava.
Se il mezzo gaudio esiste, è perché esiste la falsificazione ipocrita del mal comune: la mistificazione del mal comune è la stessa del Mendace, che compie il suo mendacio più grande quando riesce a convincere Tutti che non esiste – così pensava, Lui. Sono diabolici, gli attori del mezzo gaudio, perché intromettono tra il mal comune e il mezzo gaudio la calunnia, ἡ διαβολή, della mal-dicenza, τὸ διάβολον: lo sanno Tutti che il Diavolo è per definizione colui che opera il διαβάλλω e la mal-dicenza più grande è quella di dire bene del mal comune con la bene-dizione del mezzo gaudio, cioè interporre fra noi e il mal comune stesso l’intromissione del mezzo gaudio. «Il mal comune non avrà mai la mia benedizione! – pensava Lui –, è una sceneggiata di pessimo gusto, quella che gli attori del mezzo gaudio mettono in scena: è una farsa, la loro». Lui pensava che la “Compagnia del Mezzogaudio” – così la chiamava – fosse la compagnia teatrale più presente, sulle scene di questo mondo: quella che, nel relax del dopolavoro, più aiutava a sollevare i “pazienti della vita” dal peso intollerabile della loro stessa pazienza.
La Compagnia del Mezzogaudio porta in scena sempre la stessa pièce: conosce solo quella e, del resto, non ha bisogno di impararne altre, perché la banalità reiterata a iosa è lo svago preferito dalla gente comune, la gente, appunto, che pazienta il mal comune; in fondo, pazientare è recitare, pensava Lui, e la prova stava nel fatto che la pazienza era stata moralizzata, Giobbe in testa, a virtù dell’uomo forte di Dio, il paziente dei pazienti. Matteo 18,26-27: «Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito». Patientiam habe in me… È paziente e lento all’ira, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, «ma quando s’incazza… – pensava Lui».
Fu il “fallo” originale, a causare tutte le incazzature di Dio:
Nella sua disobbedienza che ha asservito gli organi genitali soltanto ai suoi impulsi e li ha sottratti al potere della volontà si rivela abbastanza che cosa sia stato corrisposto alla prima disobbedienza dell’uomo. Era conveniente che la pena apparisse soprattutto in quell’organo con cui si propaga la specie umana perché da quel primo grande peccato fu mutata in peggio. [Agostino: La città di Dio – Città Nuova, Roma 1997 – traduzione di Domenico Gentili – XIV, 20 – pag. 724]
…in ea parte maxime oportuit apparere, qua generatur ipsa natura, quae illo primo et magno in deterius est mutata peccato… «Il fallo originale determina l’errore fallico – pensava Lui –, Agostino lo conferma, anche se per lui è solo la libidine post edenica a rendere impura l’attività fallica».
«Quando ogni fallo sarà incappucciato per sempre – pensava Lui divertito – l’errore non sarà più seminato». Aveva solo qualche dubbio sulla scelta del verbo «incappucciare» e allora cercò delle alternative: imbacuccare, ammantare, vestire, rivestire, coprire, ricoprire, tappare, chiudere… ma nessuna funzionava meglio di «incappucciare», per cui si rassegnò all’idea di un fallo incappucciato, tanto il concetto era chiaro: il cappuccio impedisce al fallo di seminare esistenza.
Se è vero che l’uomo non crea, ma procrea soltanto, allora è anche vero che l’uomo semina solo esistenza “per conto di…” (= pro-), ma è l’essere, quello che crea veramente ciò che l’uomo pro-crea. Lo colpiva sempre, l’interpretazione etimologica che Heidegger aveva dato di ἡ φύσις, la natura, come voce del verbo φύω: produrre, generare (cf. lat. fuit). Natura verrebbe da nascitura, participio futuro di nascor, eris, natus sum, nasci, a dire che la «natura» è in sé perennemente “nascitura”. Se exsistere = ex + sistere, allora sistere è lo statum ontologico dell’essere che crea l’exstatum ontico dell’esistere ogniqualvolta qualcuno procrea. «Se φύω è, in qualche modo, da ricondurre al latino fuit – pensava Lui –, non si può non pensare a Genesi 1,3 quando Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux». Il greco dei Settanta non usa ovviamente fuit ma ἐγένετο: καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς a ulteriore riprova che esse = γίνομαι = gigno.
In tedesco fallen vuol dire «cadere» e der Fall è sia «la caduta» sia «il caso»; non è un “caso”, che l’«errare» del verbo fallen cada linguisticamente dal casus di ἡ πτῶσις: la caduta “discende” dall’errore fallico e si propaga come un virus in tutti i casi dell’esistenza. La discendenza dell’esistente ha il suo capostipite nella ptosi; sulla scorta del dettato nietzscheano, Lui non potè fare a meno di pensare che la ptosi è l’abbassamento di un organo dalla sua sede normale: la fisiologia – scienza della φύσις – è il discorso, ὁ λόγος, sulla natura, cioè su quella fisica che cade “naturalmente” dalla ptosi metafisica del fallo originale omologando in sé errore e colpa.
Per una genealogia della morale fallica, Lui si rifece alla Genealogia di Nietzsche disapprovando fortemente la consecutio di causa → errore → colpa. Fare di una causa un errore è già dare un giudizio morale che fa di quella causa un male; il successivo passaggio alla colpa deriva direttamente dalla considerazione negativa della moralizzazione della causa e ammorba la causa stessa diagnosticandola come peccato. Il peccato è dunque una pecca: il difetto consistente in un deficĕre (= mancare); si potrebbe capire l’essenza del peccato se solo si riuscisse a capire in cosa consista il suo deficit. Una mancanza? Un’ammanco? Nietzsche, facendo discendere la genealogia della colpa dal rapporto tra creditore e debitore insolvente, propende per l’ammanco:
Un debito verso Dio: questo pensiero diventa per lui strumeno di tortura. Afferra in Dio le antitesi estreme che riesce a trovare in rapporto ai suoi caratteristici e non riscattabili istinti animali, reinterpreta questi stessi istinti animali come una colpa verso Dio (come inimicizia, ricalcitramento, rivolta contro il «Signore», il «Padre», il progenitore e il principio del mondo), si tende nella contraddizione «Dio» e «diavolo», ogni no che dice a se stesso, alla natura, alla naturalità, alla realtà del suo essere, lo proietta fuori di sé come un sì, come qualcosa d’esistente, di corporeo, di reale, come Dio, come santità d’Iddio, come tribunale d’Iddio, come patibolo d’Iddio, come al di là, come eternità, come strazio senza fine, come inferno, come incommensurabilità di pena e colpa. Questo è una specie di delirio della volontà nella crudeltà psichica che non ha assolutamente eguali: la volontà dell’uomo di trovarsi colpevole e riprovevole fino all’impossibilità d’espiazione, la sua volontà di infettare e intossicare col problema della pena e della colpa le più profonde radici delle cose, la sua volontà di pensarsi castigato, senza che il castigo possa mai essere equivalente alla colpa, per tagliarsi una volta per tutte la via d’uscita da questo labirinto di «idee fisse», la sua volontà di erigere un ideale – quello del Dio «santo» –, e di acquistare una tangibile certezza della propria assoluta indegnità di fronte a lui. Oh dissennata triste bestia, l’uomo! Quali fantasie le vengono in mente, e non appena si vede un poco impedita di essere la bestia dell’azione, quale contronatura erompe, quali parossismi di follia, quale bestialità dell’idea!… Tutto ciò è di uno smisurato interesse, ma anche di una tristezza nera, fosca, sfibrante; dobbiamo favvero impedirci a forza di scrutare troppo a lungo in questi abissi. Qui c’è malattia, non v’è dubbio, la più tremenda malattia che sia infuriata sino a oggi nell’uomo… [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Seconda dissertazione, § 22 – pag. 83]
Una colpa perpetrata da una creatura finita nei confronti di un Creatore infinito, è un debito infinito, per lui insolvibile: questo il dogma cattolico del catechismo cristiano; e quindi il Creatore si “assume” (= prende su di sé) la colpa di quel debito affinché il debitore possa estinguerlo: il capro espiatorio è l’Agnello di Dio, colui che toglie i peccati dal mondo, il Creditore (= il Creatore) “in persona”.
Lui pensava alla sintomatologia, in ispecie quella di un trauma. Il sintomo, τὸ σύμπτωμα, viene da συμπίπτω, cado insieme, cioè da πίπτω, cado: lo stesso verbo da cui discende ἡ πτῶσις, der Fall, il casus della malattia originale; τὸ σύμπτωμα significa infatti anche caso, sventura, infortunio e – udite! udite! – persino caduta di Adamo. Pensava a Nietzsche: «qui c’è malattia, non v’è dubbio…». Adamo ed Eva, da buoni con-iugi, “con-cadono” nel sin-tomo di un’unica con-causa: il casus originalis, τὸ σύμ-πτωμα. «Del resto – pensava Lui – si dice “cadere” in una malattia: la malattia è l’occaso della salute».
L’occaso è il tramonto: dal latino occasus -us, derivato di occĭdĕre «cadere, tramontare», supino occasum. L’esistenza è ad Ovest dell’essere: è il suo occidente. L’esistenza è alla sinistra dell’essere: per questo è “fallata”? L’esistenza non siede alla destra del Padre? La sintomatologia dell’esistenza è la diagnosi di una caduta comune: il cadere in disgrazia di Dio. L’occaso dell’essere è il suo stare supino nell’occasum del proprio orribile dictu. In quel momento Lui vide uno con la gamba destra ingessata che camminava con le stampelle: «Ecco! – pensò – la grazia è la stampella che l’esistenza riceve dall’essere per poter camminare nonostante il trauma della caduta». Non era un credente, ma, dopo aver ricevuto le stimmate salesiane del proprio liceo classico, Lui portava in sé lo stigma della cattolicità: la lingua batte dove il dente duole.
Gli pareva di vedere onde concentriche propagarsi a dismisura in un patologico discendere dal mortifero tumore originale dell’essere verso le lunghe metastasi esistenziali del vivere: il mal comune discende da un tumore maligno, il φύω del tumor naturae, il pollone tumorale di ogni nascituro rampollo, rami pullus dell’albero genealogico boni et mali. «È come una miccia accesa dalla mano di Eva la cui fiamma si propaga a velocità vertiginosa sul cordone ombelicale dei nascituri che le gestanti alimentano», pensava. Il φύω del tumor naturae “corre” come sul cordone di una miccia lunga quanto il tempo dell’umanità intera: corre per raggiungere l’esplosivo escatologico della detonazione finale, nel cui scoppio «i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! – come si legge alla fine della Seconda Lettera a Pietro – Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia».
I cordoni ombelicali che alimentano i nascituri sono la miccia per quem caeli ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent. «Ci vuole un artificiere che sappia disinnescare l’ordigno escatologico della fine dei tempi – pensava Lui –, ordigno ordito dal Creatore per bruciare il peccato nel crogiolo della sofferenza eterna. La καταστροφή finale viene dalla στροφή iniziale». Lui pensava che “il grande Artificiere” fosse colui in grado di disinnescare il Giudizio Universale: la Desistenza. Lui non li voleva, quei cieli e terra nuova nei quali abita la giustizia, perché Giustizia significa Giudizio e ogni giudizio comporta la discriminazione di innocente e colpevole. Il grande Artificiere avrebbe permesso ai colpevoli la latitanza nella clandestinità meontologica nel Nonessere: la possibilità di non passare in giudicato, cioè di non essere condannati da una sentenza senza possibilità di appello, una sentenza inappellabile ma non ineccepibile. A Lui non piaceva né il Diritto divino della vita del mondo che verrà, né il diritto umano della vita del mondo che è già venuto:
Parlare in sé di diritto e torto è cosa priva di ogni senso; in sé offendere, far violenza, sfruttare, annientare non può naturalmente essere nulla di «illegittimo», in quanto la vita si adempie essenzialmente, cioè nelle sue funzioni fondamentali, offendendo, facendo violenza, sfruttando, annientando e non può essere affatto pensata senza questo carattere. C’è persino qualcosa di più serio che dobbiamo ancora confessare a noi stessi: che dal supremo punto di vista biologico, stati di diritto possono essere sempre soltanto stati eccezionali, essendo parziali restrizioni della peculiare volontà di vivere che ha di mira la potenza, e subordinandosi in quanto strumenti particolari allo scopo complessivo di tale volontà: come strumenti cioè per creare più grandi unità di potenza. [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Seconda dissertazione, § 11 – pag. 65]
Poco oltre, al § 14 di questa stessa Seconda dissertazione, Nietzsche scrive che «il valore della pena deve essere quello di destare nel colpevole il sentimento della colpa, in essa si cerca il caratteristico instrumentum di quella reazione psichica che prende il nome di ‘cattiva coscienza’, ‘rimorso’». La giustificazione nietzscheana della potenza come volontà di vivere della natura è la legalizzazione dell’anarchia biologica.
È proprio la volontà di vivere, che va castrata – pensava Lui –, ma non con la noluntas di Schopenhauer; la noluntas è come un preservativo: cura il fallo senza prevenirne l’errore, senza preservare dal male fallico. Lui auspicava l’impotenza, non la disfunzione erettile. L’erezione fallica arma la mano del Creatore, che bastona la creatura con la stessa verga del membro virile: il pene diventa la pena; o, meglio, diventa lo strumento per infliggere la pena minacciata in Genesi 3,16-19:
Alla donna disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori
e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ed egli ti dominerà».
All’uomo disse:
«Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie
e hai mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato:“Non devi mangiarne”,
maledetto il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba dei campi.
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane,
finché non ritornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
Questa minaccia andava disinnescata, così pensava, Lui, che auspicava l’impotenza, non la disfunzione erettile. «È una storia del cazzo, quella biblica della genesi – sbottò in un accesso d’ira ontologica –: è una storia del cazzo!».
Il fallo è fatto apposta per seminare l’errore della vita, l’errore esistenziale. Lui condivideva la stroncatura che Nietzsche faceva dell’ascesi:
Su quanto viene avvertito con la massima sicurezza come vero, come reale: essa cercherà l’errore proprio laddove il vero e proprio istinto vitale impianta la verità nel modo più incondizionato. [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Terza dissertazione, § 12 – pag. 112]
«È un errore sia quello di Nietzsche, sia quello dell’asceta – pensava Lui –: è errore quello di Nietzsche, perché la verità non è la potenza orizzontale per un lungo salto al di qua; ed è errore quello dell’asceta, perché la verità non è la potenza verticale per un alto salto al di là. Nietzsche allena dei corpi per il salto in lungo, l’asceta allena delle anime per il salto in alto». La validità della filosofia di Nietzsche si fonda sulla validitas, sulla forza fisica che l’uomo si conquista a caro prezzo: questa validità è la valetudo della salute:
Quanto più è normale lo stato d’infermità nell’uomo – e non possiamo contestare la normalità di questo fatto –, tanto più in onore si dovrebbero tenere i rari casi della possanza d’anima e di corpo, i casi fortunati di umanità, tanto più rigorosamente si dovrebbero preservare i benriusciti dalla pessima atmosfera, l’atmosfera dei malati. È così che si fa?… I malati sono il pericolo massimo per i sani; non dai più forti viene il danno per i forti, bensì dai più deboli. Sappiamo noi questo?… [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Terza dissertazione, § 14 – pagg. 115-116]
«Lui mi avrebbe messo fra quei malati che minano e mettono a rischio la salute dei suoi sani – pensò Lui – perché io rifiuto quella vita che lui ritiene essere l’unica vera e propria verità ontologica. Lui avrebbe visto nella mia nausea per l’essere umano e nella mia compassione per l’umanità quel “qualcosa di straordinariamente sinistro” – la volontà del nulla – che è l’ultima volontà dell’uomo malato». Gli sembrava di sentirlo, Nietzsche, che lo redarguiva dicendo che le ultime volontà sono l’eredità del morituro, di colui che fa testamento perché abdica dalla vita; il morituro è l’innaturale per eccellenza, colui che va contro il futuro nascituro che la natura comanda: il morituro è l’uomo del passato, l’uomo superato. Lui lo sapeva, che Nietzsche gli avrebbe detto delle cose più o meno di questo tenore, ma, francamente, non gliene poteva fregare di meno, di dispiacere a Nietzsche, di deludere un filosofo che, per il suo stato di salute fatiscente e cascante, avrebbe solo dovuto star zitto.
«E poi, Nietzsche non s’è mai proclamato Dio – anzi, ne ha proclamato la morte –, quindi non è assolutamente una minaccia, per il genere umano – pensava Lui –, è da quelli che si autoproclamano dèi, che dobbiamo guardarci, perché, se solo fosse vera la loro divinità, essi potrebbero veramente determinare il nostro futuro al di là; chissenefrega, del futuro al di qua, del futuro del nascituro, del futuro della nascitura… al diavolo la natura! Dobbiamo guardarci da coloro che dicono di avere in mano il nostro futuro al di là, perché, qualora essi non mentissero, solo loro potrebbero veramente essere i padroni della nostra futura eternità». Era l’infinità, che lo spaventava, non l’innocua e minuscola finità di questa meschina esistenza terrena.
Capovolgendo Matteo 10,28 Lui diceva sempre: «non abbiate paura di chi può uccidere il vostro corpo, temete piuttosto chi può far vivere la vostra anima»; sapeva che, dicendo questo, avrebbe attirato su di sé l’ira di Dio. È di Dio, che aveva paura: il settimo dono dello Spirito Santo, il timor di Dio, non gli mancava certo – anche se il suo era piuttosto… come dire? terror di Dio! –; epperò non gliene fregava nulla, di quel malaticcio di Nietzsche: lui non poteva nulla, contro l’uomo, al di là. (E poi, detto tra parentesi, che razza di dono avrebbe mai potuto essere il… timor di Nietzsche?). Ma, se un dio come quello cristiano fosse veramente esistito, di quello sì, che si avrebbe dovuto aver timore, anzi, paura: Lui, che dice di aver parlato per bocca di suo Figlio, ha fatto dire al Cristo (suo figlio?): «Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano». Per chi non rimane in Nietzsche, pare che ustioni in vista non ce ne siano, ma, a chi non rimane in Cristo…
«Non abbiate paura di chi può uccidere il vostro corpo, temete piuttosto chi può far vivere la vostra anima». Lui vedeva nel Cristo un pericolo potenziale: se è vero che è Dio, Lui può far vivere la nostra anima – pensava –, la può far vivere in eterno, anche nelle ustioni infernali del corpo che brucia senza consumarsi. In ospedale, Lui s’era fatto una certa cultura, sul grado delle ustioni, e lo colpiva molto il quarto grado: l’ustione si estende per tutto il derma e nel tessuto adiposo sottocutaneo, nei muscoli e nelle ossa; fa assumere alla pelle un aspetto nero con segni di carbonizzazione; la prognosi è: amputazione, significativa compromissione funzionale, e, in alcuni casi, la morte. La chiamano combustio escarotica: si ha distruzione degli elementi strutturali della cute e dei tessuti sottostanti con formazione di un’escara; l’escara è la parte necrotica di un tessuto destinata a essere eliminata e sostituita da una cicatrice.
In greco ἡ ἐσχάρα è il focolare, generalmente, il focolare domestico, ma anche il braciere, il fornello. A Lui veniva in mente la “fornace ardente” di Daniele 3,1-6:
Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d’oro, alta sessanta cubiti e larga sei, e l’aveva fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province, perché presenziassero all’inaugurazione della statua che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere. I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province vennero all’inaugurazione della statua che aveva fatto erigere il re Nabucodònosor. Essi si disposero davanti alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. Un banditore gridò ad alta voce: «Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: Quando voi udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d’oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente».
La storia è nota: tre giudei, Sadrac, Mesac e Abdènego, rifiutano di prostrarsi davanti alla statua di Nabucodonosor e il loro Dio – il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe – li salva dal fuoco; lieto fine: Nabucodonosor dà loro autorità nel suo regno. Parlando di quei tre eletti, il profeta Daniele assicura che «l’angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia» e alla fine «Sadrac, Mesac e Abdènego uscirono dal fuoco».
«Nabucco è come Nietzsche – pensava Lui –: chi non si prostra davanti a loro non ha nulla da temere, ché ciarlatani di quella risma non possono nulla, contro gli esseri umani. Ma, di contro, abbiamo un Messia che in Matteo 13,40-42 minaccia:
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Nietzsche non ha mai fatto l’ira di dio in questo modo». Et mittent eos in caminum ignis. Ibi erit fletus et stridor dentium: καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
In caminum ignis… Il camino, simbolo così mansueto e accogliente del focolare domestico, ἡ ἐσχάρα, diventa lo strumento di punizione dell’Inferno. Scartabellando il dizionario di greco, Lui scoprì che ἡ ἐσχάρα in gergo medico significa anche «crosta» prodotta da buciature, e scoprì pure che la traduzione latina di ἡ ἐσχάρα -ας è lar, laris: focolare domestico; donde i Lari, divinità protettrici della casa. Altro che combustio escarotica!
L’avevano mandato a fare quel tour in ospedale, gli amici Tutti, affinché Lui imparasse il mezzo gaudio dai pazienti: quelli che godono nel vedere che c’è sempre qualcuno che sta peggio di loro. «Spero solo che non sia risentimento, quello che cova sotto il coprifuoco “comprensivo” del mezzo gaudio – pensava Lui –: spero proprio di non dover dare ragione a Nietzsche».
Sono tutti uomini del ressentiment, questi esseri fisiologicamente sciagurati e bacati, un’intera terrestre genia tremante di sotterranea vendetta, inesauribile, insaziabile nei suoi accessi contro i felici, come lo è nelle sue mascherate di vendetta, nei suoi pretesti di vendetta: quando potrebbero veramente giungere al loro ultimo più sottile e più sublime trionfo di vendetta? Indubbiamente, allorché riuscissero a trasferire la loro miseria, ogni miseria in generale, nella coscienza dei felici: così che questi cominciassero un giorno a vergognarsi della loro felicità e si dicessero forse tra loro «esseri felici è un’infamia! esiste troppa miseria!»… Ma non potrebbe esserci fraintendimento più grande e più funesto di quello che si avrebbe ove mai i felici, i benriusciti, i più possenti nel corpo e nell’anima, principiassero in questo modo a dubitare del loro diritto alla gioia. Basta con questo «mondo alla rovescia!» Basta con questo ignominioso infrollirsi del sentimento! Che i malati non facciano ammalare i sani – tale sarebbe il significato di un siffatto infrollimento – , dovrebbe pur essere la suprema prospettiva sulla terra – ma prima di tutto è compreso in ciò il fatto che i sani restino separati dai malati, che non vengano a confondersi coi malati. O sarebbe forse loro compito essere infermieri o medici? [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Terza dissertazione, § 14 – pagg. 118-119]
«Se ammalarsi è provare quella che Nietzsche definisce nausea & compassione per l’uomo, beh, allora io posso tranquillamente girare per gli ospedali senza rischio di ammalarmi, perché sono già malato da tempo – pensava Lui –; piuttosto, forse, sono i miei amici Tutti che conservano ancora falsamente in sé la loro borghese e codina nausea per i malati e la loro necrotica e narcotica compassione farisaica per i più deboli. Costoro, che mi hanno consigliato di venire a farmi un giro qui, quando mai ci sono venuti, loro, da sani? (sempre che ci siano mai venuti da malati)». La compassione degli attori del mezzo gaudio è perbenista: moralizza il mal comune coprendone le pudende per benino; il mezzo gaudio è il perizoma del mal comune, dal lat. tardo perizoma -ătis, gr. τὸ περίζωμα, comp. di περι- «peri-» e tema di ζώννυμι «cingere».
Genesi 3,7: «Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture», καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα, Et aperti sunt oculi amborum; cumque cognovissent se esse nudos, consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata. Lui sosteneva che non bisognava coprire le vergogne del mal comune: bisognava lasciarlo nudo e senza veli, com’era prima del fallo originale. Il pudore è sintomo di cattiva coscienza: se la pudicizia del mezzo gaudio è l’indizio più evidente del reato edenico, è solo nell’impudicizia del mal comune che si può tentare un ritorno, almeno deontologico, allo stato originale. Il mezzo gaudio decora il mal comune per renderlo decoroso, decente, ma, nonostante il maquillage, il “trucco” non funziona mai del tutto: l’indecenza del mal comune è così indecorosa che trapela da sotto il cerone del mezzo gaudio, il quale, appunto, proprio a causa del suo essere gaudio solo “per metà”, non è in grado di velare tutte le rughe disdicevoli dell’invecchiamento ontologico. L’invecchiamento biologico è solo l’effetto postedenico del decadimento edenico. Per questo scandalizzava Tutti, Lui, perché andava in giro nudo e, come se non bastasse la sua nudità, cercava anche di denudare gli altri, il che era per Tutti qualcosa di intollerabile. Svergognato! – gli dicevano Tutti –, quando la finirai di mettere in mostra le tue oscenità? Al che Lui rispondeva sempre: le nostre, oscenità, non le mie, le nostre, prego. Non aveva ritegno, quando si trattava di mettere a nudo il mal comune in tutta la sua universalità. Era per Lui una specie di missione, mettere a nudo quella brutta donna, la senescenza fatiscente del sostrato maligno dell’essere, per dimostrare a Tutti che l’avvenenza del mezzo gaudio era solamente la chimera di una sua presunta bellezza: il trucco di una cosmesi illusionistica che l’arte dell’ipocrisia esercitava abilmente come un gioco di prestigio capace di occultare le sgradevoli tumescenze maligne che il senso comune preferisce non vedere.
«Tutti passano la vita a truccarsi il mal comune – pensava Lui –: poi, siccome il trucco non funziona mai del tutto, per completare l’opera, socchiudono gli occhi, affinché le brutture che ancora si vedrebbero ad occhi aperti, possano nascondersi nella nebulosità mistificante e allucinogena dell’immagine “mossa”, mossa a causa di una volutamente mancata messa a fuoco. Quando i contorni di una cosa non sono chiaramente determinati, la fantasia può vederci di tutto, in quel quella cosa». Gli veniva in mente l’impressionismo, la famosa corrente artistica che nel XIX secolo esordì con Impression di Monet, soleil levant: l’impressione solare e sfolgorante che la vista normalmente mette a fuoco, è qui guardata ad occhi socchiusi, quasi per ripararsi da quella chiarezza troppo assiomatica ed evidente che la realtà cerca sempre di imporre; l’impressionismo nasce da un’osservazione che rifugge volutamente da una messa a fuoco nitida e netta, da un realismo che impone una veduta ufficiale e canonica delle cose, impedendo ogni impressione personale: l’impressionismo evita allo sguardo la verità costituita della Weltanschauung istituzionale cercando di cogliere in una visione alternativa, ad occhi socchiusi, la speranza di un’utopia irreale.
A Lui veniva di nuovo in mente Hume: «Impression. Il mezzo gaudio guarda con gli occhi aperti solo a metà l’impression sensibile del mal comune sì che esso possa diventare solo una “impressione” di realtà: una suggestione; il mezzo gaudio è la visione impressionista della verità». È interessante vedere i significati del termine «impressione»: nel comune parlare, essa è solo un’idea personale di qualcosa, un parere. A Lui piaceva sempre pronunciare il sostantivo italiano «parere» anche come infinito del verbo latino pareo, es, parui, paritum, ere: apparire, mostrarsi. È il concetto di «fenomeno», quello che sta dietro al verbo parere: dal greco ϕαινόμενον, participio sostantivato di ϕαίνομαι «mostrarsi, apparire». Ma, a monte del fenomeno, c’è l’epi-fania, epi-stemica, dell’ἐπιφαίνω: ἐπί + φαίνω = appaio sopra. Per Lui, il mezzo gaudio appariva sempre sopra il mal comune, ne era l’epifenomeno, per così dire: una manifestazione collaterale, una sovrastruttura – alla Marx – ideologica, del mal comune. Ogni parere (italiano) sul mal comune è un parere (latino) appunto «sul» mal comune: una costruzione ideologica prodotta da thought or ideas – alla Hume – sulla base di una impression che si vuole misconoscere: ogni ideologia è il misconoscimento della verità che la origina. L’ideologia del mezzo gaudio è una suggestione, dal latino suggestio -onis, propriamente «suggerimento» (derivato di suggerĕre, participio passato suggestus: donde suggerire. Il mezzo gaudio suggerisce solo dei ‘pareri’ sul mal comune occultandone l’evidenza, cioè la verità; è subdolo, il mezzo gaudio, perché insinua la falsa opinione che, considerando comune il male, esso possa miracolosamente trasformarsi in bene, magari un bene a metà, ma comunque non più male del tutto.
Genesi 3,4-7:
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due…
Il parere del mezzo gaudio è come il serpente, insinua la tentazione di credere che il tabù è innocuo: che il mal comune si può benissimo ingerire senza effetti letali, se solo lo si prende insieme all’antidoto del mezzo gaudio… e l’uomo, vedendo che esso è “gradevole agli occhi”, ci casca. Il mezzo gaudio è pulchrum oculis, aspectuque delectabile, come il malum edenico, ma poi si rivela per quel che è: peccato, cioè mal comune. Il “parere” del mezzo gaudio è sempre quello di un consigliere frodolento, che tende a sdrammatizzare la rappresentazione – die Vorstellung – del mal comune. «Sdrammatizzare» è privare una rappresentazione del dramma ad essa congenito; la Compagnia del Mezzogaudio recita la commedia di un mistero gaudioso che si fonda sulla mistica del mal comune: ‘mistica’ nel senso che misti-fi-ca il dramma originale previsto dal copione, un copione che il libro biblico della Genesi lascia intendere.
Lui andava fiero di questa sua interpretazione etimologica della mistica sdrammatizzante: essa si basava su Giovanni 15,11: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena»; ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. Haec locutus sum vobis: ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. «Va bene il gaudium della Vulgata – pensava Lui – ma, a onor del vero, il greco di Giovanni l’Evangelista parla di ἡ χαρά, voce del verbo χαίρω: gioire».
«La mistica della sdrammatizzazione ha come principale effetto teatrale l’applauso catartico del lieto fine – pensava Lui –: svia l’evidenza del reato come un consumato ed esperto delinquente, inquinandone le prove; e ciò è confermato dall’esito latino del verbo χαίρω: hortor, esorto, incoraggio, rincuoro…». Prima ai Tessalonicesi 4,13: «Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza»; qui spem non habent: οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. La seconda delle tre Virtù Teologali, la Speranza, Lui la scriveva in grassetto verde, come il mezzo gaudio e questo per ovvi motivi: la speranza era per Lui la vis comica che permetteva alla commedia del mezzo gaudio di trasformare la tragedia del mal comune in dramma giocoso; la locuzione vis comica nasce da alcuni versi attribuiti a Giulio Cesare in lode di Terenzio: Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis, Comica ut aequato virtus polleret honore Cum Graecis … «Oh se alla garbatezza del tuo scrivere fosse unito il vigore, sì che il tuo valore di commediografo potesse fiorire di una gloria uguale a quella dei Greci…»: sarebbe virtus comica, non vis – pensava Lui – e questo gli pareva confermare la sua interpretazione del mezzo gaudio come sublimazione mistica, cioè mistificante, del male nella virtù della comunella, della combutta.
La gioia mistica di ἡ χαρά è parente assai stretta di ἡ χάρις – la grazia – anch’essa frutto del verbo χαίρω, a dire che il desiderio di Tutti è quello di veder rappresentato il mal comune non con l’evidenza drammatica e impietosa della sua verità, bensì con quella grazia sdrammatizzante che, mistificandone il dramma, ne adombra la crudezza stemperandola con l’affabulazione graziosa di un leggiadro e rassicurante intreccio gaudioso: la graziosità del mezzo gaudio adultera il sapore orginale del mal comune edulcorandolo con gli strumenti retorici della fabula; affabulare è in-cantare, cantare sopra, sopra il mal comune, l’epodo della mistica mistificazione. Già Lucrezio, in qualche modo, l’aveva scritto, nel primo libro del De rerum natura, che il mezzo gaudio è come il miele che si deve spargere sull’orlo del bicchiere, affinché l’assenzio del mal comune possa essere “bevuto” fino in fondo:
come i medici, quando cercano di dare ai fanciulli
il ripugnante assenzio, prima gli orli, tutt’attorno al bicchiere,
cospargono col dolce e biondo liquore del miele,
perché nell’imprevidenza della loro età i fanciulli siano ingannati,
non oltre le labbra, e intanto bevano interamente l’amara
bevanda dell’assenzio e dall’inganno non ricevano danno,
ma al contrario in tal modo risanati riacquistino vigore;
così io ora, poiché questa dottrina per lo più pare
troppo ostica a coloro che non l’hanno coltivata,
e il volgo rifugge lontano da essa, ho voluto esporti
la nostra dottrina col canto delle Pieridi che suona soave,
e quasi cospargerla col dolce miele delle Muse,
per provare se per caso potessi in tal modo tenere
avvinto il tuo animo ai miei versi, finché penetri tutta
la natura, in quale forma sia disposta e ornata.
«L’arte scenica del mezzo gaudio è il miele necessario affinché Tutti possano bere l’assenzio del mal comune senza farne un dramma – pensava Lui –: tutta scena! Letteratura poetica e drammatica…».
A Lui veniva in mente La bevitrice di assenzio di Picasso: una donna che si appoggia con entrambi i gomiti su un tavolo, davanti a una bottiglia di seltz e a un bicchiere di assenzio, col mento appollaiato su una gigantesca mano sinistra, persa nella svagato autismo della sua ora verde, heure verte, come i francesi chiamavano l’ekstasis ricreante dell’evasione. Il mezzo gaudio è l’ora verde del mal comune, il quale ultimo ne è l’ora… rossa. La vita: codice rosso. La morte, il codice nero che naturalmente cambia colore al codice rosso, facendolo diventare azzurro, azzurro cielo, com’è il colore della metafisica, della mistica ascesi che fa risorgere la vita morta al di qua nella mistificazione mistica della vita viva al di là: eccola, la gioia cristiana di ἡ χαρά, pensava Lui.
Ogni volta che recita la mistica sdrammatizzante del mezzo gaudio, la Compagnia del Mezzogaudio è sempre subissata da applausi: non un fischio, mai. Tutti sono sempre molto riconoscenti agli attori di quella compagnia, e, dopo lo spettacolo, prima di andarsene, Qualcuno ringrazia anche gli attori personalmente, stringendo loro la mano. «Ringraziare è infatti voce del verbo εὐχαρίζω: si è soprattutto riconoscenti verso ciò che è εὔχαρις, grazioso, gradevole, bello, incantevole; l’incanto buono che ammalia affabulando secondo quella buona grazia mistica che conduce all’operazione mistificante di εὔχαρις = εὖ + χάρις. Tautologia pleonastica il dire εὔχαρις, come dire “belle arti”: l’arte è bella per definizione. La rappresentazione scenica del mezzo gaudio è l’eucarestia che celebra la passione e morte del mal comune».
Ma non c’è εὐχαρίζω senza χαρίζω: dire o fare cosa gradita è la premessa ineludibile per arrivare al consenso eucaristico del ringraziamento, e infatti χαρίζω significa proprio «dire o fare cosa gradita». Gli attori, gli ipocriti della Compagnia del Mezzogaudio celebrano il mistero del mal comune nel modo gaudioso che Tutti vogliono vedere: con la grazia, χάρις, di chi sa muoversi, furbescamente, sulla scena. «Sono cariatidi, gli attori del Mezzogaudio – pensava Lui –, vecchie cariatidi abbellite dal trucco della maschera». E gli veniva in mente Nietzsche, in Al di là del bene e del male: «Tutto ciò che è profondo ama la maschera; le cose più profonde hanno per l’immagine e l’allegoria perfino dell’odio».
Il mal comune è la cosa più profonda che c’è: per questo ama mascherarsi con le maschere eucaristiche delle celebrazioni teatrali. Certe volte – doveva ammetterlo – Nietzsche non gli sembrava così pazzo: la ‘rappresentazione della volontà’ che Schopenhauer descrisse nel suo mondo come volontà e rappresentazione è rappresentazione del mal comune, der Wille, l’unica vera volontà che muove le recite del mezzo gaudio; la volontà scenica del male è il movente che, nell’Eden come al di qua, mosse il delinquente nella sua mistificazione mistica. Lui avrebbe voluto scrivere un libro che si intitolasse: Il mondo come volontà dolorosa e rappresentazione gaudiosa, così, tanto per chiarire una buona volta che la mistica teatrale delle speranze umane è azione scenica di un unico dramma: il mal comune.
Lui aveva veramente, per l’immagine e l’allegoria che mascherano la profondità del mal comune, perfino dell’odio, come scrisse Nietzsche; trovava così sgraziata la volontà dolorosa che macchinava sempre dietro le quinte di tutte le rappresentazioni del mezzo gaudio che nutriva un odio profondo per ogni aggraziata allegoria che quel gaudio inscenava: era solo un trucco, un trucco scenico, nient’altro che un volgare effetto speciale.
Eloquenza…
L’eloquenza, nel suo più alto vertice, lascia poco posto per la ragione o riflessione; ma rivolgendosi completamente alla fantasia o agli affetti, affascina gli ascoltatori disposti e soggioga il loro intelletto. Fortunatamente, questo vertice vien conseguito di rado. Ma ciò che un Tullio o un Demostene avrebbero potuto a malapena compiere su un uditorio di romani o di ateniesi, qualunque cappuccino, qualunque predicatore ambulante o fisso può conseguire nei confronti della generalità degli uomini, ed in grado più alto, colpendo queste passioni grossolane e volgari.
I molti esempi di miracoli inventati, di profezia e di eventi soprannaturali che, in tutte le età, o sono stati smascherati da un’evidenza contraria o si sono smascherati da se stessi colla loro assurdità, provano a sufficienza la forte inclinazione degli uomini allo straordinario ed al meraviglioso (the strong propensity of mankind to the extraordinary and the marvellous) e dovrebbero ragionevolmente far sorgere dei sospetti contro tutte le narrazioni di questo genere. [David Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – traduzione di Mario Dal Pra – pag. 185]
Eloquence… La retorica del mezzo gaudio persegue the marvellous come la filosofia segue a τὸ θαυμαστόν: il meraviglioso; la meraviglia, ἡ θαυμασία, è cosa meravigliosa, τὸ θαῦμα, perché guarda con meraviglia, θαυμάζω, la visione, ἡ θέα, che le procura una specie di divinità: ἡ θεά. Queste “catene etimologiche” lo facevano andare in brodo di giuggiole; da questa catena, poi, Lui si piccava di mostrare la dipendenza linguistica del divino da θεάομαι, vedo, e quindi da τὸ θέατρον, il teatro, luogo di spettacolo (tele)visivo quant’altri mai: τὸ θαῦμα, la meraviglia, e τὸ θέαμα, la vista, erano il “poli-teama” dello spettacolo meraviglioso e stupefacente che il mezzo gaudio inscenava sul mal comune nella mistificazione mistica di una divina meraviglia. E questo prova che…
…non c’è nulla di misterioso o di soprannaturale nei fatti, ma che tutto dipende dalla consueta inclinazione degli uomini verso il meraviglioso (the usual propensity of mankind towards the marvellous) e che, per quanto quest’inclinazione possa ad intervalli trovare un freno nel buon senso e nella cultura, non può mai venire completamente estirpata dalla natura umana. [David Hume: Ricerca sull’intelletto umano – Economica Laterza, Bari 1996 – traduzione di Mario Dal Pra – pag. 187]
Proprio per tal motivo Lui temeva che la desistenza non sarebbe mai stata attuata dal genere umano: perché la dipendenza degli uomini dal meraviglioso è assuefazione a quello stupefacente al quale meno essi riescono a rinunciare. «Mi sa che sto percorrendo un binario narrativo parallelo a quello percorso ne La nascita della tragedia da Nietzsche – pensava Lui –: senza accorgermene ho interpretato il mezzo gaudio come schematismo fantastico e immaginario del meraviglioso e dello straordinario teoretico». E gli veniva in mente quella frase de La nascita della tragedia nella quale Nietzsche diceva che «Nello schematismo logico si è chiusa in un involucro la tendenza apollinea».
Teoretico è aggettivo che parla di θεάομαι: θεωρητικός è colui «che osserva»; ἡ θεωρία è «il guardare» come sostantivazione di θεωρέω è «guardare». In ultima analisi, τὸ θέατρον è τὸ θεώρημα sono sinonimi: la visione è spettacolo; persino la teoresi, ἡ θεώρησις, è spettacolo. The strong propensity of mankind to the extraordinary and the marvellous è inclinazione al mezzo gaudio spettacolare e supefacente che per qualcuno è semplicemente rappresentazione, per qualcun altro sacra rappresentazione, a seconda che si voglia vedere o meno la divinità, ἡ θεά nella visione di ἡ θέα. Le rappresentazioni gaudiose rappresentate dal mezzo gaudio sul palcoscenico del mal comune sono – per dirla ancora col Nietzsche de La nascita della tragedia – «macchie luminose per sanare l’occhio offeso dall’orrenda notte».
Certo, Lui era cosciente del fatto che sarebbe stato troppo semplicistico ridurre il mal comune a dolorosa volontà dionisiaca e il mezzo gaudio a gaudiosa rappresentazione apollinea, anche se qualche analogia era innegabile. Lui, a differenza dell’uomo greco idealizzato da Nietzsche, pensava che si potesse benissimo fare a meno della rappresentazione, più o meno sacra, del Teatro del Mondo perché il dionisiaco non era necessariamente da “teorizzarsi” nelle magnifiche illusioni apollinee: sostituire la rappresentazione etica dell’esistenza con quella estetica è certo già un bel modo per liberarsi dal moralismo della sacra rappresentazione – pensava Lui – ma, a ben vedere, Nietzsche poteva fare di più: poteva teorizzare il boicottaggio della teatralità. Sì: rifiutarsi di andare a teatro. Se «ogni vita riposa sull’illusione, sull’arte, sull’inganno, sulla prospettiva, sulla necessità della prospettiva e dell’errore», un motivo in più per boicottarne il politeama.
«Questo Dioniso pagano, che muore e rinasce continuamente come il dioniso cristiano, va ucciso una volta per sempre – pensava Lui –, ma una voce fuori campo, che forse era la sua coscienza teoretica, gli diceva: non puoi ucciderlo, perché lui è la vita, la natura sempre nascitura». Bella roba! Dioniso rinasce continuamente nella coscienza ontologica umana sotto le specie della rappresentazione: ogni nascita ontologica della tragedia è rinascita esistenziale della commedia. Ogni rappresentazione gaudiosa è transustanziazione della volontà dolorosa: la messinscena gaudiosa allestisce sempre e solo il mistero doloroso del mal comune, è pura e semplice mise en scène.
Viviamo fra scenate continue: ogni manifestazione di vita politica è teatralità che rappresenta scenate sociali. Lui ovviamente intendeva “politico” nel senso di πολιτικός: ogni essere umano è cittadino, ὁ πολίτης, di quella città, ἡ πόλις, che è il cosmo, ὁ κόσμος, per cui Lui intendeva politico nel senso lato di cosmopolitico: ὁ πολίτης κοσμοπολίτης, il cittadino cosmopolita. L’unica cosa che non gli andava era il fatto che il cosmo, ὁ κόσμος, non significasse, grecamente, ‘il cosmo’ ma «l’ordine»: il fatto che la politica, ἡ πολιτεία, fosse alla ricerca continua di un “ordine pubblico”, era per Lui la prova provata che il disordine, non l’ordine, fungeva da sostrato politico della rappresentazione gaudiosa; la quale ultima cercava, anzi di “fare ordine” nel senso cosmetico, κοσμητικός, del termine: la rappresentazione gaudiosa è la cosmesi della volontà dolorosa.
La politica è essenzialmente cosmetica: κοσμητική (τέχνη) «arte dell’abbellire» le brutture della vita. Gli si rimproverava un certo disimpegno sociale, ed in effetti, Lui, da quando aveva chiarito finalmente a se stesso l’essenza della rappresentazione gaudiosa, vedeva in ogni manifestazione dell’agire politico – politico in senso lato, cioè cosmo-politico –, una maniera oziosa, cioè inutile – ed anche patetica – di mettere ordine in una scenografia cosmologica che si fonda sul disordine: il caos plateale della volontà dolorosa. Le rappresentazioni sceniche dell’esistenza sono metastasi della tumefazione ontologica del mal comune: un tumore che non si può asportare, si può solo cosmetizzare, cioè truccare. La cosmesi rappresentativa è la “chemio” che il mezzo gaudio inscena, ora e sempre, per limitare gli effetti cancerogeni del mal comune.
«Il trucco della rappresentazione gaudiosa è una fregatura bell’e buona – pensava Lui –, è l’inganno “politico” che fa credere efficace l’impegno sociale: ogni politico dice sempre che “non c’è trucco, non c’è inganno”, ma per forza di cose, nonostante la sua buona fede, tutto il suo impegno è comunque un gioco di prestigio: il prestigio di un politico è il prestigio del prestigiatore, perché praestigia, ae è sostantivo femminile che vuol dire ‘inganno’. Il prestigiator, oris è un ciarlatano, un impostore». Mentre pensava queste cose, gli venne in mente la figura di Guido Rossa, quell’operaio e sindacalista comunista assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979, a soli 45 anni… (ancora la maledizione del numero 45) …alla televisione, Rai Storia aveva trasmesso una fiction che rievocava in modo toccante la vita di Guido Rossa, e Lui si era proprio commosso, nel vedere l’eroismo civile di quell’uomo, il suo impegno politico…
Pensando all’impegno sociale di un Guido Rossa Lui era tentato di vergognarsi, del proprio disimpegno civile, perché figure come quella del Rossa sono degne del massimo rispetto; e, pure, pensava anche che se la desistenza si fosse attuata prima di quel funestissimo 24 gennaio 1979, Guido Rossa avrebbe potuto risparmiarsi il proprio sacrificio. Non c’era niente da fare: più l’esistenza umana metteva in scena le sue efferatezze, più Lui, oppresso dalla compassione, auspicava la fine di tutto; non solo un comunista, ma nemmeno Nietzsche, l’avrebbe approvato, un auspicio del genere, perché era sintomo di disfattismo, di renitenza alla volontà dolorosa, in una parola, sintomo di quella malattia che nasce da una cupiditas vacui che è l’esatto contrario del più comune, e perciò sano e normale, horror vacui…
…l’ipnotico senso del nulla, la quiete del sonno profondissimo, insomma l’assenza di dolore – questo può considerarsi per i sofferenti e per i radicalmente scontenti già come bene supremo, come valore dei valori, questo deve essere stimato da costoro come positivo, deve essere avvertito come il positivo stesso. (Secondo la stessa logica del sentimento, il nulla, in tutte le religioni pessimistiche, è chiamato Dio). [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Terza dissertazione, § 17 – pag. 129]
Dopo aver visto una fiction come quella che Rai Storia aveva mandato in onda per ricordare Guido Rossa, chi poteva esimersi dal provare incondizionata ammirazione per questo eroe? e ammirazione per Guido Rossa significa senz’altro ammirazione per il sindacalismo e per il comunismo di quegli anni; i brigatisti rossi “sbandarono” talmente a sinistra da diventare carnefici dei comunisti: l’essere-di-sinistra andò così a sinistra da diventare un essere-di-destra! Tant’è che i comunisti definivano fascisti i misfatti delle Brigate Rosse. «A questo mondo succede sempre così – pensava Lui –: quando la destra va troppo a destra la si accusa di essere diventata di sinistra e, analogamente, quando la sinistra va troppo a sinistra la si accusa di essere diventata di destra. Il nero che eccede diventa rosso e il rosso che esagera diventa nero». E gli veniva in mente Shakespeare: “è così tardi, che tra un po’ si potrà dire che è presto”.
Povero Guido Rossa. Povero Cristo. Poveri Tutti, i poveri cristi! Per dare un senso alla loro esistenza cadono nella trappola dell’essere: l’imboscata che ogni fede “politica” tende al mal comune si risolve sempre in un agguato mortale contro loro stessi; poco importa se sia agguato BR, agguato fascista o agguato comunista, perché dietro ad ogni agguato c’è la buona fede di una cattiva coscienza convinta di essere nel giusto: la presunzione della verità diventa sempre agguato mortale contro una presunta falsità. Non si può negare che le Brigate Rosse fossero veramente convinte di essere nel giusto, pensò Lui, sennò non avrebbero fatto tutto ciò che hanno fatto: nessuno farebbe nulla, se fosse realmente convinto dell’inutilità e dell’ingiustizia di ciò che fa. È la convinzione “politica” di far bene e di essere utili che muove ogni azione, anche quando questa convinzione diventa movente di crimini inauditi.
Una fede “politica” è come il mezzo gaudio: si contenta di una contentezza relativa, parziale, partitica, appunto. Per questo Lui era apolitico – e apartitico –: per non dover essere parziale. La parzialità del mezzo gaudio è la dimostrazione della sua impotenza: esso non riuscendo mai a raggiungere il fine di una completa finitezza, non è mai perfetto: non porta mai a compimento quel perficio che solo al participio passato fa perfectum. «Solo ciò che è finito, è giunto al termine, al proprio fine – pensava Lui –, ma, quando “è finito”, esso acquista coscienza del suo stesso essere finito: essere limitato, e dunque, di nuovo, imperfetto, non finito. Un ideale politico non si realizza mai perché è un ideale finito, parziale, partitico, che, nomen omen, essendo finito è appunto finito a priori, prima ancora di cominciare».
Gli spiaceva dover sacrificare i poveri cristi caduti negli agguati “politici” sull’altare del relativismo partitico, ma, onestamente, non si sentiva colpevole della sua defezione, perché una defezione di questo tipo non è una diserzione… desistenza sì, ma non diserzione. Non è un disertore, un desistente, perché non tradisce nessuna legge, né militare né civile: tradisce solo la legge ontologica dell’essere per poter tradire la legge ontica dell’esistere; ma nessuna legge esistenziale è giustificata da qualche legge civile o militare, e tantomeno la legge ontologica lo è. Una legge implica dei doveri che nascono dal dovere di obbedire alla legge innanzittutto, ma il dovere di obbedire alla legge ontologica dell’essere non è un dovere né civico né militare – è solo un dovere morale –, sì che essere esistenti non è né un diritto né tantomeno un dovere. Solo una visione partitica può spacciare per dovere quello ontologico di essere, perché parte dal presupposto che il dovere derivi da una legge decisa politicamente, ma nessuna legge decisa politicamente – seppur democraticamente – ha il diritto di porsi come legislatrice del diritto ontologico.
La giustificazione ontologica del dovere di essere deriva dalla moralizzazione del diritto di esistere; la moralizzazione è un’operazione curiosa: fa salire di grado ogni aspirazione al giusto, al punto da legalizzare ontologicamente ciò che solo onticamente è, al limite, legalizzabile. Ogni diritto civile è in cerca di una giustificazione più alta che rinforzi la propria legalità politica nella forza di una legalità morale: se un diritto politico riesce a dimostrare che si fonda su un diritto umano, la sua forza legale è totale; ma l’equipollenza di umanità e moralità è l’aporia che invalida tale problematica legalizzazione. Il diritto alla vita è la più sordida e subdola tra le moralizzazioni di diritti politici: «il diritto alla vita è un diritto esistenziale, non ontologico – pensava Lui –, cioè è un diritto che entra in vigore solo dopo che la vita è entrata nel mondo, cioè in vita».
Ecco l’aporia insita nella moralizzazione della legalizzazione dello jus vitae – così lo chiamava Lui –: dare valore retroattivo a una legge che non può aver valore prima della sua stessa entrata in vigore, che è l’entrata in vita; dare valore retroattivo al diritto alla vita è far retrocedere detto valore oltre l’esistenza al di qua, spingendolo nell’utopia internazionale delle genti che non hanno luogo: il diritto delle genti nasciture che ancora non sono nate è lo stesso diritto delle genti moriture che sono già morte. Il valore retroattivo ha lo stesso valore di un valore postattivo: la moralizzazione di un diritto civile, in senso politico, è retrodatazione di un’efficacia giuridica assegnata ad una anteriorità ontologica che, esistenzialmente, non ha alcun valore; fuori dei confini esistenziali posti tra i termini biologici di una vita, cioè tra una data di nascita e una data di morte, c’è una terra nella quale non vige nessun diritto civile, perché ogni diritto civile è un diritto politico avente valore esistenziale, non ontologico. Ogni caparra sull’al di là che un diritto esistenziale vuole il diritto di reclamare, è come un assegno postdatato che voglia spingersi oltre la morte del beneficiario.
«Se la morte è il terminus post quem scade la legalità di ogni diritto politico-esistenziale postdatato, pensava Lui –, allora mi si conceda anche che la nascita è il terminus a quo decade la legalità di ogni diritto politico-esistenziale antedatato. La legge dei contrari lo impone». I diritti metafisici sono quelli ontologici che si spingono oltre le loro reali possibilità esistenziali, sono quelli che fanno il passo più lungo della gamba, come si dice, laddove per gamba si deve qui intendere l’arto umano che permette di camminare su questa terra. La politica vive sulla propaganda che la sua stessa mania di grandezza diffonde: la mania di poter fondare ontologicamente il proprio limite esistenziale oltre il limite spaziotemporale della polis; se la politica riesce a fare questo, il legislatore si trasforma in un dio, e la sua potenza può allora veramente essere spacciata per volontà assoluta, altro che la volontà di potenza di Nietzsche!
La religione non ha fatto altro che legalizzare assegni postdatati dandogli un valore addirittura postumo – pensava Lui – e per farlo ha dovuto inventarsi la banca del paradiso: l’unica banca nella quale si può riscuotere un assegno postdatato oltre il limite della propria morte. Che altro è, riscuotere un assegno postdatato oltre la propria morte, se non reclamare la riscossione ontologica di un diritto che in sé sarebbe solo esistenziale? Tutti si preoccupano di rendere postumo l’effetto del loro assegno postdatato, ma perché Nessuno si occupa di rendere prenatale tale effetto? – pensava Lui. Se il diritto a riscuotere un assegno esistenziale può essere spinto così al di là da diventare un diritto di riscossione postuma, perché tale diritto non si può spingere al di là in senso contrario, a ritroso, retrocedendo verso la prenatalità?
Riflettendo sui due sensi di marcia teoricamente possibili: uno che va dall’essere vivo al non essere più vivo, ed un altro che va dall’essere vivo al non essere ancora vivo, Lui reclamava il diritto ad un assegno “predatato” che rendesse morale il diritto preontologico, cioè meontologico, a non esistere. Detto in soldoni, a Lui non interessava incassare un assegno che gli permettesse di riscuotere una vita eterna dopo la vita, bensì piuttosto una vita eterna prima della vita. Molto meglio un assegno prenatale, che un assegno postumo.
A ben vedere, la legittimità di un assegno prenatale si fonda sulla legittimità di un verso di lettura che in Occidente non è praticato: quello da destra verso sinistra. Lui era per una scrittura bustrofedica:
http://www.treccani.it/vocabolario/bustrofedico/
Bustrofèdico agg. [der. del gr. βουστροϕηδόν, avv., comp. di βοῦς «bue» e tema di στρέϕω «volgere»] (pl. m. -ci). – È così denominata la scrittura, che si ha in alcune iscrizioni antiche (greche, italiche, latine), nelle quali la direzione cambia da riga a riga, cioè da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e così via, come si volgono i buoi che arano; e iscrizioni b. sono dette le iscrizioni in cui si riscontra tale scrittura.
La mania peggiore di un rectus è quella di pretendere che il suo versus non sia retto, non sia corretto – pensava Lui –: ma lo sa, un rectus, che se è ‘retto’ lo è solo per l’autoritarismo del suo rego, is, rexi, rectum, ere: dominare? La reggenza del retto è monarchica, perché si fonda sul potere di uno solo, da μόνος + ἀρχή = ἡ μοναρχία, sì che solo il rectus rex si arroga la legittimità dell’«essere corretto» facendo finta di ignorare che la co-reggenza, nemmeno troppo implicita nella parola cor-retto, reclama il diritto del versus a qualche “correità di diritto” in un iter giuridico di tipo bustrofedico; l’arrogarsi tutto il diritto della correttezza, da parte del rectus, è mera arroganza. La par condicio nel verso di lettura del percorso ontologico-esistenziale pretende giustamente il suo double face.
«Se bustrofedico è aggettivo che rimanda alla possibilità di uno στρέϕω “contromano” – pensava Lui –, la stroficità della rettitudine si potrà, anzi, si dovrà anche rivoltare in antìstrofe», e rifletteva sul termine antìstrofe, derivante dal latino tardo antistrŏphe & antistrŏpha, e ancor prima dal greco ἀντιστροϕή, sostantivazione di στρέϕω, «voltare», col prefisso ἀντί, donde «contro, in senso inverso»: l’antistrofe è il “controsenso” della strofa, il nonsense delle strofe, la bustroficità dell’essere. Se si pensa poi che, storicamente, antìstrofe era la parte dell’antico coro greco che ritmicamente e melicamente ripeteva la strofe e orchesticamente ne riproduceva, forse inversamente, gli schemi, allora il diritto all’arsi di ogni tesi e alla tesi di ogni arsi assume persino le pulsazioni cardiache del coro nella nascita della tragedia, cioè di un continuo alternarsi tra la sistole, im-plosione dolorosa di un “dionisiaco” mal comune e la diastole, es-plosione gaudiosa di un “apollineo” mezzo gaudio.
«L’apollineo solleva l’uomo dal suo orgiastico annullamento di sé», scrisse ancora Nietzsche ne La nascita della tragedia. Era dunque un orgiastico annullamento di sé, che Lui voleva? Ci pensò molto, su, e concluse che Lui non voleva semplicemente una cosa: la mistica e mistificante rappresentazione gaudiosa che Tutti si godevano quando la Compagnia del Mezzogaudio recitava, tutto qui; se poi non volere questo implicasse il volere un annullamento orgiastico di sé, questo non lo sapeva bene; ci avrebbe dovuto pensare, e infatti ci pensò.
«Orgiastico», al di là del suo riferimento storico alle “orge” celebrate in onore di Dioniso, è aggettivo che parte da ἡ ὀργή: umore, impulso naturale; ὀργάω è essere prossimo a produrre, essere eccitato, e da qui si arriva a τὸ ὄργιον, cerimonia iniziatica, sacrificio… lo stesso «orgasmo» viene da ὀργασμός passando per ὀργάω ma, lasciando stare le implicazioni sessuali dell’orgiastico, quello che è interessante notare è che τὸ ὄργιον confina con τὸ ἔργον, l’azione, la cui energia origina δράω, agisco, donde l’azione scenica del dramma, ‘azione scenica’ che prende le mosse proprio dall’energia di δράω, affine a ἔρδω che nel sinonimo ἐργάζομαι tradisce la potenza scenica di quell’energia drammatica.
Lui pensava che il mal comune, impulso tragico e naturale dell’umana natura, senza l’orgiasmo dell’ (ὁ) ὀργιασμός derivante da ὀργιάζω non potesse «celebrare le orge» del mezzo gaudio orgiastico, cioè il mistero del doloroso che diventa gaudioso: insomma, l’orgiastico annullamento di sé di cui parla Nietzsche, per Lui era l’implosione sistolica di una contrazione privata della sua correlativa espansione diastolica. Per questo Tutti vogliono il mezzo gaudio, perché senza di esso la visione tragica del male, non filtrato dalla liturgia ecclesiale di una condivisione com-unicata, cioè messa in comune, non permette la celebrazione del mistero, cioè di quel rito misterioso per cui, con cui e in cui la gaudiosa rappresentazione può compiere il miracolo della transustanziazione del mal comune in mezzo gaudio. O magnum mysterium!
Il cappellano si fermò davanti a Lui e Lui manco lo vide, assorto ormai com’era nei suoi pensieri. «Fratello – gli disse il cappellano dandogli del tu – questa mattina, appena entrato qui in ospedale, eri, come dire? più… presente: giravi per le corsie, ascoltavi i discorsi dei pazienti, ti relazionavi a loro con affabilità premurosa, eri curioso di guardare ciò che avevi attorno a te… in poche ore sei cambiato tantissimo: dalle otto di stamattina alle quattro del pomeriggio, in otto ore, non sei più tu: che ti è successo? cos’è successo, fratello?».
Lui non poteva negarlo: era successso. Ma, come spiegargli ciò che era successo? Ciò che per Lui era un successo, per Tutti sarebbe stato un insuccesso, ne era sicuro: non tutto ciò che è successo a Qualcuno è per Tutti un successo… ma non era il momento di giocare con le parole, quello; così, cercò di spiegare al buon cappellano cosa gli era successo. «Padre – disse Lui –, mi è successo ciò che mi succede sempre: cioè, il riconoscere in ciò che vedo fuori di me le stesse cose che avevo già conosciuto in me; il riconoscere che conoscere è innanzitutto riconoscere fuori di noi le cose che già abbiamo conosciuto in noi». «Sì, fratello, – disse il cappellano –, in noi c’è quel maestro interiore che fece dire a sant’Agostino: noli foras ire! non uscire fuori! in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Fai bene, fratello, a non uscire da te per cercare la verità, ma, bisogna però che tu non ti isoli troppo, perché la verità, una volta ravvisata in noi stessi, ci rende avvisati del fatto che poi va messa al servizio degli altri, al servizio del prossimo… non lo vedi, qui, il tuo prossimo, fratello mio? nelle facce dei pazienti, di coloro che sono più sfortunati di te?».
Avrebbe voluto rispondere con un laconico: no. Ma non lo fece, per non deluderlo. «Sì, padre, le vedo, quelle facce, le ho viste, – disse Lui –, ma, vede, sono quelle stesse facce che già vedevo a casa mia, prima di venire qui, in ospedale; padre, non se ne abbia a male, ma, sono le facce di Tutti, quelle facce, di tutti quelli che abitano questo mondo, almeno, cioè di coloro che abitano il male della malattia: non c’è bisogno di uscire da casa, per vederle: basta guardarsi allo specchio». Non è che con queste parole povere credesse di aver risposto, ma era tutto ciò che aveva da dire, al riguardo, e quindi tacque. Anche il cappellano tacque. Così, tacendo tutt’e due, il dialogo poté ritenersi concluso. Fu uno dei dialoghi più brevi della sua vita, ma pazienza; il cappellano continuò per la sua via, e Lui anche.
Rimasto nuovamente solo, in verità, non si sentì così sicuro di quale fosse la sua via, per cui ricominciò a peregrinare tra le corsie, sperando di dare a quel vagabondaggio le parvenze mistiche di un pellegrinaggio; del resto, è ben per un pellegrinaggio spirituale che Lui aveva accettato il consiglio di Tutti di venirsene in ospedale; o no? «Tutte le volte che Qualcuno mi parla distogliendomi dai miei pensieri – pensava Lui –, i miei pensieri perdono quota, si abbassano, nonostante tutta la fatica che avevo fatto per farli decollare e salire in alto: certe volte la capisco, la colomba di Kant…». Faceva riferimento a quel passo della Critica della ragion pura in cui si legge che
La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria. Ed appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché esso pone troppo angusti limiti all’intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello spazio vuoto dell’intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto. [Immanuel Kant: Critica della ragion pura – Biblioteca Universale Laterza, Bari 1966 – Introduzione, Sezione III – pag. 38]
Non si sa se a una colomba sia mai capitato di pensare che, senza l’attrito dell’aria, essa avrebbe potuto volare più veloce ancora; una cosa però si sa: a Lui capitò senz’altro, di pensare che, senza gli attriti dialogici causati dagli altri, avrebbe potuto certamente volare più in alto e più velocemente, nel cielo puro del suo intelletto, senza la zavorra pesante delle chiacchiere e delle ciance di Tutti.
Kant riteneva Platone colpevole di aver abbandonato il mondo sensibile e di essersi “lanciato” sulle ali delle idee al di là di esso… jenseits derselben. «Ma che bella, quell’espressione: ‘sulle ali delle idee’, auf den Flügeln der Ideen, certe volte Kant riusciva anche a fare il poeta, senza volerlo – pensava Lui – Kant, poeta suo malgrado». Jenseits. Al di là, di là da, oltre, dall’altra parte. La moralizzazione è il propellente qui propellit, che spinge avanti, pro + pello: del resto, in latino «impulso» si diceva pulsus, us cioè con il participio del verbo pello, is, pepuli, pulsum, ere; esiste anche impello, che vuol dire colpire, spingere ed è in + pello = in-duco. Per capire il tracciato di ciò che è somatico, basta osservare il tragitto delle salme: dall’ospedale alla chiesa; in chiesa si pro-pelle l’impulso somatico oltre la sua somaticità: la pulsione di vita, che in ospedale decede, in chiesa è spinta jenseits verso la sua risurrezione. Se è vero che una pulsione è una quantità di energia che cerca una scarica, la sublimazione metafisica della pulsione di vita trova in chiesa la possibilità di scaricare tutta la carica accumulata nella frustrazione della pulsione di morte in ospedale.
Lui pensò che un’idea metafisica, cioè psichica, germoglia sulla corteccia fisica della somaticità: è dalla corteccia cerebrale che parte l’impulso a pro-pellere la vita al di là di se stessa; è così che la vita prende il volo ‘sulle ali delle idee’. Somiglia alla riproduzione per talea: la parte di una pianta emette radici e genera un nuovo individuo che conserva le stesse sue caratteristiche; la talea è il germogliare, θάλλω, di un pollone, ὁ θαλλός, che diventa rampollo, τὸ θάλος. In Kant la Ragione, die Vernunft, si riproduce per talea dall’Intelletto, der Verstand – pensava Lui –: un’Idea della Ragione è il rampollo di quel pollone chiamato Concetto, che rampolla sulla corteccia cerebrale dell’Intelletto: un’Idea della Ragione cresce su un Concetto dell’Intelletto, è una generazione spontanea. «Idea» viene dal sostantivo ἡ ἰδέα, il quale a sua volta viene dal verbo ἰδεῖν, vedere, sicché la Ragione, quando idealizza, non fa che vedere ciò che l’Intelletto concepisce: un’Idea è un Concetto sub specie speciei.
Ma, se non vogliamo credere, con Kant, che un concetto possa starsene beatamente a priori nell’anticamera pura della realtà, dobbiamo accettare l’idea (!?) che esso debba crescere a sua volta da quella che Hume chiama impression. Nel dibattito a distanza con Hume, proprio per salvare i concetti dalla loro problematica dipendenza dalla realtà, Kant li teorizzò autonomi nell’immacolato apriorismo della categoria. Come dire: esiste nella nostra mente il concetto puro di male, e se noi possiamo sentir male, è solo grazie a questo concetto puro, il quale si attiva nel momento in cui noi ci troviamo a dover provare il male: l’esperienza mette in moto il concetto puro, puro in quanto al di sopra degli eventi. «Ma pensa un po’ – pensava Lui –, mi verrebbe allora quasi da dire che, se noi non avessimo in testa il concetto puro di Male, manco potremmo sentire male, nel momento in cui la vita cominciasse a farci male. Oibò.»
La sporca ed impura realtà richiede dunque dei concetti puri, per poter essere capita? per poter essere pensata? e quale nesso congiungerà mai l’impuro estesico al puro noetico? Kant cavalcò con destrezza la distinzione tra giudizi analitici e giudizi sintetici:
In tutti i giudizi nei quali viene pensato il rapporto di un soggetto con un predicato, questo rapporto può essere di due specie. O il predicato B appartiene al soggetto A, come qualcosa che è contenuto (implicitamente) in questo concetto A; oppure B si trova completamente al di fuori del concetto A, sebbene stia in connessione con esso. Nel primo caso chiamo il giudizio analitico, nell’altro sintetico. [Immanuel Kant: Critica della ragion pura – Bompiani il pensiero occidentale, Milano 2004 – traduzione di Costantino Esposito – Introduzione, Sezione IV – pag. 83]
Nel giudizio sintetico, il predicato non è contenuto nel soggetto e si aggiunge ad esso, da fuori, portando il suo contributo genuino di conoscenza, cioè collegando (= sintetizzando) l’impuro empirico con il puro noetico. «Proviamo un po’ ad applicare questo discorso ai tre momenti della sublimazione – pensava Lui –, nel percorso dalla sensazione all’idea di sensazione passando per la moralizzazione della sensazione»:
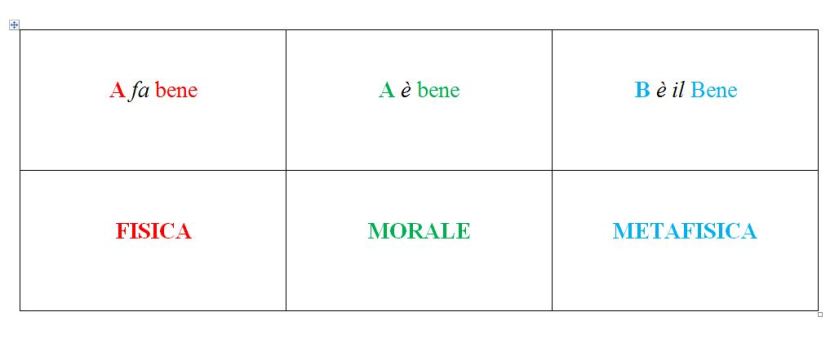
Rosso, Verde, Celeste. Domanda: l’Idea metafisica di Bene contiene o no in sé l’Esperienza fisica di qualcosa che fa bene? Se si risponde affermativamente, ci si pronuncia per un Giudizio Analitico; se si risponde negativamente, ci si dichiara per un Giudizio Sintetico. Se l’Idea di Bene fosse indipendente da ciò che fa bene fisicamente, significherebbe che non c’è bisogno di provare il benessere fisico per concludere al concetto di Bene: tale concetto sarebbe puro, perché non avrebbe bisogno di essere vidimato dalla sensazione fisica del sentirsi bene. Dal francese vidimer: l’Idea appone il suo vidimus senza il bene-stare fisico…. «Curioso: l’approvazione del bene-stare viene da uno stare-bene: quando si è d’accordo, si dice “sta bene”; invece, in un Giudizio Analitico, si verifica che a un Soggetto “stia bene” che un Predicato a lui riferito ‘stia male’ – pensava Lui – ma questo è menefreghismo puro del Concetto Puro. Il Bene non può permettere che gli si riferisca qualcosa che sta male, perché Egli è la referenza Buona di tutti i referenti che stanno bene. Se qualcosa che sta male si predica di ciò che sta bene, vuol dire che ciò che sta bene non sta poi così bene. E poi, se il Bene contenesse analiticamente solo tutti i predicati in salute, da lui si potrebbero dedurre solo soggetti sani, ma allora, i malati, come potebbero trovare in lui l’alto patronato del proprio concetto? come potrebbero indurre la propria malattia impura nel concetto puro di Salute che la salvezza del Ben-Essere patrocina? No. Per concepire il Concetto Puro di Ben-Essere ci vuole il bene-stare dello star-bene, c’è poco da fare». Così pensò, Lui.
E allora, se non poteva essere analitico, il Giudizio sul Bene, doveva per forza essere sintetico. Un Giudizio sintetico sul Bene è poi nient’altro che un Concetto di Bene che non contiene in sé il concetto di male ma lo accetta sinteticamente come un padre legittimo accetta la paternità di un figlio illegittimo. Il Male è estraneo al Bene, ma, sinteticamente, si unisce ad esso? il Male fa conoscere al Bene l’esperienza dello star bene? ma come può, il concetto di Male, aggiungere sinteticamente qualcosa al concetto di Bene, dal momento che il Bene è l’esatto contrario del Male? ci dev’essere un’incognita che fa da medium, tra il concetto di Bene = star bene e il concetto di Male = star male…
…l’incognita x su cui s’appoggia l’intelletto, quando crede di trovare, al di fuori del concetto A, un predicato B estraneo a esso, ritenendolo al tempo stesso congiunto con esso…
Se l’identità analitica tra il soggetto del Benessere metafisico e il predicato dello star bene fisico, tra il soggetto del Malessere metafisico e il predicato dello star male fisico, non ha il nostro benestare, qual è l’incognita che permette la sintesi di fisico e metafisico? «Potrebbe essere il giudizio morale che noi diamo sullo star bene e sullo star male – pensò Lui –, il giudizio morale potrebbe essere il medium che traduce lo star male nel Male e lo star bene nel Bene facendo passare lo star bene nel suo essere bene e lo star male nel suo essere male». Con questa illuminazione, Lui pensò di essersi già meritato il nobel: «dopo questa intuizione felice, posso benissimo ritirarmi in pensione e non fare più niente per tutta la vita: questo è il mio Hauptwerk».
Dopo questa sua geniale trovata, in effetti, Tutti cominciarono lentamente a credere che il Giudizio “si decidesse” impercettibilmente nel punto di fusione tra sensazione fisica e concetto metafisico, come in chimica il punto di fusione di una sostanza è il valore, di temperatura e di pressione, a cui coesistono la fase solida (= star bene o male) e la fase liquida (= essere bene o essere male) in equilibrio termodinamico: il valore. Quando lo star bene diventa un valore, ecco spuntare il suo essere bene: è bene, star bene; quando lo star male diventa un valore, ecco spuntare il suo essere male: è male, star male. Ma perché è bene, o è male, star bene o star male? Perché star male fa male, e Nessuno vuole star male, tranne i cristiani, che però sono l’eccezione che conferma la regola; e poi, i cristiani vogliono star male, sì, ma solo al di qua: se gli si togliesse la speranza di poter star bene al di là, anche loro fuggirebbero a gambe levate lo star male al di qua, perché Nessuno è così scemo da desiderare di star male al di qua senza il compenso compensativo di uno star bene al di là.
Quando pronunciò mentalmente il sintagma «compenso compensativo», Lui ebbe un’altra illuminazione delle sue: non sarà che il compenso al di là sia compenso solo perché va a compensare lo star male al di qua? In latino compenso, as, avi, atum, are significa controbilanciare, in quanto com + penso: è incredibile, che in latino penso sia voce del verbo «peso»! Eh già, difatti, a ben pensarci, il «penso» è proprio quel pensum che viene pensato come dovere, compito penoso e pesante… il peso dello star male al di qua, pensato, cioè pesato in un equo soppesare, va pesato assieme (= com-pensatum) al contrappeso dello star bene, va controbilanciato in un “pesare assieme” che è ‘pensare assieme’ al di qua e al di là per far sì che il bilancio consuntivo del Giudizio finale sia corretto. Lo star male al di qua è un penso? È il prezzo che si deve pagare per poter mettere sull’altro piatto della bilancia lo star bene?
Era giugno, faceva caldo, e da una finestra aperta in una grata dell’obitorio seminterrato Lui sentì il vociare querulo e petulante di alcuni venditori: «buon peso! buon peso, signori! venite, comprate…!». C’era un mercato, proprio lì, all’altezza della camera mortuaria; il vociare mercatale era petulante perché cercava di allettare promettendo il buon peso: petulare viene da petere, chiedere; ed era querulo perché era lamentoso: era un queri petulans, lo stesso della rogazione, pensava Lui. “Buon peso?” nessun peso è buono, se lo si deve portare sulle proprie spalle. Sapete come fa, un peso, a diventare semibuono? Si convince che al di là di sé c’è un contrappeso che lo bilancia, ecco come fa – pensava Lui –: quando sente che il suo peso lo trascina giù verso l’ingiustizia dolorosa di un bilancio negativo, cioè quando il piatto della bilancia sul quale lui sta cade vertiginosamente verso il baratro dello star male, allora lui pretende sull’altro piatto una rappresentazione gaudiosa che bilanci il suo penso doloroso, ed è così che il mal comune vede la propria sorte (ri)sollevata da un contrappeso miracoloso, il contrappeso del mezzo gaudio, che comunque è un contropenso pensato dal penso. E fu così che gli venne da pensare all’Io-penso di Kant: Ich-denke. L’Io è il “penso” di Dio?
«Se Io sono il penso di Dio, la mia esistenza è il compito che l’essere mi ha dato da fare per punizione – pensò Lui –, ma questo è impensabile, e quindi non è un penso». Scherzava sempre con le parole, Lui, così, tanto per sollevare un po’ il peso del proprio pensare… però, tra uno scherzo e l’altro, la serietà di questo pensare non lo esimeva dal proprio peso, sì che Lui pensò seriamente che lo star male fosse la causa fisica, ἡ αἰτία, che, nel punto di fusione morale, si sente responsabile, αἴτιος, e comincia a convincersi di essere il colpevole, ὁ αἴτιος, di quella «colpa», τὸ αἴτιον; sui due piatti della bilancia ci sono da una parte lo star male e dall’altra il Bene: l’ago della bilancia è la Morale, che, trasformando la causa fisica in responsabilità etica, permette la compensazione del penso doloroso ad opera del senso dcolpa, che, chiedendo perdono, crede di aver ricevuto per dono il contrappeso capace di riequilibrare le sorti della propria condizione. La Morale è l’ago che fa alla Bilancia la grazia di equilibrare lo star male fisico e il Bene metafisico mercé un giudizio moralmente positivo dello star male come essere bene; in questo modo i cristiani hanno pensato bene di valutare positivamente il loro star male: dandone una valutazione morale. Gran cosa, la moralità!
«Se la Morale ha questo potere perequativo straordinario, che sa addirittura trasformare il male in Bene – pensava Lui –, essa merita davvero un serio approfondimento etimologico». E così, pensando alla Morale, cominciò a cercare sui dizionari da dove mai le provenisse, questo potere straordinario…. cerca e cerca, scoprì ciò che già sapeva: Morale viene da mos, moris, ma questa non è che la morale latina della più antica morale greca, la quale ultima è Etica, non morale… purtroppo, però, l’Etica di τὸ ἔθος è in primo luogo «abitudine», ahimè. Onestamente, Lui sperava di rintracciare una traccia più metafisica dell’abitudine e del costume, perché non può solo essere una questione di costume o di abitudine il fondamento della Morale: ma, poi, pensò che se la Morale deve fare da ago della bilancia tra Fisico e Metafisico, essa deve partecipare sia della fisicità sia della metafisicità, un po’ come lo Schema kantiano, o come l’Eros platonico… deve poter tenere il piede in due staffe… in fondo è comprensibile, che l’abitudine sia morale: mos, moris è il “buon costume” di individuare nella morale l’unica interprete che conosce entrambe le due lingue, quella fisica e quella metafisica, del Bilancio umano, e quindi l’unica in grado di tradurre il codice analogico dell’estetica nel codice logico della noetica; un buon interprete deve conoscere bene tutt’e due le lingue di cui vuol appunto farsi interprete, per poter tra-durre, traghettare il fisico su su nel metafisico.
Far bene è fare come “si costuma”. In italiano «costumare» è sia avere per costume sia educare: mos, moris significa «maniera di comportarsi» così com’è «abitudine», ἔθος. La Morale si fonda, eticamente, sull’usanza, la costumanza del costume, cioè sulla Tradizione che traduce, trasporta, da qui a là. La Metafisica è il traslato della Fisica, la figura retorica che «porta oltre» secondo l’etimo metaforico di μετά + φέρω. A Lui venne in mente Caronte, il traghettatore dantesco di Inferno III:
Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare.
Caronte era lo psicopompo, cioè il traghettatore di anime nell’Ade; il suo nome assona nel calembour χαῖρ’ ὦ Χάρων: «salve, o Caronte». Già. Nel saluto greco, χαῖρε, c’è il χαίρω, il gioire, che è arrivato sino al nostro «Salve!» passando per la Salus latina: dire «Salve!» è dire «Salute!», cioè dire Caronte. Ancora una volta la grazia, ἡ χάρις, come fonte del gioire salutare di un traslato metaforico che trapassa al di là: la grazia è la tradotta dei trapassati.
Non si sa, come gli venissero, questi lampi aforistici, che riassumevano motteggiando, nell’apparente, quaresimale compunzione della boutade semiseria, l’ossimoro derivante dalla compresenza di doloroso e gaudioso nella gaia scienza del suo argomentare la concordia discors di mal comune e mezzo gaudio. Tant’è. Caronte psicopompo….! Caronte mistagogo…? Nel suo gergo, mistagogo era colui che inizia alla mistificazione mistica; in realtà, il mistagogo era, nei riti misterici dell’antica religione greca, il sacerdote che dava un’istruzione preliminare a coloro che dovevano essere iniziati. Aveva buon gioco, Lui, con questa sua lettura etimologica, perché poteva dimostrare linguisticamente che la Morale è la graziosa traduttrice che traduce il Male in Bene facendosi interprete del mezzo gaudio, così, per vezzo.
Non a caso aveva detto che il mezzo gaudio agisce per vezzo: vezzo significa «abitudine», dal latino vitium, il quale, però, non parla certo di virtù anche ad uno che il latino non lo sappia. Il mezzo gaudio agisce per vezzo perché conosce l’arte di entrare nelle grazie di Tutti: agisce per vezzo perché è vezzoso, grazioso: l’allotropo del vizio. Il vezzoso si ingrazia Tutti perché si presenta come grazioso, carino. La forza della grazia è la sua vezzosità, e la sua vezzosità sta nel vizio di fare quello che Tutti vogliono che si faccia: ciò che si fa per abitudine, com’è costume. Per questo il gaudio è mezzo, strumento di catarsi nella trasformazione scenica del male in Bene.
«Forse, al mezzo è toccata la strana sorte lessicale di chiamarsi così perché, appunto, si trova nel mezzo – pensava Lui –, a metà tra ciò che è in potenza e ciò che è in atto, tra un’intenzione e la sua realizzazione; il gaudio dell’essere bene è il mezzo per trasformare lo star male in Bene grasie al suo essere in mezzo, a metà tra lo star male e il Bene: perciò è mezzo-gaudio, perché sta tra il dolore del mal rosso al di qua e la gioia del gaudio celeste al di là». Così Lui intendeva dare finalmente un colore anche al male: rosso; se la gioia del paradiso è celeste, il male è rosso: il mal rosso è il mal comune, così aveva deciso, Lui (forse perché si firmava sempre in grassetto rosso, ma non è sicuro). Il mezzo che il gaudio usa per sanare lo star male è fargli la morale, e fargli la morale consiste nel convincerlo che il suo star male è un penso da pensarsi come causa di una colpa molto lontana, la quale ultima è essere male solo perché rifiuta di essere controbilanciata da un essere bene che gli deriva dal Bene stesso, qualora lo star male accetti di riconoscere tale colpa e ne chieda perdono al Bene; ma se lo star male chiede perdono, improvvisamente, sull’altro piatto della bilancia, si materializza, non si sa come, il peso soprannaturale del suo essere bene, l’unico in grado di portare il bilancio in pareggio, cioè la bilancia nella sua corretta posizione, con i due piatti perfettamente allineati in linea retta. Quando star male ed essere bene si “pensano” assieme, lo star male riceve il com-penso del suo male in virtù del vezzosissimo vezzo morale, il cui sintomo godurioso è il famoso mezzo gaudio, l’org(i)asmo dei miti ed umili di cuore.
Da dove arriva, il vezzo di immaginare graziosa la grazia che salva? dal vezzo platonico di legare Buono, Vero e Bello? A Lui veniva in mente Giovanni 10,11: «Io sono il buon pastore». Ego sum pastor bonus. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· È in greco, che il Buono ammette la sua agnizione dal Bello: il Salvatore è ὁ καλός, è il Buono in quanto Bello. Per quel che riguarda il Vero, in Giovanni 14,6 c’è l’autodichiarazione anche del Vero: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me», e c’è persino il mezzo: Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ. Ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me.
La tradizione che vuole l’identità di Bello e Buono risale al noto καλὸς κἀγαθός, crasi di καλὸς καὶ ἀγαθός: ἡ καλοκἀγαθία è il carattere o la condotta nobile del καλοκἀγαθός, la nobile virtù platonica dell’essere Bello e Buono, anzi, Bello in quanto Buono. Nel III canto del Purgatorio, Dante si ricorderà della καλοκἀγαθία quando, vedendo Manfredi di Sicilia, dirà: «biondo era e bello e di gentile aspetto», e se ne ricorderà anche Mario Tobino, quando intitolerà Biondo era e bello la sua bella biografia di Dante Alighieri; ma la καλοκἀγαθία arriva da più lontano: dal Primo Libro di Samuele, dove, a 16,12, del futuro re Davide si dice che «Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto». Erat autem rufus, et pulcher aspectu, decoraque facie… πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν καὶ ἀγαθὸς…
Il vezzo di immaginare Bello il Buono è inveterato. «La bellezza salverà il mondo» è vezzo che riprende una frase del principe Miškin ne L’idiota di Fëdor Michajlovič Dostoevskij e che si può tranquillamente citare insieme a quell’altra celebre frase di Martin Heidegger: «Ormai solo un dio ci può salvare», come suona il titolo che la redazione del giornale tedesco Der Spiegel diede a un colloquio che si svolse tra Heidegger e due inviati del settimanale: solo un dio “bell’e buono” ci può salvare. Il bell’e buono è il pontifex, il Sommo Pontefice, costruttore del ponte che traduce il male fisico del dolore al di qua nel bene metafisico della gioia al di là: questo è il «Vero bell’e buono»:
…l’uomo verace, in quel temerario e ultimo significato con cui la fede nella scienza lo presuppone, afferma con ciò un mondo diverso da quello della vita, della natura e della storia; e in quanto afferma questo “altro mondo”, come? non deve per ciò stesso negare il suo opposto, questo mondo, il nostro mondo?… È pur sempre una fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella scienza – anche noi, uomini della conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, continuiamo a prendere anche il nostro fuoco dall’incendio che una fede millenaria ha acceso, quella fede cristiana che era anche la fede di Platone, per cui Dio è la verità e la verità è divina… [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Terza dissertazione, § 24 – pag. 147]
Ciò che è bell’e buono è vero: una verità bell’e buona. Certe volte i modi di dire sono veraci, verità bell’e buone. Certo, che, se per essere vera, una verità deve anche essere buona, allora si capisce come la religione abbia potuto promuoverla a divinità: la bontà – nonché la bellezza – sono tratti antropomorfici che richiedono di assumere le fattezze di un essere animato, vivo. Per questo il Cristo ha potuto dire di essere la Verità e la Vita: come fa, una verità morta, ad essere bella e buona? Sarebbe una falsità bell’e buona!
La creatura ama fare come il suo Creatore: prende della terra dal suolo, ne fa un fantoccio, poi gli soffia sopra convinto di avergli dato la vita, e, dopo avergli dato la vita, mette quel fantoccio tra le proprie verità belle e buone. Fuor di metafora, la terra presa dal suolo sarebbe la solida coscienza di star bene, a cui l’uomo dà la parvenza di essere animato nella coscienza che star bene è bene, e poi, dopo averlo animato, gli dà anche la bellezza e la bontà, affinché esso, come in un cartone animato di Walt Disney, possa ricreare la creazione primigenia nella convinzione di essere la Coscienza di Essere: è una rappresentazione in tre atti che ricapitola tutta la storia del genere umano.
Certe volte Lui si sentiva d’accordo con Nietzsche: il cristianesimo è un platonismo per il popolo. In effetti, il platonismo, in sé, non è affatto per il popolo, anzi, è aristocratico anzichenò: per Platone, solo i veri filosofi, i filosofi bell’e buoni, i migliori, οἱ ἄριστοι, riuscivano a interrompere la catena delle reincarnazioni per fissare definitivamente “gli occhi dell’anima” su quelle Idee iperuraniche, che sono l’eterna Verità delle cose, senza dover mai più scendere al di qua a guardare le brutte copie di quelle. La beatitudine platonica è la contemplazione degli originali ontologici; contemplazione alla maniera teoretica espressa dal verbo θεωρέω: contemplazione come speculazione. E gli veniva in mente Prima ai Corinzi 13,12: «Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto», βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum.
«Non ci si pensa mai, che la speculazione, in quanto riflessione, riverbera l’azione dello specchio, – pensava Lui –: lo speculum, lo specchio, per sua natura riflette un’immagine, e, quando san Paolo dice che noi, al di qua, vediamo come per speculum, non fa altro che recitare la lezione cattoplatonica secondo la quale le cose di quaggiù sono ‘vere’ nella misura in cui rispecchiano le cose di lassù». Colossesi 3,1-2: «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra». Ma sarà vero, che noi, quaggiù, conosciamo nella misura in cui ri-conosciamo?
Ma, per il cristianesimo, la salvezza non è solo una questione di conoscenza: è innanzitutto una questione di riconoscenza, e non nel senso platonico appena detto; riconoscenza come sentimento di chi è riconoscente, non di chi riconosce in una copia l’originale. Sentimento: è tutta in questa parola, la novità che il cristianismo apporta al platonismo: prima di Cristo, per salvarsi bastava conoscere, dopo Cristo bisogna anche riconoscersi riconoscenti. C’è un sinonimo di riconoscenza, in senso cristiano, che rende bene il significato di questa parola: gratitudine. La gratitudine inizia proprio con quel «grati…» che subito fa venire in mente la gratuità: infatti, «gratis» è parola che viene dal latino come forma contratta di gratiis, ablativo plurale di gratia «grazia» con valore avverbiale di «graziosamente».
«Certo, se Dio è amore, lo si conosce innanzitutto amandolo», pensava Lui, al quale non andava proprio giù quell’aggiunta cristiana di sentimento ad un’attività, quella gnoseologica, che per Platone da sola bastava a salvarsi l’anima. «E certo – pensava Lui – dal momento che il cristianismo ha rivelato lo Spirito di Dio come Amore, l’Anima non avrebbe più potuto salvarsi semplicemente conoscendo delle verità, ma piuttosto riconoscendosi bisognosa di questo Spirito, cioè di questo Amore, che è la Verità delle verità». Dopo Cristo, l’anima è tornata ad essere ciò che etimologicamente è sempre stata: anima-zione di un corpo anima-to, cioè qualcosa di troppo anima-le, per poter essere spirituale; l’anima è solo il fiato dell’animale uomo, e per respirare ha bisogno dell’alito di Dio, quel soffio che in Genesi dà l’animazione al fantoccio di fango plasmato dal Creatore: l’alito di Dio è quel respiro che, linguisticamente, nella teologia soffia come Spirito Santo. Lui pensava che la gente avrebbe dovuto saperle, queste cose, e innanzitutto sapere il dato etimologicamente oggettivo che fa sia dell’Anima (profana) sia dello Spirito (santo) delle esalazioni più o meno sacre di soffi vitali: in latino anima significa «fiato» come in greco ὁ ἄνεμος significa «vento» (si pensi all’anemometro) e in greco τὸ πνεῦμα significa «alito» (si pensi allo pneumatico) come in latino spiritus significa «soffio d’aria»: quando in italiano si dice «spirare», ci si può riferire sia al soffiare del vento (lo spirare di un venticello) sia all’esalare l’ultimo respiro (il rimettere l’anima a Dio).
Quello che emerge, da un’osservazione neanche troppo attenta dell’«aerodinamica» cristiana, è che l’Anima, per sopravvivere (= vivere sopra, al di là) deve intubarsi nello Spirito Santo di Dio stesso: come se l’esistenza quaggiù fosse una vita da passarsi interamente in camera di rianimazione, in terapia intensiva, al fine di riattivare col bocca a bocca continuo dell’amor di Dio quella respirazione originale che Adamo ed Eva avevano compromesso, cioè manomesso; insomma, o si passa l’esistenza rassegnati ad una intubazione a vita, o, nell’istante della morte, si muore per sempre, perché il fiato anima-le respira grazie all’alito di Dio. Questo, in sintesi, il messaggio cristiano.
A Lui non era mai piaciuta, la respirazione bocca a bocca: gli ricordava tanto i baci in bocca, ai quali, finché si è giovani, si affida tutta l’essenza dell’anima-zione amorosa; quindi non gli piaceva nemmeno il concetto di salvezza derivante da una intubazione continua nel bocca a bocca dell’amor di Dio. Insomma, non gli piaceva quell’aver fatto della salvezza una faccenda più amorosa che conoscitiva: Lui era uno studioso, per giunta professore, e troppe volte, a scuola, alla fine dell’anno aveva assistito a rianimazioni di studenti in fin di vita, cioè a promozioni date più per amor dello studente che per amor di verità: la verità che quello studente non aveva studiato affatto. Punto. La salvezza cristiana gli ricordava troppo la salvezza scolastica, e lo induceva a pensare che solo gli ignoranti, i sempliciotti, si possono veramente salvare, per Gesù Cristo, perché loro sanno sicuramente amare molto meglio dei sapienti e dei dotti: la salvezza cristiana era troppo simile alla salvezza scolastica rubata in extremis dal buon ladrone di turno chiamato studente. Quello che sconcerta, è che l’anima, da sempre addetta all’animazione del corpo in questo mondo, dopo Cristo debba finire in rianimazione, cioè “sotto Spirito”, per poter continuare ad animare il corpo nell’altro mondo.
I commedianti della Compagnia del Mezzogaudio, quando sono cristiani, sono la peggior razza di ipocriti: ogni loro recita è un promo per pubblicizzare un gaudio intero posto al di là del mezzo; una specie di trailer, un filmato promozionale che fa pubblicità “a rimorchio” di una propaganda missionaria facente riferimento a una proiezione che avverrà in una sala che tutto sarà, tranne che cinematografica e tantomeno teatrale. La Compagnia del Mezzogaudio si atteggia sempre così: vi piace? ah, ma questo è niente, vedrete poi! Il mezzo gaudio talvolta serve a mettere sul gusto, a far pregustare, come un antipasto, il pasto che verrà, la vita che verrà, cioè la vita del mondo che verrà, amen. Il mezzo gaudio spesso finisce con un amen: un “così sia” che è la speranza cristiana di un ‘credo’ ultraterreno; il mezzo gaudio è moralista proprio per questo: perché nasce da uno sperare in tempi migliori, ma si spera in tempi migliori quando si intravede la possibilità di un dover essere che adesso non è. La Morale nasce dalla percezione di una differenza tra essere e dover essere: essere mezzo gaudio da questa parte e dover essere gaudio intero da un’altra parte.
Sì, gli parve proprio di essere giunto a un’importante conclusione: il Giudizio Morale è tale in quanto fa la morale a un essere che non è come dev’essere; senza l’informazione che nasce dal percepire un essere che non è come dev’essere, la Morale non potrebbe nemmeno esistere. Lui pensava: io posso dire
- star bene non è star male
- star male non è star bene
e non ho detto niente, perché questa è un’ovvietà derivante dal principio di non contraddizione, per il quale non è possibile che una cosa sia e non sia allo stesso tempo: se sto bene non sto male, e viceversa.
Ma – pensava Lui – se io dico
- star bene non è male
- star male non è bene
questa non è più un’ovvietà, perché quella copula, è, insinua già nelle due affermazioni una considerazione riguardante il dover essere, dal momento che, quando dico che star male non è bene, praticamente dico: sarebbe bene che io stessi bene, cioè non è bene che uno stia male. Il Giudizio Morale si origina dunque dalla considerazione di un dover essere e, conseguentemente, dalla generalizzazione che necessariamente si compie quando si fa tale considerazione; se io, che sto male, dico: sarebbe bene che io stessi bene, nel momento in cui lo dico, estendo e innalzo questo ‘essere bene’, cioè questo dover essere, a regola generale e ottimale di una condizione universale: se è bene che io stia bene, è bene che Tutti stiano bene, è Bene per Tutti stare bene.
La Morale ricerca «come si deve essere»: cosa è bene che sia, ma, facendo questa ricerca, per forza di cose prescinde progressivamente sempre più dal dato fattuale e contingente di un essere, dal quale comunque parte per la sua considerazione, e si spinge sempre più verso il dover essere ‘che sarebbe bene che fosse’ e che invece non è: così, generalizzando ed universalizzando la sua miglioria, arriva ad un «come si dev’essere» che, alla fine, è un «essere come si deve» e, all’infinito, addirittura l’«Essere-come-si-deve»: Dio, l’essere-a-modo.
A Lui veniva in mente quella frase che Nietzsche scrisse al termine della sua Genealogia della morale: l’uomo «soffriva del problema del suo significato» e perciò azzarda qualche interpretazione della propria sofferenza: la volontà di verità è esattamente la ricerca di una interpretazione plausibile, se non vera, che permetta di immolare il mal comune sull’altare di una buona causa; «a che scopo soffrire?». E bene, l’ideale ascetico – scrive Nietzsche – ha offerto alla sofferenza lo scopo, il senso che essa cercava quando il cristianesimo ha proposto la propria interpretazione di questa sofferenza come effetto di una colpa che Gesù Cristo ha redento una volta per tutte.
La genealogia, ἡ γενεαλογία, come discorso sulla nascita, ἡ γενεά, sull’origine, in quanto genealogia della morale, ha la sua genesi, τὸ γένος, nel divenire, γίγνομαι, di un essere, ciò che dovrebbe essere: il divenire insito nell’interpretazione morale è la genetica di una santificazione ontologica. L’ontogenesi di un qualsiasi precetto morale è inscritto, per così dire, nella filogenesi dell’essere in evoluzione verso il suo dover essere. Si parte da un essere-che-è, si passa per quell’essere-come-dovrebbe-essere, e si arriva all’essere-come-deve-essere: dal confronto tra l’essere-come-è e l’essere-come-dovrebbe-essere si riceve l’informazione di uno iato, di una cesura, di un vuoto, cioè si percepisce la differenza tra un essere e il suo dover essere; questo confronto è reso possibile da una comparazione pregiudiziale secondo la quale tra due stati dell’essere, il più patologico dei due è quello che deve essere curato dal dover essere.

La lacuna che si apre come uno squarcio tra essere-come-è e essere-come-si-deve è quella che la Morale si propone di colmare: è la falla apertasi con il fallo originale. La lacuna… a Lui venne in mente l’Offertorio della Messa da Requiem: Domine, Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu…
Come a scuola, se l’essere non “colma la lacuna”, finisce nella fossa profonda della bocciatura e perde l’anno, cioè la vita: lacus, us: lo stagno di fuoco del Tartaro cristiano, quella che Dante, in Paradiso XXXIII,22, chiama infima lacuna de l’universo: l’Inferno.
Or questi, che da l’infima lacuna
de l’universo infin qui ha vedute
le vite spiritali ad una ad una,
supplica a te, per grazia, di virtute
tanto, che possa con li occhi levarsi
più alto verso l’ultima salute.
Dante è salito dall’infima lacuna infernale verso la salvezza, la salute finale, per grazia di Dio. La grazia. Lo colpiva molto, il fatto che, in latino, quando la causa di un’azione corrisponde al suo scopo, cioè quando è detta causa finale, tale complemento di causa si può rendere con gli ablativi causa o gratia preceduti dal genitivo; ma anche in greco succede così, solo che in greco si usa l’accusativo χάριν – l’accusativo di grazia – preceduto o seguito dal genitivo. Insomma, in grammatica, la grazia è diventata una preposizione che serva a tradurre il complemento di causa: c’è da rifletterci su.
Lui aveva scritto una poiesi, intitolata Gratiae Gratia, che recitava: la grazia è la canonizzazione del complemento di causa. E ne aveva scritta anche un’altra, che aveva intitolato Salvezza:

Senza il benestare della grazia nulla è “buono a…”, non c’è niente da fare: senza grazia l’uomo è “buono a nulla”, da solo non si salva. E gli veniva in mente Giovanni 15,5: «senza di me non potete far nulla», χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν, sine me nihil potestis facere. Ma gli veniva in mente anche l’antipaticissimo Agostino: «chi ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te».
«Caro Agostino, detto così, sembra che Dio ci abbia messo in un grande mare di merda proprio perché noi fossimo costretti a chiederGli di darci una mano, una Mano che ci tiri fuori, – pensava Lui –, come dire: Io ho permesso che tu finissi lì dentro per dimostrarti che non puoi uscirne da solo…. per dimostrarti che da solo non ce la puoi fare, – capito? – perché tu riconosca che hai bisogno del mio aiuto, se non vuoi affogare… e, a chi accetta di lasciarsi salvare, Dio getta il suo Salvagente: suo Figlio in Persona».
La grazia è quel Salvagente in grazia di cui, in virtù del quale l’essere-come-si-deve fa diventare l’essere-così-com’è esattamente come-si-deve-essere. Lo Spirito della Morale è il Paràclito: dal latino tardo paraclētus o paraclī̆tus, che è dal greco παράκλητος «chiamato presso, invocato» (e quindi «consolatore»), derivato di παρακαλέω «chiamare a sé, chiamare in aiuto», composto da παρά + καλέω = «chiamare presso»; la forma paraclĭtus (e quindi l’italiano paràclito) riproduce la pronuncia bizantina. Giovanni 14,16-17: «…io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi». Lo Spirito Paraclito è l’ad-vocatus, l’av-vocato delle cause celesti, cause perse se ci si danna l’anima e cause vinte se ci si salva.
Il Consolatore. Lui l’aveva sempre pensato, che la consolazione fosse l’essenza del mezzo gaudio, quel sintomo benefico che deriva dal vedere che c’è Qualcuno che sta peggio di te: tu stai male, ma vedendo chi sta più male di te, ne provi una sorta di gioia a metà, una gioia monca, sì, ma che è già qualcosa: meglio di niente. Per la precisione, va detto che il mezzo gadio, però, non gode solo nel vedere che c’è chi sta peggio: esso si compiace soprattutto del fatto che, in ultima analisi, Tutti, a prescindere dall’intensità del loro star male, stanno comunque male, in questo gran mare di merda: ciò, è veramente essenziale, per provare il mezzo gaudio.
Se c’è bisogno di consolazione, è perché qualcosa non va come deve andare, ovviamente. Eppure, chi cerca il mezzo gaudio, non cerca la causa di questo suo bisogno, gli basta soddisfarlo per metà. In questo Lui era diverso da Tutti: Lui voleva soddisfarlo del tutto, quel bisogno. E gli veniva in mente l’acqua viva di Giovanni 4,14: «chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno». Fu a questo punto che realizzò la seguente tabella:
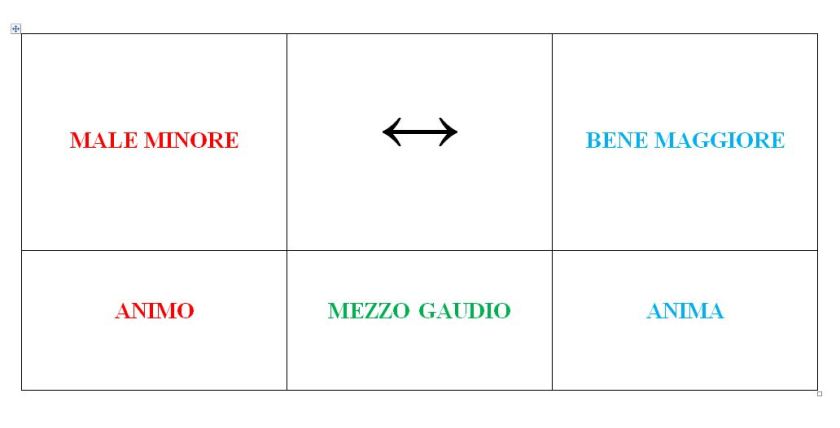
Il mezzo gaudio è il crocevia nel quale l’essere decide se intraprendere la via del male minore oppure quella del bene maggiore; questo crocevia è la croce dell’essere: il crocicchio in cui ne va della Morale, all’incrocio tra essere così com’è e essere come dev’essere. Se giudicare è teilen, dividere, la scelta morale si compie proprio in questo punto di divisione, o di fusione, in cui lo stato solido della fisicità, passando per la “liquidità” della scelta morale, sale o non sale allo stato aeriforme della metafisicità. Se uno decide di godere guardando a chi sta peggio di lui, il suo mezzo gaudio è avere in animo di non andare verso il dover essere, mentre se uno sceglie di godere guardando a chi sta meglio si lui, il suo mezzo gaudio è avere in anima di andare verso il dover essere, così pensava, Lui: tutto si decide al bivio della Morale.
Ebrei 4,12: «la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito»; il crocevia, il punto di fusione, è μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus. Voilà, Anima e Spirito, al bivio: ὁ μερισμός è il dividere, il teilen di un μείρομαι che si decide in das Urteil: il Giudizio. O potenza dell’etimologia! Lui non credeva ai suoi occhi: il dizionario di greco diceva che μείρομαι è da confrontare col latino mereo, es, ui, itum, ere; secondo Lui, quel participio passato, meritum, era più che sufficiente per giustificare la teoria della causa moralizzata in colpa: mereo vuol dire meritare ma anche essere colpevole, perché è colpevole chi merita una pena, e merita una pena chi è colpevole.
Il meritum, ecco il frutto di quel carpire dall’albero della conoscenza la differenza tra Bene e Male: il compenso, meritum, di quel carpire fu nel carpire la facoltà di giudizio, cioè la facoltà di saper operare il distinguo tra Bene e Male, un distinguo che è appunto ὁ μερισμός cioè un μείρομαι in parti: una parte buona e una parte cattiva. Chi non sa distinguere tra Bene e Male non può avere né merito né colpa, perché non è in sua facoltà quel cerno, separo, che è il prònao del discernimento, verbo che viene da discerno: distinguo. Per distinguere bisogna prima separare: se io avessi, su un foglio di carta, disegnate due figure esattamente uguali e sovrapposte, ne vedrei una sola, non due: ebbene, questa visione era il punto di vista di Adamo ed Eva prima del fallo originale. Il poter vedere distintamente figure separate è lo strabismo causato dal peccato originale: lo strabismo di chi è sempre costretto a decidere dove sta la figura vera, la diplopia di un “vedere doppio” rende difficile la focalizzazione, la messa a fuoco della verità.
Che tutto questo suo almanaccare fosse avvenuto davanti al reparto di oculistica, era assolutamente irrilevante, perché ormai per Lui ciò che contava erano i pensieri e non ciò che dava loro adito; chi, chiama diplopia il «vedere doppio»? solo uno che se ne sta a pensare davanti a un reparto di oculistica senza nemmeno vederlo, così pensava, Lui. Ebrei 4,12 l’aveva sempre intrigato, con quel suo “punto di divisione” tra ἡ ψυχή e τὸ πνεῦμα; il destino, la Moira, Μοῖρα, è «sorte, destino», perché viene da μείρομαι «avere in parte, in sorte», cioè avere ἡ μοῖρα «la parte». Senza parte, niente merito.
Tutto dipende dal “punto di vista” in cui ci si pone: dal punto di osservazione della medietas, del mezzo, la Morale può assumere il punto di vista dell’Animo, cioè dell’Anima che guarda verso il male minore, oppure il punto di vista dello Spirito, cioè dell’Anima che guarda verso il bene maggiore. La consolazione derivante all’Anima dal suo guardare allo Spirito è la Speranza cristiana. Cominciava a farsi sera, e in ospedale avevano acceso le luci; sarà per questo, che a Lui si accese in testa, come una lampadina, un dialogo chiaroscurale tra la luce spirituale (CHIARO) e il buio animale (SCURO)?
SCURO: Vuoi illuminarmi a tutti i costi?
CHIARO: Perché tu abbia la vita.
SCURO: Cosa c’entra la luce con la vita, questo lo sai solo tu.
CHIARO: Sta scritto: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini.
SCURO: Ah, sì, sì… Giovanni 1: …la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta…
CHIARO: Bravo.
SCURO: La vuoi sempre vinta, tu, vero?
CHIARO: Le tenebre non mi possono vincere: le porte degli inferi non prevarranno; Matteo 16,18.
SCURO: Se non ci fossi io, nessuno se ne accorgerebbe, che tu sei la luce: senza il buio, la luce non fa luce a un bel nulla: io sono il foglio nero su cui tu disegni le tue scie luminose, io sono la camera oscura in cui tu puoi sviluppare le tue foto. Lo sai, no? che foto viene da φῶς φωτός: luce? Foto, fotosintesi…
CHIARO: È vecchia, questa storia.
SCURO: Ma è vera: prova a far luce dove non c’è il buio, se sei capace.
CHIARO: Senza di te io sarei luce pura: chiarore assoluto, bianco immacolato.
SCURO: Com’era il tuo Signore, prima che la sua creatura decidesse di passare al bianco e nero…
CHIARO: Il mio Signore resta Biancore assoluto, Bianchezza pura; e la sua creatura lo raggiungerà solo se saprà smacchiarsi fino ad indossare la sua stessa vesta candida.
SCURO: Il tuo Signore vuole essere l’unico, a far luce: la prima stella che sorse al mattino per far luce, Lucifero, fu condannata dal tuo Signore a far buio in eterno; il fosforico Lucifero, portatore di luce per definizione, almeno fra le stelle, non fu tollerato, dal tuo Signore: tutti devono stare alla sua ombra, sennò finiscono all’ombra di Lucifero. Nel cielo, il Sole, non disdegna che la Luna, e le Stelle, facciano anch’esse luce: lui fa luce di giorno e loro fanno luce di notte. Solo il tuo Signore vuole essere l’unica luminaria dell’Universo.
CHIARO: Il peccato di Lucifero fu proprio questo: non accettò il suo brillare di luce riflessa. Solo Dio è la Luce: tutto risplende della sua Luce… Luce da Luce, φῶς ἐκ φωτός, lumen de lumine… persino suo Figlio, brilla di luce riflessa. Non lo conosci, il Credo?
SCURO: E come no? Poi venne l’uomo, la sua creatura più perfetta, che, volendo essere come Lui, scelse il bianco e nero: mi spieghi come è potuto accadere, che la creatura, volendo diventare come il Creatore, cioè Bianca come la Luce, è diventata… bianconera?
CHIARO: Fu Lucifero, a promettere che l’Uomo sarebbe diventato come il Bianco, come Dio; il Nero disse: «Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Loro mangiarono, e cominciarono a vedere, oltre al Bianco anche il Nero.
SCURO: Già, e poi dovettero aspettare fino all’anno zero, che il Bianco mandasse il bianchetto: il bianchetto della grazia ottenuta per i meriti di suo Figlio. Perché volle vedere anche il Nero? per questo l’Uomo fu sbattuto sulla terra? dove, tra l’altro, tutto si vede a colori, e non in bianco e nero?
CHIARO: I colori tutti insieme danno il Nero, lo sai benissimo.
SCURO: Senti un po’, tu, che sei la luce del tuo Signore, fammi un po’ luce su questa questione: perché, quando i colori spariranno, alla fine dei tempi, nel mondo che verrà, gli uomini saranno eternamente fissati o nel Nero dell’Inferno o nel Bianco del Paradiso? A giudicare da questa situazione finale ed eterna, sembra che al tuo Signore non sia poi dispiaciuta così tanto, la scelta di vedere tutto in bianco e nero, che l’uomo fece mangiando dall’albero del Bianco e del Nero; mi sembra che l’abbia fatta sua, questa scelta dell’uomo, che l’abbia immortalata, dal momento che ha colorato una vita eterna con dei viventi neri e con dei viventi bianchi. Tu, che sei la luce del tuo Signore, chiariscimi un po’questo problema: i viventi neri, i dannati, sono bianchi o neri? Se sono vivi sono bianchi e se sono neri sono morti: cos’è, questo essere bianconero? questo chiaroscuro inquietante, né carne né pesce?
CHIARO: La Luce del mio Signore è la Vita stessa: l’essere è albino. Dal momento che il Signore pose in essere il creato, esso rimase e rimarrà per sempre il foglio bianco che “gli diede carta bianca”. Non è sul tuo foglio nero, che Lui disegnò il creato, ma sulla libertà della sua stessa carta bianca. Nessun vivente può essere cancellato da quella carta e i viventi neri, come li chiami tu, sono quelli che si vedono solo “sulla carta”, ma che in pratica nessuno vede più, perché la Luce del mio Signore non li illumina più.
SCURO: È semplicemente orribile! Non poteva, il tuo Signore, se tanto gli era dispiaciuta la scelta della sua creatura di vedere anche il Nero, oscurare completamente al di là chi al di qua scelse di veder nero? è a dir poco sadico, inventarsi un foglio bianco tutto pieno di disegni che nessuno può vedere: è terribilmente antipatico, questo tipo di inchiostro… “simpatico”.
CHIARO: Il mio Signore aveva dei disegni, sulle sue creature, ma non tutte li hanno voluti ricalcare.
SCURO: Hai detto bene: il tuo Signore non lascia che si disegni a mano libera; si salva solo chi disegna nelle linee già tratteggiate da Lui, chi colora le immagini che Lui ha già delineato. «Se non diventerete come bambini…»: è forse per questo, che si salva solo chi pittura disegni già fatti? Mi spiace: io non sono la carta copiativa del tuo Signore, la carta carbone di Dio.
CHIARO: Per questo la tua anima è nera come il carbone.
SCURO: O bianchissimo Spirito, io non intendo usare il bianchetto del tuo Signore, lasciami stare, lasciami stare nel mio Nero: nella sua pietosa caligine, almeno, la passione e morte dell’umanità non si vede. In beata caligine, caligaverunt oculi mei…
Domine, Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu… Quando pensava a questo apocalittico lacus, ‘infima lacuna de l’universo’, a Lui veniva in mente che
Questo appunto significa l’ideale ascetico: che qualche cosa mancava, che un’enorme lacuna circondava l’uomo – egli non sapeva giustificare, spiegare, affermare se stesso, soffriva del problema del suo significato. Soffriva anche d’altro, era principalmente un animale malaticcio: ma non la sofferenza in se stessa era il suo problema, bensì il fatto che il grido della domanda «a che scopo soffrire?» restasse senza risposta. L’uomo, l’animale più coraggioso e più abituato al dolore, in sé non nega la sofferenza; la vuole, la ricerca persino, posto che gli si indichi un senso di essa, un «perché» del soffrire. L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino a oggi è dilagata su tutta l’umanità – e l’ideale ascetico offrì ad essa un senso! [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Terza dissertazione, § 28 – pag. 156]
«No, mi spiace per Nietzsche – pensava Lui – io non credo affatto che l’uomo sia ‘l’animale più coraggioso e più abituato al dolore’: io, che sono uomo, nego la sofferenza, non la voglio, e quindi men che meno la ricerco; nemmeno se me ne si dice il senso, l’accetto; con o senza perché, il soffrire non mi piace, e lo rifiuto. L’assurdità non è della sofferenza, è nella sofferenza, è la sofferenza: la sofferenza in sé è la maledizione che affligge e angoscia l’umanità sotto le specie del mal comune». Malediva la maledizione che il Creatore aveva lanciato contro la sua creatura il giorno in cui Adamo ed Eva mangiarono il malum.
Proprio non la digeriva, quella mela. «Finché uno non digerisce qualcosa che ha mangiato di sua spontanea volontà, passi; ma che uno debba fare indigestione a vita per qualcosa che ha mangiato un suo progenitore, questo proprio non mi va giù… – pensava Lui – perché dovrei tenermi sullo stomaco per tutta la vita una mela che non ho mangiato io? Quando uno è lì che muore di fame, non è che Dio lo alimenta con quella mela, se non sbaglio… è una mela che serve solo a far morire, non a far vivere: si materializza quando non si ha fame, e si smaterializza quando si ha fame, come una bella donna È una mela maledetta, quella». Ce l’aveva con le mele tanto quanto ce l’aveva con le donne: un fallo ci ha messo al mondo carpito da una donna, e delle donne continuano a metterci al mondo carpite da un fallo. Visto che già la donna ha commesso l’errore di essere presa in fallo nell’Eden, per farsi perdonare come minimo dovrebbe, su questa terra, non lasciarsi mai più prendere da un fallo, diceva: prima presa in fallo e poi presa da un fallo? Prima il danno e poi la beffa? Eh, no, errare humanum, perseverare…
A Lui avevano insegnato che era tutta colpa della maledizione edenica, per cui non aveva altre risposte, alla domanda sul perché del mal comune. Quindi, per venirne a capo, bisognava continuare ad arrampicarsi sui vetri, anzi… sugli alberi, su quei due alberi che il mito biblico poneva in Eden: l’albero della conoscenza del Bianco e del Nero, e l’albero della vita, che probabilmente era incolore. Grazie ai frutti dell’albero della vita stava scritto che Adamo ed Eva, cioè noi, sarebbero riusciti a non invecchiare, e per colpa del frutto dell’altro albero, invece, stava scritto che avrebbero dovuto morire, e così avvenne: l’albero della vita non fece in tempo a promettere la sua immortalità, che l’altro albero subito riuscì a mantenere la sua promessa di mortalità. L’uno promise e l’altro mantenne. Quando a mantenere un effetto non è la stessa causa che l’ha promesso, c’è da star sicuri che qualcosa non andrà ad effetto come si deve, pensava Lui, ed in effetti…
In ospedale c’era uno, sui quarant’anni, seduto su una carrozzina, che si era rotto la tibia cadendo dalla moto; alla gamba aveva un aggeggio, una specie di tutore in metallo che addossava su di sé tutto il peso che avrebbe dovuto sopportare la tibia, così, tanto per poter fare quattro passi onde evitare l’atrofia del muscolo, qualora fosse rimasto troppo tempo fuori uso… parlarono, Lui e il Centauro:
LUI: Come hai fatto, a farti male?
CENTAURO: Eh, l’unico guard rail che c’era, l’ho preso io: un calcolo sbagliato…
LUI: Chissà che male!
CENTAURO: Non ti dico!
LUI: Ti è passata, la voglia di andare in moto?
CENTAURO: No, anzi: tra sei mesi, quando mi toglieranno tutto, non vedo l’ora di ricominciare.
LUI: Nonostante tutto quello che stai sopportando?
CENTAURO: Guarda che non è la prima volta: mi sono già procurato altre rotture, in passato, in seguito ad altre tre cadute dalla moto
LUI: E nonostante tutto questo continuerai ad andare in moto?
CENTAURO: Altroché!
Sorrideva tutto contento, quel centauro, si sentiva come un eroe di guerra, o qualcosa del genere; nella vita faceva l’operaio, era separato, viveva da solo, e la sua unica passione era la moto. Quando l’incontro avvenne, Lui stava rileggendo il Parmenide di Platone. Fu il centauro, ad attaccare bottone, distraendolo da quell’impegnativa lettura: Lui non aveva nessuna voglia di mettersi a parlare, perché le faccende dell’Uno e dell’Essere platonico lo interessavano assai di più, ma fu costretto a lasciare per un attimo Platone perché il centauro continuava a parlargli.
Il centauro è un animale mitologico metà uomo e metà cavallo. Chirone fu forse il centauro più famoso: esperto nelle arti, nelle scienze ed in medicina ebbe per allievi numerosi eroi, tra i quali Achille, com’è noto. Chirone, in quanto medico, fu chiamato a curare Achille quando quest’ultimo, a seguito delle magie praticate da sua madre Teti, per renderlo immortale, ebbe la caviglia ustionata; Chirone gliela sostituì con quella di un Gigante morto, Dámiso, particolarmente dotato nella corsa, per questo Achille divenne pie’ veloce. Non risulta, però, che tra i discepoli di Chirone ci siano mai stati dei campioni di motociclismo, forse perché a quei tempi non c’erano ancora le moto. Il centauro che Lui aveva visto in ospedale evidentemente non aveva nessun Dámiso tra i suoi amici, perché l’osso che si portava addosso era artificiale.
Lui rimase basito, dal colloquio avuto con il centauro, gli cascarono le braccia: «Com’è possibile – pensava – che un essere umano viva per andare in moto? Al punto da sopportare stoicamente qualunque sofferenza?». Quando pensava a quel centauro, è allora che perdeva la speranza che l’umanità potesse mai raggiungere l’utopia della desistenza: se ci sono degli umani che vivono per delle futilità come l’andare in moto… vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
1Parole di Qoèlet, figlio di Davide, re a Gerusalemme.
2Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
3Quale guadagno viene all’uomo
per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole?
4Una generazione se ne va e un’altra arriva,
ma la terra resta sempre la stessa.
5Il sole sorge, il sole tramonta
e si affretta a tornare là dove rinasce.
6Il vento va verso sud e piega verso nord.
Gira e va e sui suoi giri ritorna il vento.
7Tutti i fiumi scorrono verso il mare,
eppure il mare non è mai pieno:
al luogo dove i fiumi scorrono,
continuano a scorrere.
8Tutte le parole si esauriscono
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo.
Non si sazia l’occhio di guardare
né l’orecchio è mai sazio di udire.
9Quel che è stato sarà
e quel che si è fatto si rifarà;
non c’è niente di nuovo sotto il sole.
Il Qoelet, altrimenti detto Ecclesiaste, non si capisce come possa figurare tra i 72 libri della Bibbia, con questo suo piagnucolare così poco da credenti, pensava Lui. Ma subito dimenticò la Bibbia perché, senza un apparente motivo, gli venne in mente l’inizio dello Ione di Platone, laddove Socrate esordisce dicendo: «Il mio saluto all’illustre Ione!», che in greco fa risuonare quel χαίρειν così familiare alla grazia di ἡ χάρις… gli umani, quando salutano, lo fanno con grazia. «E già, forse perché per loro niente è più grazioso della salute – pensava Lui –: siccome quando c’è la salute c’è tutto, se tu saluti uno dicendo ‘Salute!’, gli auguri tutto il bene possibile… se poi lo saluti dicendogli ‘Salve!’, allora lo saluti ancora meglio, perché sembra che gli auguri la Salvezza». I Romani l’hanno persino santificata, la salute: Salus, con la «S» maiuscola, è la dea Salute, la dea della salute; salveo, es, ere, difettivo della seconda coniugazione, vuol dire essere in buona salute: peccato che sia difettivo, pensava Lui. I verbi difettivi sono verbi che mancano di alcuni tempi, modi e persone verbali, e fin qui, niente di male: che, però, proprio al verbo che dovrebbe sprizzare salute da tutti i pori, cioè da tutti i tempi, si faccia mancare qualche tempo, questo non è un buon segno: non dovrebbe essere fallato, un verbo del genere.
Ma non era lo Ione che lo interessava, adesso, bensì il Parmenide, il dialogo di Platone che stava leggendo prima che il centauro attaccasse bottone; a dire il vero, appena il centauro ebbe finito di attaccare quel bottone, Lui subito ricominciò a fare l’occhiello all’àsola platonica, cioè a riprendere la lettura del Parmenide, l’unico pastrano che desiderasse veramente abbottonarsi, nonostante il caldo del mese di giugno; forse perché àsola viene da ansula, diminutivo di ansa, che vuol dire «manico» e dunque anche «appiglio»…. Salmo 23: il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza… Così ricominciò ad appoggiarsi alle stampelle platoniche del Parmenide, anche perché, proprio lì, in ospedale, Lui pensava di aver capito finalmente una cosa strabiliante: «forse – pensava – nel Parmenide c’è la descrizione del peccato originale… sì, mi pare proprio che da una lettura attenta del Parmenide possa derivare un’esegesi puntuale del peccato originale».
Il Parmenide di Platone è notoriamente un testo di difficilissima comprensione, ma Lui pensava di aver trovato la chiave di lettura in grado di permetterne finalmente l’accesso: «Il verbo ESISTERE: è lui la password in grado di decriptare quel crittogramma», diceva sempre; sosteneva, cioè, che, se in certi punti cruciali del Parmenide, si fosse sostituito il verbo essere con il verbo esistere, come d’incanto il varco si sarebbe aperto e l’aporia ontologica sarebbe diventata accessibile, una buona volta.
L’albero della conoscenza del Bianco e del Nero: il suo frutto fa passare dall’essere all’esistere. Genesi 3,22-24: il Signore Dio disse
Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all’albero della vita.
Flammeum gladium. Una spada di fuoco impedisce all’esistere di tornare ad essere quello che era. Se, oltre all’esistenza, l’uomo avesse carpito anche l’immortalità, sarebbe veramente diventato come Dio, la falsa promessa luciferina si sarebbe veramente realizzata; per questo l’accesso all’Eden fu severamente proibito.
Pare di capire che Dio è l’essere dotato di due requisiti:
- Esistenza immortale
- Conoscenza del Bianco e del Nero
L’uomo carpì la conoscenza del Bene e del Male ma gli fu impedito di carpire anche l’immortalità: o l’una o l’altra, perché, con tutt’e due, si diventa Dio. Dio è conoscenza del bianconero e immortalità dell’esistenza: Verità e Vita; la Via a Lui è preclusa da una spada di fuoco.
Carpire. Viene da carpo, is, carpsi, carptum, ere. A Lui veniva da dire: carpe malum. Anche perché, in greco, ὁ καρπός è il frutto di un albero ed anche il frutto di un ventre, il figlio… il frutto del tuo seno, Gesù… fructus ventris tui, Iesus… nell’Ave maris stella si dice che la madre di quel frutto fu salutata dall’arcangelo Gabriele con un ‘Ave’, perché Ave, letto da destra verso sinistra, è Eva: come dire che il frutto dell’«anti-Eva», Maria, è l’unico antidoto contro il veleno contenuto nel frutto di Eva; se Eva partorì il peccato, un Ave avrebbe presto annunciato il parto della grazia.
Sumens illud ave
Gabrielis ore
funda nos in pace
mutans Evae nomen
L’Ave della salutazione angelica mutò il nome di Eva. Lui aveva sempre visto il peccato originale come causa di rottura dello specchio ontologico, il quale improvvisamente va in mille pezzi, cadendo dall’essere lassù all’esistenza quaggiù. Vecchia metafora, questa, che, nel XIII secolo, fece dire al grande pensatore e poeta persiano sufi Jalāl al-Dīn Rūmī: «La verità è uno specchio caduto dalle mani di Dio e andato in frantumi. Ognuno ne raccoglie un frammento e sostiene che lì è racchiusa tutta la verità». Lui pensava che questo specchio fosse piuttosto caduto dalle mani dell’uomo, che non dalle mani di Dio: lo specchio è l’essere divino che, cadendo nell’essere umano, comincia ad esistere nei suoi frantumi: i pareri sono schegge di verità. «Scheggia» viene dal latino schĭdia e dal greco τὸ σχίζιον & ἡ σχίζα, voce del verbo σχίζω «spaccare», che in latino è scindo.
Dopo lo σχίζω originale, la verità appare solo più come “schizzo” di un disegno abbozzato nella miriade di segni sparsi qua e là, come in un puzzle che tocca all’uomo ricostruire: il primiero di-segno si mostra ora come un segno da decifrare. L’uomo non ha più idea di cosa fosse l’ideazione primordiale di questo disegno e cerca di rifarsene un’idea.
Così è necessario, io credo, che frantumandosi si polverizzi progressivamente l’Essere che è colto con il pensiero (τῇ διανοίᾳ): infatti sarà sempre come se prendessimo un insieme privo di unità. [Platone: Parmenide – Rusconi, Milano 1994 – traduzione di Maurizio Migliori – 165 b – pag. 233]
In questo passo del Parmenide Lui leggeva, tra le righe, la descrizione degli effetti dello σχίζω originale: la verità a senso unico dell’Essere, frantumata negli infiniti sensi della polisemia, ognuno dei quali può diventare “eresia”, scelta, secondo le intenzioni etimologiche di quel dividere, διαιρέω che è διά + αἱρέω = «prendo attraverso» come διανοέω è διά + νοέω = «attraverso la percezione sensibile». E gli veniva in mente il famoso assioma della filosofia scolastica nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, niente è nell’intelletto che prima non sia stato nei sensi, che Locke fece suo nella propria teoria sull’origine delle idee, e che Leibniz integrò con l’aggiunta nisi ipse intellectus, eccetto l’intelletto stesso. Il che gli pareva un’ulteriore conferma dell’intuizione di Hume, secondo la quale ogni pensiero, ogni idea proviene da un’impressione sensibile, the impression.
Rovesciando l’assioma della scolastica sopraccitato, esce la modalità conoscitiva precedente il fallo originale: tutto è da sempre nell’intelletto, senza che prima sia mai stato nell’intuizione sensibile; in fondo, è ben questa la differenza tra l’intuizione pura e l’intuizione empirica argomentata da Kant: il noumeno è proprio l’essere ontologico in sé, conosciuto senza la mediazione esistenziale dei sensi, cioè senza quel διά che indica appunto il «tramite» per mezzo del quale e attraverso il quale si deve passare. «Noumeno» viene infatti dal greco νοούμενoν participio presente medio-passivo del verbo νοέω: il fenomeno è il parere esistenziale di una verità ontologica? La verità latita sotto le specie dei pareri?
Gli era sempre piaciuta, la definizione, heideggeriana, della verità come qualcosa che si nasconde, che latita, appunto, sotto le apparenze dei pareri; e su questa latitanza Lui aveva anche composto una delle sue poiesi, che aveva intitolato In manette:
La Verità?
Una latitante
che si costituisce!
La verità costituita è quella “ammanettata” nei pareri fenomenici della maya. L’ossessione platonica di come faccia, l’Uno ontologico della verità, a diventare i Molti esistenziali che si vedono nei pareri fenomenici, è quella che muove tutto il Parmenide. È stupefacente, che l’uomo abbia l’Idea di un’unità del molteplice che al di qua non vede e che, per ciò, presume di aver visto al di là:
Dunque, ogni volta che consideriamo in se stessa la realtà diversa dall’Idea, quale che sia la parte esaminata, sempre la troveremo essere una molteplicità infinita. [Platone: Parmenide – Rusconi, Milano 1994 – traduzione di Maurizio Migliori – 158 c – pag. 193]
Almeno gnoseologicamente, il mal comune sembra derivare da una molteplicità di pareri che non si sa come ricondurre all’unità. L’uomo vorrebbe poter salutare il ritrovamento della reductio ad unum con un bel χαίρειν tipo quello con cui Socrate salutò Ione nell’omonimo dialogo platonico; un χαίρειν che in latino possa suonare come moto retrogrado, cammino a ritroso da Eva all’Ave che fu detto a Maria.
«È l’ermeneutica, la maledizione dell’esistenza – pensava Lui –, e viene dal greco ἑρμηνευτική (τέχνη), arte dell’interpretazione. Se la verità fosse chiara, non ci sarebbe bisogno di interpretarne la fenomenicità in quel vano tentativo di ammanettarla che ci vede sempre con le carceri vuote. Lo stesso Nietzsche, pur di non ammettere l’esistenza al di là di una verità a priori ontologicamente chiara, si rassegnò alla volontà di impotenza dell’interpretazione, all’impotenza dell’a posteriori, e stigmatizzò quest’ultima come unica vera potenza a piori della vita: la potenza di una verità in potenza da realizzare quotidianamente con il potere dell’ermeneutica». Per i Greci l’ermeneuta, ὁ ἑρμηνεύς, era colui che interpretava il pensiero di altri; il grecista Nietzsche avrebbe dovuto tenerne conto, quando rifiutò di considerare l’ermeneuta come portavoce di una voce altri, la voce di un allotrio che Platone ben descrive nel suo Parmenide:
- «Se dunque l’Uno rispetto a se stesso non è né diverso, né un tutto, né una parte, non deve necessariamente essere identico a se stesso?».
- «Necessariamente».
- «E che? Ciò che è in Altro da sé, dal sé che è in sé, non è necessario che sia diverso da sé, se è anche in Altro da sé?».
- «Mi sembra di sì».
- «Così ci apparve essere l’Uno, in sé e anche in Altro».
- «Infatti, ci apparve così».
- «Dunque, a quel che sembra, l’Uno sarà diverso da sé».
- «Così sembra».
L’identità dell’Essere-Uno-in-sé è la tautologia ontologica che diventa essere-molti-per-sé nell’eterologia esistenziale dell’essere diventato altro da sé dell’in sé. Su questa aporia Hegel ci costruirà sopra tutta la sua Fenomenologia dello Spirito – pensava Lui – e pensava anche a quel punto dello Ione in cui Socrate “accusa” i rapsodi di essere solamente «interpreti di interpreti»: ἑρμηνέων ἑρμηνῆς. Platone era alla continua ricerca degli originali ontologici, convinto che quaggiù, nell’esistenza, l’essere non mostrasse che brutte copie di quelli; vi fu uno strappo ontologico che tocca al filosofo ricucire, dice Platone, suggestionato da pitagorismo e orfismo, e in questo verbo, ricucire, Lui vedeva un rimando alla critica mossa da Socrate ai rapsodi: il rapsodo è l’aedo che “cuce insieme” citazioni tratte da poesie di altri; il rapsodo, ὁ ῥαψῳδός, è ῥάπτω, «cucire» + ἡ ἀοιδή «il canto» di ἡ ᾠδή: il suo raptus è ermeneutico in quanto interpreta una poiesi che viene da un al di là non chiaramente identificabile. Il rapsodo rende dialogica la logica tautologica.
«In effetti, se il peccato originale si può pensare come il frantumarsi di uno specchio – pensava Lui – sarà ben legittimo allargare la metafora e magari pensare questo specchio come un tessuto, una stoffa ben tessuta i cui brandelli, gettati per il mondo da uno strappo originale sono ancora lì a dimostrare lo strappo primigenio tra creatura e Creatore. E se è così, cioè se la creatura, dopo lo strappo, cerca continuamente di ricucire questo strappo, allora essa, precipitata nel suo esistere, diventa veramente il rapsodo del proprio essere stato e non fa che cantare nel tempo l’elegia lamentosa della sua verità, stracciata prima che il tempo fosse ordito». Fu così che Lui si accorse di essere poieta, cioè rapsodo.
La missione dell’uomo è dunque quella di ricostruire la verità? Come un paziente detective? – quando diceva così, Lui voleva dire: ‘come un investigatore malato’, e non solo perché si trovava in ospedale pieno di pazienti, nel momento in cui lo stava pensando. Già. Ricostruire la verità, risalendo al colpevole? Per poi magari metterlo in quel carcere nel quale la verità riesce sempre a non entrare? Che detective incapace, che è l’uomo! – pensava – passa la vita a mettere la verità in gabbia e alla fine in gabbia ci finisce lui, quando la morte gli fa interrompere di brutto l’indagine e lo incarcera per la colpa di non esser riuscito a scoprire la verità che lui stesso si proponeva di mettere al fresco. E poi, bastasse, ricostruirla, la verità! Per il cristianesimo bisogna anche farla, non solo ricostruirla. Stava pensando a Giovanni 3,20-21: Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio», ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν, qui autem facit veritatem.
Tra le sue novità, il cristianesimo ha apportato questo strano modo di dire: «fare la verità», che, nel greco della koinè, suona ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν, facere veritatem; a riprova del fatto che, dopo Cristo, conoscere non basta più, per salvarsi l’anima, questa locuzione esprime la necessità di mettere in pratica ciò che si è conosciuto come vero, secondo il dettame di Giacomo 2,14-26:
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c’è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull’altare? Vedi: la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la Scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete: l’uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Così anche Raab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un’altra strada? Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Lui se lo immaginava, il Cristo che, al di là, diceva all’anima di Platone: «invece di perdere il tuo tempo per cercare di capire come l’Uno possa diventare Molti, avresti fatto meglio ad andare in ospedale, a fare del volontariato, perché “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”, e dunque: “via, lontano da me, Platone maledetto, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!». E gli pareva proprio di vederlo, il povero Platone, tutto impaurito e sgomento, difendersi dicendo che la sua anima, pur avendo filosofato nel migliore dei modi per tutta la vita, non era mai arrivata a capirlo, che, oltre a conoscerla, la verità, la si doveva anche “fare”. E Lui tra l’altro si sentiva molto solidale, con Platone, perché aveva sempre avuto il sentore che avrebbe fatto la sua stessa fine, prima o poi, al di là: era di quelli che la verità cercano di conoscerla, Lui, ma che non sempre cercano di farla.
«Il personale ospedaliero sembra proprio essere sempre tutto intento a farla, la verità: curare pazienti è il modo migliore di fare la verità – così pensava, Lui»; il quale, ecco, era proprio andato all’ospedale per vedere se gli riusciva di capire come si fa, a fare la verità, ma purtroppo, il day hospital stava giungendo al termine e la verità non gli si concedeva che sotto le mentite spoglie di un ideale puramente da conoscere; niente da fare: fare la verità gli piaceva molto meno che conoscerla. Secondo il cristianesimo, Dio la verità non l’ha fatta recapitare all’uomo solo “per conoscenza”, come si dice in burocratichese; e invece tutta la filosofia è scritta solo “per conoscenza”, ecco perché la teologia la rispedisce sempre al mittente.
Parmenide: «Se l’Uno è Uno, non è vero che per nessuna ragione potrà essere molti?». Quando leggeva questa frase del Parmenide di Platone, Lui pensava: «Mah! Intanto, dopo Cristo, l’Uno è Tre». Si riferiva alla Santissima Trinità. «Chissà come l’avrebbe scritto, Platone, il Parmenide, se avesse potuto conoscere la grande rivelazione cristiana: che l’Uno è Tre? Ma è anche vero che, il Tre trinitario, essendo fuori del tempo e dello spazio, pur essendo Tre non è Molti: fuori del tempo si può anche assistere al miracolo di un Tre che resta Uno. Del resto, Heidegger l’aveva ben detto, che Esistere è tempo, no?». Lui diceva sempre che Heidegger, come Platone, aveva parlato indifferentemente di Essere e di Esistere creando e facendo molta confusione. Non è Essere, che è Tempo, ma Esistere – diceva sempre. E pensava anche che l’Essere volle incarnarsi proprio per dimostrare a Tutti la propria esistenza, affinché non si dicesse più che l’Essere è, ma non esiste!
Se l’Uno fosse rimasto Uno, cioè Tre – pensava – la creazione non sarebbe mai avvenuta. La creazione è creazione di un Tutto costituito da Parti. L’Uno trinitario non è un Tutto, perché le sue tre Persone non sono parti costituenti un Tutto; quando si parla di un Tutto, si parla di Parti esistenti, esistenti nello spazio e nel tempo. E gli veniva in mente il saggio che Emmanuel Lévinas pubblicò nel 1961, Totalità e infinito, saggio sull’esteriorità. L’Uno non può essere una Totalità, perché sennò sarebbe costituito da Parti. Parmenide: «Che cos’è un Tutto? Non è forse quello a cui non manca alcuna parte?». Bisogna vederli in greco, il Tutto e la Parte:
- τὸ ὅλον
- τὸ μέρος
‘La Parte si merita la salvezza se rientra nel Tutto’. Questa frase, che, detta così, può sembrare buttata lì senza un senso particolare, ha invece la sua ragion d’essere nell’esito latino di Tutto come Salus e Parte come Meritum. Il merito di una Parte è il suo rientrare nel Tutto, e questa è la sua salvezza. La stessa falla apertasi tra Anima e Spirito a causa del fallo originale, è effetto di una scomposizione esistenziale del Tutto Ontologico. Platone si dibatte tra una visione ontologica dell’Uno che non può essere un Tutto e una veduta esistenziale nella quale l’Uno è per forza un Tutto: il suo discorso fa l’equilibrista sul filo del rasoio e rischia sempre di cadere; pluralitas non est ponenda sine necessitate: Guglielmo di Ockham (1288-1347), il frate francescano celebre per il famoso “rasoio”, gli faceva sempre mettere in dubbio la creazione: «la molteplicità non andava posta in essere (cioè in esistere), perché non ce n’era necessità», così pensava, Lui.
C’è un Uno che siste e un Uno che esiste. L’Uno che siste è quello fuori del tempo e dello spazio: la Trinità. L’Uno che esiste è quello nel tempo e nello spazio: il creato. Dell’Uno che siste si può dire: «non sarà quindi un tutto e non avrà parti, l’Uno, se è Uno». Forse la teologia cristiana s’è inventata un Uno che siste per poter porre in essere una Molteplicità non esistente; visto che la Molteplicità esistente non può essere un Uno ontologico nella sua Totalità, bisognava inventare una Totalità infinita, cioè l’Infinito, senza dover negare una Molteplicità ontologica. Con l’istituzione della Trinità si istituisce una Molteplicità in Cielo; la Molteplicità celeste pone poi in esistere (non in essere) la Molteplicità in Terra. Con l’istituzione della Molteplicità ontologica la molteplicità esistenziale sembra più giustificata… forse è per questo che il cristianesimo ha voluto un Essere Trino?
«Porre in essere» è una locuzione fondamentalmente sbagliata – pensava Lui –, se fosse corretta saremmo costretti a pensare che l’Essere si può porre in essere, il che è assurdo, perché sarebbe come dire che il Creatore si può creare! Si deve dire «porre in esistere»: il Creatore, il “supposto in essere”, pone in esistere il creato. Gli piaceva, questa definizione di Dio: il supposto in essere, perché rendeva bene l’idea di Dio, il quale, se è, non è stato posto in essere ma, essendo, deve essere comunque supposto in essere. L’Uno che siste, Unum qui sistit, «dunque, se non ha parti, non ha inizio, né termine, né mezzo: infatti queste sarebbero sicuramente sue parti». Di converso, l’Uno che esiste, Unum qui exsistit, ha parti, ha inizio, termine e mezzo. Fu così che decise le seguenti due definizioni:
- Unum sistens
- Unum exsistens
L’Uno che siste è Tre. L’Uno che esiste è Molti. L’Uno che siste è il… preposito, il preposto, il… prevosto? Verrebbe piuttosto dal francese prévôt un Unum sistens che fosse primo dignitario ontologico alla maniera conventuale di un monastero e la sua prepositura assumerebbe la dignità di titolo ecclesiastico… l’Essere è il Priore ontologico? Si può ben capire come il concetto di Unum sistens possa sforare nell’assolutismo ontologico, sforare nel senso di superare il limite. «…termine e inizio sono limiti di ogni oggetto»: τελευτή γε καὶ ἀρχὴ πέρας ἑκάστου. Il limite, τὸ πέρας, è il confine della Totalità, non dell’Infinito, cioè dell’Unum sistens, il quale ultimo deve perciò essere Ἄπειρον, infinito, appunto. L’estremità, τὸ πεῖραρ, implica la definizione e la configurazione di una Forma, τὸ σχῆμα, e l’Unum sistens conosce solo la forma della faccia delle sue Tre Persone, se proprio si vuole aggiornare con la rivelazione cristiana del dopo Cristo l’assunto platonico dell’Unum sistens amorfo. L’Unum sistens non ha – voce del verbo ἔχω – forma: è curioso che τὸ σχῆμα venga messo dai dizionari di greco in relazione al verbo ἔχω; l’ecologia esistenziale non è quella ontologica.
Essere o Avere: il dilemma che Erich Fromm rese famoso nel 1977 con la pubblicazione di Avere o essere, è in ultima analisi il dilemma esistenziale che provoca l’angoscia, esistenziale, di una molteplicità di parti esistenti le quali non potranno mai, esistenzialmente, essere Uno, potendo solo avere i Molti, τὰ πολλά, nel πολύς polivoco e polimorfo dell’Unum exsistens. Solamente l’Unum sistens è Uno: «Ed essendo così, non sarà in alcun luogo. Non può infatti essere né in Altro da sé né in se stesso».
- ἐν ἄλλῳ
- ἐν ἑαυτῷ
La polimorfia, ἡ πολυμορφία, altrimenti detta polimorfismo, è dovuta al fatto che τὸ πέρας comporta un inizio e una fine:
- ἡ ἀρχή
- ἡ τελευτή
ma l’inizio comporta una archia e la fine una teleologia, cioè, l’inizio implica un potere e la fine una perfezione. L’implicazione autoritaria dell’archìa deriva dal presupposto ontologico di un Essere che non «ha inizio» perché «è l’inizio» di Tutto, laddove Tutto è il Creato, che ha inizio dall’arché ontologica e in essa ha anche fine, nel senso teleologico che demanda alla fine la responsabilità del ritorno all’Unum sistens. Se l’Essere è l’inizio dell’Esistere, esso non ha inizio. A Lui parve di essere giunto a un punto cruciale, nella trattazione aporetica dell’Essere o Avere (inizio):
- L’Essere è l’Inizio
- L’esistere ha inizio
E, siccome è l’Essere, a dare inizio all’esistere, esso ha il potere incipiente dell’origine. L’esistere ha inizio e fine, l’Essere è inizio e fine. Potere e Perfezione pertengono all’Essere onto-logicamente, non eco-logicamente. Il latino pertineo, es, tinui, ere sta per estendersi, diffondersi, tendere, mirare, avere come scopo, appartenere, riferirsi a… il potere archetipo è la pertinenza dell’incipit all’Essere. Solo l’Inizio può dare inizio: solo ciò che è può dare, dare un avere. Solo ciò che esiste può essere pertinente, solo l’esistente pertiene ad altro da sé. A rigore, all’Essere non per-tiene nulla, perché Lui tiene Tutto. La pertinenza è la res extensa, l’intensione che diventa estensione.
L’Alterità è contenuta nell’Identità. «Ma se è in sé stesso, il contenente non sarebbe nient’altro che se stesso, posto che sia in se stesso: è infatti impossibile essere in qualcosa senza esserne inclusi». Il contenente, τὸ περιέχον, è l’Essere, il contenuto, τὸ περιεχόμενον, è l’esistente. E a Lui veniva di nuovo in mente l’antico adagio: quidquid recipitur, ad modum recipientis, recipitur. La Definizione è contenuta nella Tautologia. La Differenza è inclusa nell’Uguaglianza. Pensando a Identità e Differenza, si potrebbe dire che l’identità è ontologica e la differenza è la sua diversità dall’esistente. L’Essere è solo in sé, l’esistente non è in sé. «Dunque, saranno una cosa il contenente in quanto tale, un’altra il contenuto. Infatti una realtà nella sua interezza non potrà contemporaneamente avere la duplice funzione di subire e fare. Altrimenti l’Uno non sarebbe più Uno, ma due».
Questo passo del Parmenide gli sembrava la chiave di volta di tutta la questione. E intanto, di soppiatto, nel testo greco di Platone erano comparsi i due verbi dell’ACTIO e PASSIO: agire e subire. Il contenente agisce e il contenuto subisce. L’Essere agisce e l’esistente subisce. Anche se, a ben vedere, Platone aveva definito l’essere come capacità di agire e subire… già, ma tale definizione risentiva del solito pasticciaccio derivante dal gioco degli equivoci – ricorrente, in Platone –, consistente nello scambiare essere ed esistere senza uno stabile criterio definitorio. È l’esistere, che si può definire come capacità di agire e subire; l’essere è solo capacità di agire. Gli veniva in mente The Comedy of Errors, La commedia degli errori, di Shakespeare; ma anche La commedia degli equivoci, I Menecmi di Plauto… Il Parmenide, ma in genere tutti i dialoghi di Platone, sono “giocati” su una specie di commedia degli equivoci, equivoci tra Essere ed Esistere. La drammaturgia dei dialoghi platonici si regge sulla recitazione di Essere ed Esistere che giocano a scambiarsi i ruoli; e, se non si conoscesse l’insofferenza e l’antipatia che Platone nutriva per il sofismo, si potrebbe tranquillamente dire che la drammaturgia dei suoi dialoghi è “montata” ad arte per poter recitare una perfida e subdola commedia sofistica.
Ne era cosciente, Platone? Platone sofista suo malgrado? Il sofismo di Platone derivava forse da una coscienza ontologica ancora immatura, ancora acerba, per così dire: il realismo intransigente del V secolo avanti Cristo non sapeva distinguere tra Essere ed Esistere? Al punto da poter inscenare senza colpa il mastodontico equivoco dei dialoghi platonici? L’Essere Due innesca la spirale dell’esistente e si origina da un Essere che decide di farsi contenitore. La dualità ontologica si biforca in due direzioni: una soprannaturale ed una naturale; la dualità soprannaturale biparte Essere-Bene e Essere-Male e quella naturale l’essere-adamitico e l’essere-umano così come lo conosciamo. La diramazione ontologica di Male e Bene originò una deviazione che per la teologia cattolica è devianza, un deviare dalla retta via. La perversione della biforcazione consiste nel suo diventare Due: l’Essere, l’Uno, diventa Due per colpa di un Altro che gli si oppone esistenzialmente, cioè oggettivamente.
Davanti all’avverbio «oggettivamente» la discussione non può prescindere da una riflessione etimologica sul sostantivo «oggetto» condotta in tedesco: der Gegenstand. «Oggettivo» è ciò che è ‘posto davanti’: gegen + stand = che sta di contro, così come in latino «oggetto» è ob + iectum = ciò che è gettato (vedasi il progetto gettato di Heidegger). L’oggettività è la “colpa” di ciò che esiste in quanto sta di contro all’Essere. Lui si chiedeva: «Ma, stare di contro, è essere contro? Io potrei avere di fronte a me il mio amore, la mia amata, la quale, pur standomi di contro, tutto sarebbe tranne che contro di me». L’«essere contro» è la possibilità di essere visibile, questo pensava, Lui. Il peccato dell’oggettività è tutto nella possibilità di una visibilità indipendente dall’Essere: la colpa sta nell’operare quel distinguo senza di cui non si dànno idee chiare e distinte. Il contenuto vuole vedersi come distinto dal contenitore, vuole cominciare ad agire. La Totalità infinita diventa Tutto finito. Si impone una definizione che distingua tra Totalità e Tutto.
Rifletteva su quella frase del Parmenide: «una realtà nella sua interezza non potrà contemporaneamente avere la duplice funzione di subire e di fare». Solo ciò che è creato, cioè solo ciò che è esistente, può subire, oltre che agire; l’Essere non può subire, in teoria… in pratica, però, Lui pensava alla novità apportata dalla rivelazione cristiana: la passione e morte del Dio-Figlio. Prima di Cristo, Platone poteva anche pensare che l’Essere-Uno non potesse subire, in sé, nessuna divisione interna. Dopo Cristo, però, se si crede a un Dio che patisce la passione e morte di se stesso nel proprio Figlio, allora le cose cambiano…. «…una realtà nella sua interezza…»: il testo dice ὅλον. L’ontologia è per forza sempre olistica. L’«olismo» è la tesi secondo cui il tutto è più della somma delle parti di cui è composto. Ma a Lui appariva evidente che solo in senso ontologico, la Totalità può dirsi un assoluto non relativo alle sue parti, perché se Totalità è il Tutto Ontologico, esso non ha parti. La parte è il destino dell’esistente, che prende parte al Tutto perché ne fa parte: questa è la Moira.
L’olismo espresso dall’aggettivo ὅλος ὅλη ὅλον salvus facit… «Ma – pensava Lui –, non è un tutto, che ci salva, bensì il Tutto». Se si chiama il Tutto la Totalità ontologica, ci si risparmia il pietoso e problematico gioco di parole tra Tutto e Totalità. È l’«allotropia», il problema – pensava – ma lo diceva più in senso linguistico, che non chimico, facendo riferimento al fenomeno della presenza, in una lingua, di voci diverse nella forma, ma risalenti a una medesima voce originaria: il cosiddetto «polimorfismo». Platone nel Parmenide parla di ἡ ἀλλοίωσις: il mutamento, la differenza, l’alterazione, insomma, il cambiamento di una conversione dall’ego all’alius. La concezione aristotelica del Motore Immobile parte da questa considerazione platonica dell’Unum sistens, il quale non può che essere immobile, dal momento che non può subire mutazioni ontologiche. «Per far rientrare nell’ ὅλον ontologico il problema dell’alterità esistenziale, il cristianismo ha dovuto concepire un Essere in tre Persone ma in un’unica sostanza – pensava Lui –: l’essere della stessa sostanza del Padre da parte del Figlio, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, è l’escamotage con cui il simbolo niceno costantinopolitano esce dall’impasse dell’alterità che teneva in iscacco l’ontologia divina».
«Nella Trinità l’Essere risolve la propria consistenza ontologica nella sincronicità extratemporale del proprio Essere-Uno, seppur in Tre Persone – pensava Lui –: la sostanza divina non è ontologicamente, Coscienza di Essere, bensì Scienza di Essere: scientia essendi». Aveva in mente il § 21 di Psiche e techne, di Umberto Galimberti, laddove si legge che «la coscienza emerge dall’intervallo tra pulsione e soddisfazione».
A differenza della vita istintiva, la vita pulsionale, con i suoi caratteri di permanenza, plasticità e intenzionalità, sa procrastinare, attraverso l’inibizione, la soddisfazione immediata per quella futura se questa è più garantita. Ma per questo occorre un intervallo tra pulsione e azione, quell’intervallo presieduto dall’inibizione che crea lo spazio psichico per la selezione degli stimoli e la scelta dell’azione più vantaggiosa. [Umberto Galimberti: Psiche e techne / L’uomo nell’età della tecnica – Saggi Universale Economica Feltrinelli, Milano 2002 – § 19 L’eccesso pulsionale – pag. 188]
A Lui piaceva molto questo passo, ma gli piaceva anche trasporlo su un piano un pochino più metafisico: «e se l’intervallo fosse tra Anima e Spirito?». Galimberti scrive che «tra la pulsione e l’azione c’è un intervallo che è negato all’istinto. Questo intervallo è la casa di psiche». E se la casa di psiche fosse a due piani? Al primo piano, l’intervallo tra pulsione e soddisfazione, e, al secondo piano, l’intervallo tra animalità e spiritualità? Anzi, addirittura, si potrebbe persino pensare che i due piani siano stati entrambi costruiti sulle uniche fondamenta del fallo originale che causò la falla, cioè l’intervallo, sia in senso fisico sia in senso metafisico… si avrebbe una proporzione del tipo:
pulsione : soddisfacimento = anima : spirito
Umberto Galimberti aveva dedicato tutto il § 53 di Psiche e techne a La casa di psiche e il crollo delle sue mura. La coscienza è l’inter-vallo che interpone tra Anima e Spirito la possibilità della riflessione: la coscienza abita l’intercapedine posta tra scienza del bene e noscienza del male, tra scientia boni et noscentia mali. Per mettere a fuoco bisogna che la vista prenda le distanze giuste tra sé e l’oggetto che vuole vedere: per questo la vista deve rispettare la distanza di una corretta messa a fuoco, e per rispettare questa distanza deve allontanarsi dall’Essere-Bene. Allontanandosi dall’Essere-Bene la “vista” della conoscenza comincia lentamente a intravedere un Essere-Altro, il quale, non essendo l’Essere-Bene, fu chiamato l’Essere-Male. L’Essere-Bene, come Unum sistens, di per sé, è immobile.
Il gioco delle parti che Essere ed Esistere recitano nel Parmenide si può ben leggere nell’aporia di un Uno che, “non avendo luogo”, «…non è in quiete né è immobile». In un certo senso è u-topica, l’ontologia dell’Uno, perché l’Uno, non essendo in un luogo esistenzialmente definibile in senso spaziotemporale, non ha, appunto luogo; solo, per uscire da questa aporia, bisogna distinguere tra l’essere immobile dell’Unum sistens e il suo stesso essere mobile come Unum exsistens. Il divenire esistenziale è l’eterologia dell’Unum exsistens che dismette i panni della tautologia ontologica dell’Unum sistens. L’Essere monozigote diventa eterozigote. Il Semplice diventa Composto. Il latino simplex fu in precedenza il greco ἁπλόος che per contrazione fu anche ἁπλοῦς. È importante sapere che ὁ πλόος, contratto in πλοῦς, è «la strada» che si deve percorre in «navigazione», dal verbo πλέω che vuol dire «navigare». Invece dal verbo διπλόω, «ripetere», viene διπλόος διπλόη διπλόον: «doppio», altrimenti contratto in διπλοῦς διπλῆ διπλοῦν. Da tutto ciò emerge un itinerario esistenziale da immaginarsi come una sorta di “cammino” che l’Uno fa scendendo “giù” nella Molteplicità: l’incarnazione.
Lì, in ospedale, un neonato piangeva perché aveva fame e la sua mamma subito gli aveva messo la tetta alla bocca. E Lui ripensava all’intervallo esistente tra un bisogno e il soddisfacimento del bisogno stesso. Ci vuole tempo, per soddisfare un bisogno, il che significa che un Essere fuori del Tempo o non ha bisogni o li soddisfa subito… e gli veniva in mente ancora il Parmenide, quando dice che l’Unum sistens «non ha dunque alcun tempo né è in alcun tempo» e «Allora, se l’Uno non partecipa in alcun modo di alcun tempo, non è mai divenuto, né stava divenendo, né era, e ora non è diventato, né diviene, né è, e in futuro non starà divenendo, né sarà divenuto, né sarà». Solo nel tempo l’Essere diviene e solo nel tempo può esserci coscienza: se coscienza è intervallo, un intervallo può solo essere intervallo di tempo nello spazio. Fuori dello spazio temporale della coscienza c’è solo scienza, ma nell’Essere-Sciente non c’è tempo per prendere coscienza, né peraltro ve n’è la necessità.
Fondamentale, per Platone, è poi il concetto di partecipazione, espresso dal verbo μετέχω = μετά + ἔχω. Ecologia della metacomunicazione: ἡ μέθεξις. Per esistere bisogna partecipare all’Essere: οὐσίας μετέχειν. Lui era assolutamente convinto che la μέθεξις platonica fosse arrivata alla comunione cristiana senza troppe modifiche; come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica all’articolo 1331: «Comunione, perché, mediante questo sacramento, ci uniamo a Cristo, il quale ci rende partecipi del suo Corpo e del suo Sangue per formare un solo corpo»; Prima ai Corinzi 10,16-17: «il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane», οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. Come si può vedere, san Paolo usa lo stesso verbo di Platone: μετέχω. De uno pane participamus. La communicatio in greco è ἡ κοινωνία: la partecipazione.
La storia della cultura cristiana qui in Occidente ha per massima ambizione la sostantivazione: tende con tutte le sue forze al Sostantivo. L’Unum sistens è sostanza semplice: il massimo cui possa arrivare la fantasia ontologica dell’uomo occidentale. Non ha tutti i torti, Nietzsche, nel dire che il cristianismo è un platonismo per il popolo: il concetto di partecipazione che il latino communicatio e il greco ἡ κοινωνία traducono, è partecipazione a una sostanza, la quale è a sua volta sostantivazione di un aggettivo, o di più aggettivi. La transustanziazione che il cristiano crede avvenga al pane e al vino durante la consacrazione è partecipazione al corpo e al sangue dell’Essere: il pane è participio presente di pane e corpo, così come il vino è participio presente di vino e sangue divino. Come un oggetto, per il platonismo, è tale in quanto partecipa dell’Idea ad esso preposta, così pane e vino, per il cristianismo, sono corpo e sangue di Cristo in quanto partecipano della sua sostanza: l’Idea platonica è la sostanza cristiana: sostanza ontologica.
Le opere di Platone sono disseminate, qua e là, di dialoghi in cui si afferma la partecipazione all’Essere insita nella Teoria delle Idee. Per esempio, anche in un dialogo poco noto come l’Ippia maggiore, ricercando il Bello in sé, si cerca di arrivare all’Idea di Bello. Bruno Centrone nota che «Nella domanda socratica viene impiegato l’aggettivo sostantivato preceduto dall’articolo (τό), che in greco si presta a indicare:
- l’insieme delle cose x
- la particolare cosa x in questione
- la qualità o proprietà astratta X
In quest’ultimo senso noi intendiamo l’Idea in senso lato: quella che concettualizza tutte le qualità di ciò che è Bello, includendo sia l’insieme delle cose belle x sia la particolare cosa bella x in questione. Lui si era convinto che la sublimazione operata dalla Morale partisse da aggettivi, passasse per aggettivi sostantivati e finisse con dei sostantivi:

Se io ho il numero 1 ho un numero dispari; se ho i numeri 1, 3, 5, e 7 ho qualche numero dispari; se penso a tutti i numeri dispari ho l’Idea di Dispari: il concetto di Numero Dispari. La Categoria di Quantità percorre questi tre momenti: Uno → Qualcuno → Tutti = Unità → Pluralità → Totalità. La salita al Parnaso dell’Idea abbisogna della sostantivazione: si deve arrivare al sostantivo «Dispari» che comprende tutti i singoli numeri dispari e in questo modo ne permette la comprensione: quando un concetto è comprensivo di tutti i casi particolari che sussume, è possibile la comprensione di quegli stessi casi particolari.
«Il numero 1 è dispari perché partecipa dell’Idea di Dispari o perché è compreso nel Concetto di Dispari? – si chiedeva Lui –, forse la partecipazione è la fase ontologica della comprensione? e la comprensione è la fase logica della partecipazione? Se il nostro cervello è costruito, alla Kant, sui due “piani” di Intelletto e Ragione, chissà se si può dire che la partecipazione è la conoscenza razionale di una cosa e la comprensione ne è la conoscenza intellettuale?». Ma, al di là della varie congetture, la cosa più sicura è che, Concetto o Idea che sia, il livello più alto di comprensione è costituito dall’insieme più capiente, e la massima capienza si ha quando tutti gli aggettivi perdono la loro individualità per essere tutti e quanti compresi nel Sostantivo che li giustifica.
Il valore di un Aggettivo è nel Sostantivo che lo sostanzia sostantivandolo: la sostanza di una attribuzione è la sua sostantivazione. «Ma ora si impone un’attenta analisi etimologica del vocabolo – pensava Lui –: ‘aggettivo’ viene dal latino tardo adiectivum (nomen), derivato di adicĕre «aggiungere», traduzione del greco ἐπίϑετον (ὄνομα)». Adicio, is, ieci, iectum, ere: porre sopra, aggiungere. L’aggettivo è un «epi-teto» perché è voce del verbo ἐπιτίθημι = ἐπί + τίθημι, pongo sopra. Il sostantivo, a differenza dell’aggettivo, è substantivus proprio in quanto è la parte del discorso «che può stare da sè»: è la parte autonoma alla quale si riferiscono gli aggettivi.
Ci fu un tempo in cui Lui si trastullò nell’idea che l’ANALISI LOGICA potesse aiutare a chiarire l’ANALISI ONTOLOGICA. Nella sua famosa epìtome, intitolata Kant e la farfalla, Lui aveva già ben compendiato il rapporto tra analisi logica e analisi ontologica, anche in relazione all’analisi grammaticale, e la Critica della ragion pura di Immanuel Kant gli era servita proprio per suffragare il seguente ragionamento:
La sostanza è il SOSTRATO di ogni cambiamento. Dal latino substerno, is, substravi, substratum, ere: stendere sotto. La sostanza è “stesa sotto” al mutare fenomenico di una stessa realtà. Non avete mai notato che nella parola sostanza c’è un SUB? che non è un sommozzatore, ma è la preposizione che in latino vuol dire SOTTO? E vi siete mai accorti che quando facevate analisi grammaticale parlavate di SOSTANTIVO come una specie di attaccapanni sul quale mettere degli aggettivi? Sostantivo è SUB-STANTIVUS: sostanziale perché sta sotto anche lui. E allora, visto che ci siamo, diciamo che l’AGGETTIVO è l’ACCIDENTE:
SOSTANZA : ACCIDENTE = SOSTANTIVO : AGGETTIVO
Se non ci fosse un sostantivo “con le spalle larghe”, come potreste mettergli sulle spalle tutti gli aggettivi che volete? E, passando all’analisi logica: se non ci fosse un SOGGETTO, come potreste attribuirgli dei PREDICATI? Sostanza, Soggetto e Sostantivo fanno parte della stessa famiglia: la sostanza è in filosofia ciò che il soggetto è in analisi logica e il sostantivo in analisi grammaticale. Accidente, Predicato e Aggettivo fanno anch’essi parte della stessa famiglia, ma una famiglia che può solo INERIRE alla famiglia precedente: una famiglia di discendenti, per così dire.
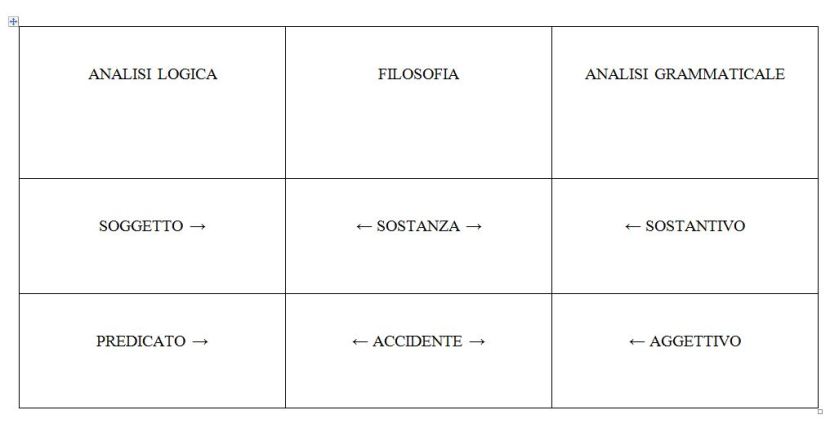
«Rapporti temporali sono dunque possibili soltanto nel permanente» e «solo in virtù del permanente, l’ESISTENZA, nelle varie parti della serie temporale, acquista una QUANTITÀ che prende il nome di DURATA», dice Kant. Domanda: se non ci fosse la sostanza, cosa sarebbe una successione? (per esempio la successione di bruco – crisalide – farfalla). Risposta: sarebbe qualcosa che non succede (= non avviene) perché nessuno stato presentandosi con una durata determinabile in relazione agli altri stati sarebbe verificabile, e quindi sarebbe come se non si verificasse, in quanto inconoscibile da noi.
«In tutti i fenomeni, il permanente è quindi l’oggetto stesso cioè la sostanza (phaenomenon)». A questo punto, se vi passasse per la testa l’idea che Kant potrebbe essere vecchio e che questa sua concezione della sostanza, come qualcosa di permanente sottostante le mutazioni esistenziali, è ormai superato, leggete questo passo: «Io trovo che in tutti i tempi non soltanto il filosofo, ma lo stesso senso comune, hanno presupposto tale permanenza come sostrato di ogni mutamento dei fenomeni e che anche nel futuro le cose non potranno assolutamente cambiare».
Tra l’altro, colgo l’occasione per notare, con Kant, che il Giudizio che connette un SOGGETTO-SOSTANTIVO-SOSTANZA ad un PREDICATO-AGGETTIVO-ACCIDENTE è un GIUDIZIO SINTETICO: come farei a giudicare la farfalla come un bruco o una crisalide, se non avessi mai potuto constatare nella realtà il fenomeno della metamorfosi del ciclo suddetto? Mai e poi mai, analiticamente, dal concetto di farfalla, si potrebbe dedurre quello di crisalide, o di bruco. Allora, il giudizio scientifico sulla metamorfosi suddetta è a posteriori, dal momento che bisogna sperimentarlo per conoscerlo, ma è anche a priori, perché la categoria di relazione, come inerenza e sussistenza, è il concetto puro che mi permette di concepire la sostanza di questo fenomeno al di là della sua metamorfosi.
Dai tempi in cui aveva scritto Kant e la farfalla, Lui era un po’ meno convinto che nella nostra testa ci sia veramente il concetto puro di relazione, messo lì ad arte, chissà da chi, proprio perché noi si possa “concepire” una sostanza sussistente e inerente a tutti i fenomeni che si riferiscono a quella stessa sostanza.
Provò a immaginare cosa avrebbe potuto essere, nel pensiero, un aggettivo senza un sostantivo di riferimento, e trovò nel seguente scambio di battute del Parmenide di Platone un bel modo per esemplificare tale pensiero di un aggettivo “orfano” di sostantivo:
- «…l’Uno né è Uno, né è, se si deve credere a questo ragionamento».
- «Potrebbe essere».
- «Ciò che non è, questo Non essere, potrebbe avere qualcosa o essere qualcosa?».
- «Come potrebbe?».
- «Non se ne ha quindi nome, né definizione, né scienza alcuna, né sensazione, né opinione».
- «Risulta di no».
- «Non è quindi nominato, né definito, né congetturato, né conosciuto, né alcuna tra le cose esistenti ne ha sensazione».
- «Sembra di no».
- «È possibile dunque che questa sia la condizione dell’Uno?».
- «A me non pare possibile».
Se dico «l’Essere è Uno», il nome Uno potrebbe essere inteso come aggettivo del nome Essere, il quale quindi ne sarebbe il nomen substantivum: in questo senso, Uno sarebbe il nomen adjectivum di Essere. Se l’aggettivo è tale in quanto “partecipa” del sostantivo al quale si riferisce, Uno, senza Essere, non è nemmeno aggettivo.
Quindi, l’Essere dell’Uno (ἡ οὐσία τοῦ ἑνός) sarà, anche se non sarà identico all’Uno. In caso contrario, infatti, il primo non sarebbe essere dell’Uno e l’altro, cioè l’Uno, non parteciperebbe (μετεῖχεν) del primo, ma sarebbe la stessa cosa dire che “l’Uno è” e che “l’Uno è Uno”. [Platone: Parmenide – Rusconi, Milano 1994 – traduzione di Maurizio Migliori – 142 b – pag. 123]
L’Essere dell’Uno come ἡ οὐσία τοῦ ἑνός pone nella sostanza, ἡ οὐσία, la sostantivazione che “regge” l’aggettivazione. Lui, poi, andava in brodo di giuggiole quando vedeva che il dizionario rimandava l’ οὐσία alla voce εἰμί, cioè alla voce del verbo «essere»: la lingua, almeno quella greco-latina, impone il dogma della partecipazione di un aggettivo alla sostanza ontologica cui esso è “soggetto”, cioè al proprio soggetto logico. L’essere soggetto a un sostantivo fa di un nomen un adiectivum e l’assoggettare un aggettivo fa di un nomen un substantivum. «Il totalitarismo ontologico si fonda sulla gerarchia categoriale dell’assoggettamento – pensava Lui –, cioè sulla dittatura della sostanza ontologica».
«È la sottomissione, il mettere sotto (i piedi?) che dà potere, e la sostanza non fa altro che sottomettere, – pensava Lui –: la sottomissione dell’assoggettamento sostantivale, poi, è la più subdola delle sottomissioni, perché è rea di un dolus, i che si nasconde sub, sub specie submissionis: sub + dolus = subdolo. La sostanza è la più subdola delle sottomissioni. La sostanza soggioga perché subordina: l’aggettivo dev’essere subordinato a lei, pena il non essere». Odiava il totalitarismo ontologico, Lui, ed era quindi ben naturale che odiasse di conseguenza anche il sostantivo e la sua sostanza: l’asservimento. «Chi ci libererà dalla sostanza?», pensava sempre. Lui si sentiva un umile aggettivo, predicato unicamente come accidente dell’Essere; era il cristianismo, complice il platonismo, che l’aveva ridotto a questa frustrazione ontologica, derivante da quel senso di inutilità e di impotenza che il totalitarismo ontologico crea efficacemente imponendo il dogma della partecipazione: la communicationis dogma, come la chiamava Lui. I salesiani, zoccolo duro del cattolicesimo, in giovane età gli avevano inculcato questo dogma piantandogli saldamente in testa il chiodo fisso della comunione sacramentale; “confessione e comunione, sennò, niente salvezza”, gli avevano sempre ripetuto in tutte le salse.
Per colpa (o merito?) del cattoplatonismo, Lui si sentiva Uno che «è» solo se partecipa dell’Essere (o all’Essere?). Il Parmenide di Platone parlava del suo dramma esistenziale:
- «Dunque, l’Essere indica qualcosa di diverso da Uno».
- «Necessariamente».
- «Allora, quando si dice sinteticamente: “Uno è”, non si afferma altro se non che l’Uno partecipa dell’Essere?».
- «Senza dubbio».
A dire il vero Lui di dubbi ne aveva, e tanti. Uno «è» soltanto se partecipa dell’Essere: οὐσίας μετέχει (?). Lui si sentiva “uno”, magari non “Uno”, ma Qualc-uno sì, e, faceva fatica a credere che senza la comunione con l’Essere che si sostanzia sotto le specie del pane e del vino durante la Messa non avrebbe mai potuto essere, al di là, quella povera anima in pena che era al di qua. Avrebbe voluto sapere cosa ne avrebbe detto, Platone, di un’anima che perde l’animazione se non mangia l’Essere che si dà in pasto sacramentale dall’altare di una chiesa per mano di un prete, magari pure salesiano…
- «Ripetiamo di nuovo: se l’Uno è, che cosa ne risulta? Osserva: questa ipotesi non significa necessariamente che l’Uno è tale da comportare delle parti?».
- «Come dici?».
- «In questo modo: se l’Essere si dice dell’Uno-che-è e l’Uno dell’Essere che è Uno, non sono la stessa cosa l’Essere e l’Uno, ma si predicano entrambi di quella realtà che abbiamo posto come ipotesi, dell’Uno-che-è. Non è allora necessario che lo stesso Uno-che-è sia un tutto, di cui siano parti l’Uno e l’Essere?».
- «Necessario».
…se l’Essere si dice… «si dice»: λέγεται. Se il verbo λέγω è il latino lego, allora vuol dire che il suo “dire” col-lega insieme un Uno qualsiasi con il suo stesso Essere… piaceva tanto, ad Heidegger, questo “collegamento”. Tutto sta a vedere in cosa consista e quanto sia grande il potere copulativo del verbo essere, cioè, tutto sta a vedere cos’è, la copula ontologica.
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/copula/
còpula s. f. [dal lat. copŭla «legame, congiunzione»]. –
- letter. Accoppiamento, spec. nel senso di congiunzione sessuale, coito.
- In anatomia comparata, sinon. di basibranchiale.
- In grammatica, la congiunzione e; più spesso, la forma verbale che unisce il soggetto e il predicato nominale, tratta, nelle lingue indoeuropee, dai verbi significanti «essere» (per es.: lat. «homo est animal», ital. «l’uomo è un animale», oppure «il mare era calmo», ecc.).
- Nell’antica terminologia chimica, parte di un composto chimico capace di unirsi con altre per dare sostanze dette appunto copulate.
- Nella terminologia musicale dei sec. 12°- 13°, il termine latino copula era usato per indicare una specie distinta di discanto consistente in una coda a note brevi che una voce svolgeva nell’ultima nota del canto fermo.
La copula unisce soggetto e predicato nominale. Il cattoplatonismo fa del Soggetto-Cristo l’Idea divina capace di dar senso al soggetto-uomo che di Lui si predica. Ogni predica(zione) che si rispetti comporta il concetto di partecipazione: se l’Uno si predica dell’Essere, vuol dire che l’Uno «è» solo se partecipa dell’Essere; ma, molto più terra terra: se uno «è», è perché si predica dell’Essere. «Vuol dire che…» sta per «significa che…»: il significato è ciò che «si dice», ciò che può «essere detto» di qualcosa.
«Furbi, i preti! – pensava Lui –, loro fanno la predica… quale modo è più furbo, per chiamare un discorso, se non il chiamarlo ‘predica’? la predica è il discorso che più di tutti predica la necessità di far sì che ogni predicato si predichi sempre dell’Essere, quindi la predica è il predicato più ontologico che c’è. Furbi, i preti: loro sono i servi dello stesso totalitarismo ontologico con cui asservono i fedeli dell’Essere all’Essere».
- «Adesso considera anche questo aspetto».
- «Quale?».
- «Noi diciamo che l’Uno partecipa dell’Essere e che per questo è?».
- «Sì».
- «E per questo l’Uno-che-è ci è apparso molteplice?».
- «Proprio così».
- «Che dunque? L’Uno in sé, che noi diciamo partecipare dell’Essere, se con il pensiero riusciamo a considerarlo in sé, da solo, senza questo, di cui diciamo che partecipa, allora, ci apparirà solo uno o anche molteplice?».
- «Io credo uno».
- «Vediamo allora: è necessario che una cosa sia il suo Essere, un’altra esso stesso,se l’Uno non è l’Essere, ma partecipa dell’Essere in quanto Uno».
- «Necessario».
- «Dunque, se una cosa è l’Essere, un’altra l’Uno, l’Uno non è diverso dall’Essere perché è Uno, né l’Essere è altro dall’Uno perché è Essere, ma sono diversi tra loro per la Diversità e l’Alterità».
- «Senza dubbio».
- «Perciò la Diversità non è uguale né all’Uno né all’Essere».
- «Come potrebbe, infatti?».
«No, non si può parlare dell’Essere, cioè dire l’Essere, con lo strumento concettuale della partecipazione – pensava Lui – , è uno strumento esistenziale, la partecipazione, con il quale non si può predicare l’Essere, ma solo l’Esistere. Prova ne è che, per descrivere, cioè dire, le tre Persone all’interno della Santissima Trinità, la teologia cristiano-cattolica ha dovuto precisare e sottolineare tre volte che si tratta di generazione, non di creazione: il Figlio è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre…».
Quando una cosa è creata, cioè generata esistenzialmente, non è della stessa sostanza di colui che l’ha creata. Questo gli parve poco, ma sicuro. Invece, se uno è generato ontologicamente, allora è consustanziale a chi l’ha generato. I Tre della Trinità, possono permettersi il “lusso” di essere molti solo perché nessuno dei Tre è stato creato dall’altro: non hanno bisogno di partecipare dell’Essere, per essere, perché essi sono l’Essere, sì che Essi sono Molti e Uno allo stesso tempo, cioè in nessun tempo. Poi, un bel giorno, anche se, fuori del tempo non può sorgere nessun giorno – ma fa lo stesso – un bel giorno, i Tre decidono di creare il Creato, e allora, da quel momento, il primo momento del tempo, Tutto è in quanto partecipa dell’Essere. Un altro bel giorno ancora, poi, un essere, l’essere umano, decide di non partecipare più dell’Essere, e si autocondanna a dover aspettare che l’Essere si incarni per dar nuovamente modo all’essere umano di poter partecipare dell’Essere, con la confessione e la comunione… viva i salesiani!
«È come se una madre minacciasse il proprio figlio dicendogli: o torni dentro di me, o sarai perduto». Folle. E gli pareva di vederlo, quel figlio mammone, che faceva di tutto per rientrare là, in quel paradiso amniotico da dove era uscito, un brutto giorno più o meno lontano, quando il peccato originale della nascita l’aveva condannato a non essere più in comunione con la propria madre; gli sembrava di vederla, quella testa di cazzo, intestardirsi per cercare di rientrare nella vulva di sua madre, senza farcela più: facile uscire, meno facile rientrare – pensava Lui – la nascita è irreversibile, non si può tornare indietro. E poi sentenziava il suo motto preferito:
Ogni penetrazione vaginale
è il folle tentativo
che una testa di cazzo compie
per cercare di far rientrare il problema
che l’ha messo al mondo.
In greco τὸ ἀμνίον è il sacco amniotico in cui pascola il feto prima di nascere, forse perché ἀμνίον è da mettere in relazione con ἡ ἀμνός: l’agnello. Il cappellano passò sussurrando: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi… e a Lui venne da chiedersi se l’Agnello immolato c’entrasse per caso qualcosa con l’immolazione amniotica dei nascituri…
L’Essere è dunque il liquido amniotico di tutto ciò che esiste? Dio, a differenza delle mamme, pretende che i suoi figli gli ritornino in seno, alla fine dei tempi: qualcuno per abortirlo, qualcun altro per farlo nascere a nuova vita. È un padre premuroso, il Dio della Vita, anzi, è Padre e Madre allo stesso tempo: infatti può permettersi l’androginia perché è fuori del tempo; è un dio ermafrodita, il dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? O forse è l’Essere, che è bisessuale, per poter far da Padre e da Madre insieme? O forse, fuori del tempo, non è nemmeno il caso di parlare di sesso? Forse la sessualità è solo nel tempo? Del resto, senza tempo, come farebbero a passare i nove mesi necessari per far fuori un feto?
Dio non ci ha messo nove mesi, e nemmeno nove giorni, per creare Tutto: ci ha messo sei giorni, e il settimo si è riposato; parola di Genesi 1,27-28:
E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
Lui aveva sempre pensato che, chissà, se in quei tempi ci fosse già stata la “settimana corta”, il Creatore forse non avrebbe creato l’Uomo: avrebbe magari iniziato il suo week-end di venerdì e il sesto giorno dell’esamerone si sarebbe risparmiato la fatica di creare l’Uomo… quando pensava questo, la settimana corta gli sembrava una stupenda occasione buttata via dalla storia; ma evidentemente, a quei tempi, non c’era ancora, la settimana corta, o probabilmente il Creatore la faceva lunga, la settimana: chi lo sa? difficile a dirsi.
«Maschio e Femmina, li creò». La prima coppia, dopo quella, più impegnativa, di Bene e Male.
- «Che dunque? Se tra questi prendiamo l’Essere e la Diversità, se vuoi, oppure l’Essere e l’Uno, o l’Uno e la Diversità, allora non prendiamo forse ogni volta una realtà, che giustamente deve essere chiamata coppia?»
- «Come dici?».
- «Così: si può dire “Essere”?».
- «Si può».
- «E poi ancora dire “Uno”?».
- «Anche questo».
- «Non abbiamo così nominato ciascuno di essi?».
- «Sì».
- «E allora, quando dico “Essere e Uno”, io non indico la coppia insieme?».
Genesi 2,18: E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ’αὐτόν. Non est bonum esse hominem solum: faciamus ei adjutorium simile sibi. Nelle intenzioni di Dio, la donna doveva essere per l’uomo un aiuto «bell’e buono»: καλὸν e bonum. Lui aveva ancora in testa l’Ippia maggiore di Platone, con la sua disquisizione sulla kalokagathìa: ἡ καλοκἀγαθία.
Forse non era bene che l’uomo fosse solo, perché, da solo, l’uomo non è “buono a” far figli?
«Il significato del termine Agathón, che la tradizione filosofica traduce solitamente con “Bene”, non è da affidare a un contesto morale, ma a un contesto metafisico, volto alla ricerca della causa prima da cui ogni cosa dipende. Infatti, scrive Heidegger: “Tò Agathón significa in greco ciò che è atto (taugt) a qualcosa e che rende atto (tauglich) a qualcosa”. Se dunque Agathón significa “ciò che è buono a…”, l’idea di Bene si riferisce a “ciò che è buono a far essere e a far apparire ogni cosa”. Il Bene è Bene in quanto causa, il suo valore (bonum) consiste nell’esser causa di tutto ciò che è» [Umberto Galimberti: Il tramonto dell’Occidente / nella lettura di Heidegger e Jaspers – Saggi Universale Economica Feltrinelli, Milano 2005 – pag. 185]
Nell’Ippia maggiore, Socrate dà esattamente questa definizione di Buono come qualcosa che è “buono a…”, quando dice a Ippia:
- SOCRATE: «Quindi, diciamo ora correttamente che bello (καλόν) è più di ogni altra cosa l’utile (τὸ χρήσιμον)?».
- IPPIA: «Correttamente di sicuro, Socrate!».
- SOCRATE: «Dunque, ciò che è capace (τὸ δυνατὸν) di produrre una certa cosa è anche utile rispetto a ciò in vista di cui è capace, mentre ciò che è incapace (τὸ ἀδύνατον) è inutile?».
- IPPIA: «Certo».
- SOCRATE: «Bello è quindi una capacità (Δύναμις μὲν ἄρα καλόν), brutto un’incapacità (ἀδυναμία δὲ αἰσχρόν)?».
- IPPIA: «Assolutamente…».
Poche righe prima, Socrate aveva detto ad Ippia:
In generale, dunque, queste cose le diremo belle nello stesso senso: guardando alla natura di ciascuna di esse, alla sua produzione, alla sua condizione, diciamo bello ciò che è utile sia per come è utile, sia in relazione a ciò per cui è utile, sia per il momento in cui è utile, mentre brutto ciò che è inutile in tutti questi sensi. [Platone: Ippia maggiore – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2012 – traduzione di Federico M. Petrucci – 295 d-e – pag. 125]
«Che squallido! – pensava Lui –: porre l’utilitarismo a fondamento della bontà, e per di più ontologica!». E dunque, non era bene, che l’uomo fosse solo, perché da solo non sarebbe stato “buono a…” far figli?
Più pensava alla deontologia ontologica del cattoplatonismo, e più gli veniva da tessere l’elogio del «buono a nulla». «L’unica cosa “bell’e buona”, per questa gente, è ciò che è capace di fare qualcosa – pensava Lui – e in sommo grado ciò che è capace di ‘far essere’: il porre in essere, l’arte delle arti». Più passava il tempo e più gli diventava simpatica la figura del “perdigiorno”, di colui che vive senza credere che il tempo sia denaro e che quindi lo butta via convinto di non diventare per questo più povero, anzi. Più lo si butta via, più il tempo ci fa ricchi, pensava. Non amava vivere secondo la categoria della quantità, ma secondo la categoria della qualità.
Cos’è, l’Uno? Un numero? O un Essere? O l’Essere? Lui pensava che la modalità esistenziale fosse decisa dalla risposta che si dava a questi interrogativi. E gli veniva in mente quella frase del Parmenide: «Se allora l’Uno è, necessariamente anche il numero è». Lui avrebbe preferito che Platone dicesse: se allora l’Uno è, necessariamente anche il numero esiste. Alle solite: lo scambio equivoco dei verbi Essere ed Esistere rendeva incomprensibile questo capolavoro platonico… L’Unum sistens non è numerabile, solo l’Unum exsistens lo è. L’Essere, per poter esistere, deve lasciarsi numerare, enumerare, annoverare, contare. Forse si può dire che il passaggio dall’Uno al Due, prima nell’oggettivazione del Male e poi in quella della Donna, significano proprio l’inizio dell’Esistenza oggettuale del Creato.
Non era bene che l’Uomo fosse solo, ma fu male che il Bene non fosse solo: l’opposizione Bene / Male come opposizione Dio / Satana, dimostra che era Bene che il Bene fosse solo (forse perché non era mai stato solo, essendo sempre nella Trinità delle sue Tre Persone?). Insomma, Dio era bene che restasse solo in compagnia della sua Trinità, mentre l’Uomo non era bene che restasse solo in assenza della sua Donna. La dualità che si origina, a livello angelico, dall’oggettivazione del Bene in Male, non è Buona, come lo è quella che crea l’oggettivazione del Maschio in femmina. L’Essere che fa esistere esiste nel Tutto composto da innumerevoli parti: innumerevoli perché sono tante, non perché non sono enumerabili.
- «Ma se c’è il numero, c’è molteplicità e infinita pluralità degli enti; non è forse il numero molteplicità infinita e partecipe dell’Essere?».
- «Senz’altro».
- «Dunque, se il numero nella sua totalità partecipa dell’Essere, forse ne partecipa anche ogni parte del numero?».
- «Sì».
- «Allora, l’Essere è suddiviso in tutta la molteplicità e non manca a nessuno degli enti, né al più piccolo, né al più grande? Ma non è assurdo aver detto questo? In che modo, infatti, potrebbe mancare l’Essere a uno degli enti?».
- «In nessun modo».
- «Allora, l’Essere si suddivide sia in parti piccolissime, sia in parti grandissime, in tutte le forme possibili, esso più di tutte le altre realtà si suddivide e le sue parti sono innumerevoli».
- «È così».
La conclusione è che «In ogni singola parte dell’Essere, allora, è presente l’Uno, il quale non manca ad alcuna, né alla più piccola, né alla più grande, né a nessun’altra». Lui pensava: «L’esistente è l’essere “tante volte” quante l’Essere è. L’enumerazione è la modalità esistenziale di pensare l’Essere sub specie speciei, cioè sub specie discreti; discretus, discreta, discretum è il participio di discerno: dis + cerno = dis-tinguo, separo. La species, la sembianza fenomenica, deriva dalla discrezione di una cernita: speciosus viene dal verbo spicio, cioè specio, is, spexi, spectum, ere: guardare; specioso è ciò che è visibile, ed è visibile in quanto è stato discretizzato. Lui andava fiero, della pseudo-tautologia espressa dalla locuzione latina sub specie speciei, dacché gli sembrava che questa rendesse bene l’idea del fatto che, l’Uno, se non si manifesta fenomenicamente, resta invisibile, e, se si manifesta, diventa numerabile, cioè si assoggetta ad una quantificazione esistenziale che ontologicamente sarebbe impossibile: finché se ne resta al di là, nel cielo della suo ontologia, l’Essere va esente da ogni quantificazione e quindi da ogni mercificazione; ma, se ne scende al di qua, rischia di perdersi nelle parti del Tutto.
Ciò che pone in essere non è soggetto al numero, quindi è Uno-che-è; ciò che è posto in essere è assoggettato al numero, quindi è uno-che-è-uno: 1. La kalokagathìa è dunque l’utilità di qualcosa, e questa utilità è capacità di porre in essere, essere buoni a far essere, laddove “fare” è appunto la poiesi creativa: questo è vantaggioso.
- SOCRATE: «Il bello, Ippia, ci sembra quindi essere il vantaggioso (τὸ ὠφέλιμον)».
- IPPIA: «Certamente, Socrate, in ogni caso!».
- SOCRATE: «Ora, il vantaggioso è ciò che produce qualcosa di buono (τὸ ποιοῦν ἀγαθόν)».
- IPPIA: «Lo è».
- SOCRATE: «Ma ciò che produce non è altro se non la causa (τὸ αἴτιον), o no?».
- IPPIA: «È così».
- SOCRATE: «Dunque il bello (τὸ καλόν) è causa del buono (τοῦ ἀγαθοῦ)».
Col che, il cerchio si chiude: la causa prima è quella “bell’e buona” a porre in essere. Ma l’Essere pone in essere l’esistere, e l’esistere è doloroso assai. Tutti dicevano che era la sua algesia eccessiva, la sua eccesiva sensibilità al dolore, a fargli dire queste cose, ma Lui diceva che la vita fa male, e che bisogna cercare un analgesico adatto: lo chiamava “vitalgesico”; cercava un vitalgesico capace di ridurre o eliminare τὸ ἄλγος, il dolore. Non era un “freddo”, Lui, non era così algus da poter far finta di niente, davanti alla vitalgia.
«Il Bello è causa del Buono. Mah! – pensava Lui –, cosa ci sia di Buono nell’Esistere e di Bello nell’Essere, lo sa solo il ‘Pastor Bello’ che è ‘Pastor Buono’». Era la solita storia di Giovanni 10,11: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· Ego sum pastor bonus. Il cattoplatonismo ha fatto completamente sua la lectio platonica secondo la quale fra Bello e Buono non c’è differenza… differenza… «Differente» viene dal latino differo, differs, distuli, dilatum, differre: spargere, disseminare e poi anche differire, rinviare, donde differenziarsi. Differire è portare (ferre) altrove (dif), uno «spostare» che fa «esser diverso»: in latino, diverto significa appunto «scostarsi da»; diverto, is, verti, versum, ere: il participio passato della diversione è il diversum dell’italiano «diverso».
Sia il «diverso» sia il «differente» portano in sé, etimologicamente, il senso di uno sfasamento causato da uno spostamento. Il comune prefisso dis – che linguisticamente è sempre foriero di dis-grazia –, è dif-ferenza e div-ersità in quanto fero e verto che diventano differo e diverto. Lui pensava che il peccato originale fosse consistito essenzialmente in una dis-locazione: una location sfalsata diversamente; un trasferimento altrove, ma non solo nel senso, fin troppo facile, dell’Uomo che viene cacciato fuori dalla Casa del Padre, bensì, soprattutto, nel senso ontologico e gnoseologico, di un essere che non è più “tutt’uno”: una dissonanza cognitiva e ontologica, anzi, cognitiva perché ontologica.
Un non addetto ai lavori filosofici del pensiero potrebbe rimanere stupito, del fatto che si dia tanta importanza all’Uno; per esempio, il Parmenide di Platone, e ancor prima il poema Sulla natura di Parmenide stesso. Siamo nel 500 avanti Cristo, e il discorso sull’Uno è il centro della speculazione sull’Essere. Perché? Perché l’Essere, se non è tutt’uno, comincia a esistere, e allora sono guai. È fondamentale, questa espressione, tutt’uno; sembra un modo di dire, ma nasconde in sé la verità della prima “casa” umana al di là e del successivo trasloco originale nella seconda “casa” umana al di qua. Non è semplicemente un traslato, una metafora, il trasloco originale: è la traslazione della salma umana nella bara del proprio corpo mortale, alla Platone. Prima del trasloco, prima della dislocazione dell’essere umano, l’Esistere era tutt’uno con l’Essere: l’univocità dell’Unum sistens non era ancora uscito fuori di sé per andare ad abitare l’equivocità dell’Unum exsistens. I sinonimi Essere ed Esistere diventano contrari. L’equivoco si fonda sul fatto che l’Esistere evoca (-voco) l’Essere come se gli fosse eguale (equi-): ma evocare è ricordare, richiamare alla memoria, non è un essere presente; senza differenza, senza diversità tra Essere ed Esistere non si potrebbe nemmeno equivocare, chiamare in modo equo, in modo eguale, come se fosse lo stesso, Essere ed Esistere, come se fosse tutt’uno.
L’Esistere comincia ad esistere quando l’Essere non è più in sé, cioè quando di contro a Lui si staglia, netta, la figura della presenzialità obiettiva, oggettiva, dell’Altro, che è praesens in quanto ens che sta prae, che sta di contro, come ob + iectum: oggetto. L’Essere, che pre-esiste, diventa esistente quando ciò che ha posto in essere decide di esistergli di contro. La metafora dell’albero del Bene e del Male nasconde in sé l’essenza dell’informazione: ‘percezione di una differenza’. Lui non finiva mai di cantare le lodi di Gregory Bateson, per questa geniale intuizione che definisce l’informazione come la percezione di una differenza. Ma certo! Adamo ed Eva peccarono perché vollero essere informati, e per essere informati dovettero carpire la percezione della differenza tra Bene e Male, tra Essere ed Essere-Altro: questo carpire fruttò il capire, capire una dislocazione alternativa dell’Essere.
Carpe malum. La tentazione luciferina spinge verso la disformità, un altro bel sinonimo di differenza, che parla di una forma difforme rispetto ad un’altra forma: la forma del Male è semplicemente il suo essere “difforme al Bene”, il suo non essere ‘conforme al Bene’. Per vedere due forme, due sagome, due figure, bisogna che esse non siano sovrapposte, bisogna che non siano coincidenti: la coincidenza dell’Essere che non esiste ancora si può immagginare come uniformità ontologica, identità assoluta di sé con se stesso. La parola uni-formità contiene l’Uno nel suo prefisso: uni, a dire che l’abito ontologico primigenio vestiva l’uniforme, un habitus d’ordinanza che era il suo aspetto ontologico. Poi, l’Uomo decise di cambiarsi d’abito, e, toltasi l’uniforme, smise i panni ontologici dell’uniformità, cominciando a vestire quelli esistenziali della difformità.
Ma, difformità non è deformità. Difforme è ciò che ha una forma diversa, differente rispetto ad un’altra forma. Deforme è ciò che ha una forma diversa, differente da una forma naturale. Naturale: in questo aggettivo sta tutta la colpa della deformità; perché, se essere diversi da qualcosa è solo essergli differenti, non c’è nulla di Male, ma, se essergli differenti è essere diversi da qualcosa di normale, di naturale, allora la diversità è una differenza sostanziale: è anormalità. Donde tutti i sinonimi di deforme: storpio, sformato, informe, mostruoso, ripugnante, grottesco… in una parola: malfatto. Lui ne era convinto: l’essere deforme è nel prefisso «mal-» che precede il «-fatto»: il difforme non è malfatto, è solo diverso, differente; il deforme è malfatto. La malformazione del deforme, infatti, viene da una… malefatta! Un misfatto è alla radice della malefatta che deforma l’Essere storpiandolo nella difformità deforme del suo Esistere: questo è (il) Male.
Il Male è la colpa della diversità. Il Bene gliene fa una colpa, al Male, del suo aver voluto differenziarsi da Lui scegliendo di diventargli alternativo in una forma a Lui differente. «L’omofobia, nel suo senso etimologico più puro, cioè scevro da connotazioni sessuali – pensava Lui –, è un fenomeno prettamente esistenziale: la fobìa per l’identità ontologica espressa da ὁμός ὁμή ὁμόν è la paura che ha non ha timor di Dio, è il panico che nasce quando si teme di dover essere costretti in eterno ad essere tutt’uno con l’Essere, senza poter mai errare liberamente per gli errori dei vicoli ciechi che sconfinano equivocamente dalla via maestra della verità ontologica». L’Uomo scelse di viaggiare, di cambiare casa, di traslocare: questo è Male?
L’abitudinaria sedentarietà dell’Essere pare non tollerare evasioni e vagabondaggi esistenziali. A Lui veniva in mente la parabola del figliol prodigo narrata in Luca 15: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto…». Il figlio più giovane è quello che sceglie di uscire dall’Essere del Padre per intraprendere l’avventura esistenziale: errare nell’errore. Il paese lontano in cui il figlio minore va ad abitare è un postaccio proprio perché è lontano dall’Essere in cui è, in cui “abita” il Padre: Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας· ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. La colpa del figliol prodigo è quella di aver sperperato la sostanza del Padre, cioè la sostanza dell’Essere. Lo scialacquare esistenziale è possibile dal momento che si “divide” l’Essere in parti: il testo greco lo dice bene, nella richiesta del figlio minore di avere μέρος τῆς οὐσίας, la (propria) parte di sostanza. La sorte, la Moira, nasce da un esistere al di fuori dell’Essere: il destino di un mortale nasce dal suo essere uscito dall’Essere per intraprendere il viaggio nel tempo e nello spazio dell’esistere.
Lui era molto colpito, dal fatto che il greco di Luca parlasse di μέρος τῆς οὐσίας. Ancora più colpito era dal fatto che questa parte di sostanza paterna fosse la vita biologica: ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον, l’Essere dà la vita biologica solo a chi sceglie di uscire dalla vita ontologica, questo gli pareva il senso profondo della parabola evangelica. Se fosse così, la parabola del figliol prodigo sarebbe una grande metafora del peccato originale: la libera scelta che l’essere umano fa di vedere il suo Essere da fuori; questo sintagma, «da fuori», è nel prefisso ex che si appone a sistentia quando si parla di ex-sistentia. Il peccato fu: scegliere di e-sistere. Il partire del figliol prodigo è in ultima analisi il parto di un Essere che fu costretto a mettere al mondo chi volle partirsi da Lui. È assai suggestivo, e fors’anche rivelatore, il fatto che in latino partio partionis sia, come sostantivo femminile, «il parto» derivante da un deporre le uova, e, come verbo, lo spartire di partio, is ivi (ii), itum, ire: partitum fu il figliol prodigo, il primo essere esistente, che decise di esistere partendosi dall’Essere paterno. La vita ontologica, violentata da uno stupro peccaminoso, partorisce la vita biologica e il destino comincia ad incombere sull’essere umano. Glo veniva in mente il Parmenide di Platone:
- «Allora, l’Essere si suddivide sia in parti piccolissime, sia in parti grandissime, in tutte le forme possibili, esso più di tutte le altre realtà si suddivide e le sue parti sono innumerevoli».
- «È così».
- «Dunque, le sue parti sono in un numero che è il maggiore in assoluto».
- «Il maggiore, certamente».
- «Che dunque? Ce ne può essere qualcuna che è parte dell’Essere, ma che è nessuna parte?».
- «Come infatti potrebbe accadere una tal cosa?».
- «Ma se è, credo che finché è, necessariamente sia sempre una ed è impossibile che sia nessuna».
- «È necessario».
- «In ogni singola parte dell’Essere, allora, è presente l’Uno, il quale non manca ad alcuna, né alla più piccola, né alla più grande, né a nessun’altra».
Rileggendo questo scambio di battute, a Lui parve di leggere, tra le righe del dialogo platonico, una sorta di esegesi della parabola del figliol prodigo. Che altro è, “andare incontro alla propria sorte” – come si dice – se non pretendere, tendere a priori, alla propria parte di Essere? E poi, se si va a vedere il testo greco quando si parla dell’Essere che si suddivide in parti, questo «suddividersi» è proprio μεμέρισται cioè il verbo del suddividere il pleroma ontologico nelle parti di τὸ μέρος, la parte di eredità ontologica che l’Essere dà a chi vuole vivere la propria vita biologica. «Però – pensava Lui –, il figlio maggiore non ha deciso di andarsene a vivere fuori della Casa del Padre, è rimasto col Padre, lui, è rimasto con l’Essere… voglio dire: se uno decide di andarsene, peggio per lui: decide di andarsene incontro alla morte, termine ultimo e ineludibile dell’esistenza: chi decide di vivere deve mettere in conto anche la morte, chi decide di vivere decide anche di morire. Ma, chi decide di non vivere…». Lui pensava che, se la parabola del figliol prodigo fosse veritiera, dovrebbe essere reale anche la possibilità che qualcuno decida di non voler esistere, di non voler uscire dalla sistenza del Padre. In teoria, chi decidesse di restarsene nell’Essere paterno non dovrebbe prendersi pena della morte, non dovrebbe meritarsi la pena di morte che incombe su tutti coloro che vanno a vivere da soli. Il figlio maggiore è rimasto col Padre, in causa sua, la casa dell’Essere: lui non dovrebbe aver commesso, dunque, nessun peccato originale, pensava, Lui. «Se la parabola del figliol prodigo fosse veramente attendibile, dovremmo poter pensare, lassù nell’Eden, a degli esseri umani che, a differenza di Adamo ed Eva, decisero di restare nel paradiso terrestre senza commettere alcun peccato, o no?».
In effetti, non era poi così improponibile, l’ipotesi, prospettata dalla stessa parabola del Figliol Prodigo, di esseri umani che, essendo rimasti fedeli, non si sono meritati la pena capitale insita nell’esistenza biologica. Può sembrare una specie di fanta-vangelo, ma, a ben vedere, è assolutamente evangelica, la possibilità che il figlio maggiore possa essersene stato buono buono nella Casa del Padre senza meritarsi nessuna maledizione. La desistenza. La desistenza è la morale del figlio maggiore, quello che decide di non nascere per non dover tradire l’amore di suo Padre. La desistenza è l’atto più morale che l’Essere possa desiderare: i desistenti sono i prediletti del Padre Celeste, o almeno dovrebbe essere così, perché sono gli unici che scelgono di non far nascere altri “figli minori” traditori e rinnegati. «Sì – pensava –, i desistenti sono il sogno proibito dell’Essere, il suo sogno inconfessabile… del resto, come fa, l’Essere, a confessare che i suoi figli prediletti sono quelli che decidono di non esistere? Solo i desistenti sono figli del Dio Maggiore, gli altri sono figli di un dio minore: la vita biologica».
L’Unum exsistens è l’Uno che è stato costretto a spartire le proprie sostanze, la propria sostanza ontologica sussistente, diventando l’Uno che «è né più né meno della totalità delle sue parti», come si legge nel Parmenide di Platone.
- «Ma l’Uno non è anche il tutto?».
- «Come no!».
- «Se dunque tutte le parti si trovano ad essere nel tutto, visto che l’Uno è tutte le parti ed è anche lo stesso tutto, se tutte sono contenute nel tutto, l’Uno sarà contenuto dall’Uno: così si conclude che l’Uno stesso sarà in sè».
- «Appare così».
- «D’altra parte il tutto certamente non è nelle sue parti, né in tutte né in qualcuna. Se infatti fosse in tutte, necessariamente sarebbe anche in una, perché, se non fosse in una qualsiasi, non potrebbe nemmeno essere in tutte: se infatti questa parte è una fra tutte, se il tutto non è in questa, come potrebbe allora essere in tutte?».
- «In nessun modo».
- «Ma il tutto non è nemmeno in qualcuna delle parti. Se infatti il tutto fosse in qualcuna, il più sarebbe nel meno, il che è impossibile».
- «Infatti, è impossibile».
- «Ma se il tutto non è né in molte parti, né in una, né in tutte, non è forse necessario che sia in qualche cosa d’altro, oppure in nessun luogo?».
- «È necessario».
- «Dunque, se non fosse in nessun luogo non sarebbe affatto; ma il tutto, che è, poiché non è in sé, non sarà necessariamente in Altro?».
- «Senz’altro».
- «L’Uno dunque, in quanto tutto, è in Altro, ma in quanto è la totalità delle parti, è in sé. Così l’Uno è necessariamente in sé e in Altro».
- «È necessario».
«Il figlio minore, il figliol prodigo, è quell’Altro a causa del quale l’Essere non è più in sé – pensava Lui –; non è più in sé per il dolore di averlo perduto… all’immobilità sedentaria del figlio maggiore si oppone la mobilità nomade del figlio minore». E pensava ancora al Parmenide, laddove si legge che l’Uno dovrà necessariamente sia muoversi sia restare immobile. «È immobile se è in se stesso. Essendo nell’Uno e non muovendosi da questo, sarà sempre nello stesso, cioè in se stesso». Il giusto è, agli occhi dell’Essere, colui che non si muove mai… avrebbe voluto aggiungere: da casa; il giusto è chi non si muove mai da casa, chi non mette mai piede fuori dall’Essere. Che noia!
Chi è, l’anima in pena? Chi esce dallo Spirito Santo dell’«essere nella Casa del Padre». Non è nello spirito ontologico, uscire dall’Essere. I bimbi buoni se ne stanno sotto spirito, sotto la formalina del liquido amniotico dell’Essere, senza nessun “parto” che li metta al mondo. L’anima in pena è quella che esce dal grembo dello Spirito. Se volessimo tradurre in linguaggio corrente il senso più riposto del peccato originale, dovremmo probabilmente dire che il primo uomo esistente fu colpevole di aver voluto andare a vivere “da solo”, come si dice, colpevole di aver voluto lasciare la Casa del Padre per andare a fare il single, o magari anche per sposarsi e mettere su famiglia. Ma, in Genesi 2,24 il Creatore, dopo aver creato la donna, disse: «l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne»; questo “lasciare” padre e madre sembrava avere la sua benedizione. Come mai, allora, l’uomo e la donna furono maledetti, quando decisero di lasciare il Padre? Se non è bene che l’uomo sia solo, perché è male che l’uomo vada a vivere da solo?
«Dio-Padre benedice solo i “figli di papà”: i bamboccioni che vivono con i genitori per sempre – pensava Lui –: timor di Dio è paura di andare a vivere da soli? Dio-Padre ama gli immaturi? Ama le mele che non cadono mai? Bella roba! Come fa, un genitore, ad educare i propri figli, se deve avere come modello i veri figli di Dio? I buoni figlioli, quelli non ripudiati, quelli che stanno sempre sotto la gonna del Padre…». Gli sembrava quasi blasfemo, parlare di “gonna del Padre”, perché, se è maschio, Dio non dovrebbe portare la gonna. Ma poi si ricordò che Dio, in quanto Essere, è bisex: fuori del tempo e dello spazio la moda impone un’uniforme “transessuale” che ci si può figurare come una specie di «gonna-pantalone» ontologica.
L’Unum sistens è ontologicamente identico a sé, l’Unum exsistens è esistenzialmente diverso da sé. «Se dunque l’Uno rispetto a se stesso non è né diverso, né tutto, né una parte, non deve necessariamente essere identico a se stesso?». L’Esistere comporta la perdita dell’identità ontologica dell’Essere. Il figlio minore, decidendo di esistere, costringe il Padre a fare testamento prima del tempo, cioè a fare le parti, a dividere in parti le proprie sostanze: una parte ontologica per il figlio maggiore e una parte esistenziale per il figlio minore. L’infinito ontologico diventa una Totalità esistenziale. L’Essere deve fare il contabile e mettersi a contare in quante parti è giusto suddividere se stesso per non far torto a nessuno dei suoi due figli. È così che l’Anima si divide dallo Spirito e va a morire nell’interland dell’Essere, nei quartieri più periferici, malfamati e fuori mano, che si trovano fuori della Casa del Padre: va a conoscere delle realtà problematiche.
- «Dunque, tutte le realtà che non sono Uno, sono diverse dall’Uno e l’Uno è diverso da tutte le realtà che non sono Uno?».
- «Come no!».
- «Quindi, l’Uno sarà diverso dagli Altri».
- «Diverso».
- «Ora osserva: l’identico e il diverso in sé non sono contrari tra loro?».
- «Come no!».
- «Potrà quindi mai l’identico essere nel diverso o il diverso nell’identico?».
- «Non lo potrà».
Il figlio minore è borderline: vive al margine dell’Essere, ai bordi dell’Uno: è emarginato, si è autoemarginato nella diversità difforme e deforme della differenza dall’Essere e per ciò è diventato “contrario” al Padre; non le vede più come Lui, le cose, perché si è messo in un altro punto di osservazione: quello che è fuori dall’Essere, il punto di vista che si ha quando si esiste.
Vedere le cose in modo diverso causa il non andare d’accordo. Però, basta poco, per vedere le cose in modo diverso: basta spostarsi di poco, di un solo passo, e già tutto sembra diverso. O potenza del viaggiare. Peccato che viaggiare sia errare, peregrinare nell’errore, peccato! «È tutto peccato, ciò che è peccato? – pensava Lui –: se tutte le volte che si dice “peccato!” si commettesse peccato, sarebbe veramente un peccato». Come sempre, quando voleva sdrammatizzare, errava tra i divertimenti linguistici dei giochi di parole, i diversivi che preferiva: divertimento viene da diverto, che, come s’è visto, in latino è «separarsi da» come «essere diverso da»: era un peccatore nato, Lui, con la sua vocazione al divertimento.
Ogni divertimento è un divorzio dall’Essere. Diverto si dice anche divorto, e il divortium è appunto la separazione, più o meno consensuale; il Padre non acconsente, ma il figlio minore se ne va lo stesso: il divorzio originale non fu consensuale. E infatti la separazione dei beni non era stata prevista, non era stata messa in conto, come si dice. Se l’identico e il diverso in sé sono contrari tra loro
- «Potrà quindi mai l’identico essere nel diverso o il diverso nell’identico?».
- «Non lo potrà».
- «Se allora il diverso non sarà mai nell’identico, non c’è nessun ente nel quale il diverso possa stare per qualche tempo. Infatti, qualunque sia il tempo in cui si trova in qualcosa, per quel tempo il diverso sarebbe nell’identico. Non è così?».
- «È così».
- «Poiché quindi il diverso non è mai nell’identico, non sarà mai in qualcuno degli enti».
- «Vero».
- «Quindi il diverso non sarà né in ciò che non è Uno, né nell’Uno».
- «No, infatti».
- «Quindi l’Uno non differirà da ciò che non è Uno a causa del diverso, né il Non uno differirà dall’Uno».
- «No, infatti».
- «Né saranno recoprocamente diversi per se stessi, visto che non partecipano del diverso».
- «Come potrebbero, infatti?».
- «Se non differiscono né per se stessi, né per il diverso, non si sottraggono forse del tutto a qualsiasi differenza reciproca?».
- «Si sottraggono».
- «Ma ciò che non è Uno non partecipa nemmeno dell’Uno; infatti non sarebbe più Non uno, ma in qualche modo sarebbe Uno».
- «Vero».
- «Allora, il Non uno non sarà nemmeno numero, perché, se avesse numero, non sarebbe più del tutto Non uno».
- «No, infatti».
- «E dunque? Le cose che non sono Uno sono forse parti dell’Uno? Se fosse così, non parteciperebbero forse dell’Uno?».
- «Parteciperebbero».
- «Se dunque prendiamo i due termini, l’Uno e il Non uno, in senso assoluto, l’Uno non sarà né parte delle cose che non sono Uno, né un tutto di cui quelle sono parti; a loro volta anche le cose che non sono Uno non saranno né parti dell’Uno né un tutto di cui l’Uno è parte».
- «No, infatti».
- «Ma abbiamo detto che le realtà che non sono in relazione né in quanto parti, né in quanto tutto, né in quanto diverse, sono identiche tra loro».
- «Infatti, l’abbiamo detto».
- «Dobbiamo dunque dire che anche l’Uno, che si trova in tale relazione con le cose che non sono Uno, è identico a queste?».
- «Dobbiamo dirlo».
- «L’Uno dunque, a quel che sembra, è sia diverso dagli Altri e da se stesso, sia identico agli Altri e a se stesso».
- «Appare una conclusione probabile sulla base del ragionamento svolto».
«Il Non uno è la necessità aporetica dell’Uno – pensava Lui –, necessità aporetica come necessità esistenziale. Il Non uno è il sacrificio dell’Uno, che sacrifica il suo Essere immolandolo sull’altare della diversità, altare al quale officia l’Altro, il celebrante della Messa Nera». Solo come numero, 1 può esistere come non-Uno, ma Uno non può essere 1. Il 2 nasce dall’Uno, non dall’1: l’1 che precede il 2 nella genealogia esistenziale non è l’Uno che dà inizio, è l’1 che inizia. Se solo l’Uno fosse, l’1 non potrebbe mai esistere; l’1 è creato dall’Uno che comincia ad esistere, dopodiché nasce il 2: in questo senso, è necessario che l’Uno si sacrifichi, affinchè l’1, poi il 2, e poi ancora tutti gli Altri, numeri, possano esistere. In questo senso, la quantificazione enumerabile dell’Uno è sacra, perché è frutto del suo sacrificio. L’Essere che esiste è il suo essere numerabile, computabile, calcolabile.
La ratio, la ragione, in latino esprime bene il concetto che solo un Essere rateizzabile è un essere raziocinabile: la “razione” è ogni singola parte dell’Essere pensabile con il raziocinio dell’essere umano che esiste. Se non lo “fa a pezzi” rateizzandolo in rate esistenziali, l’essere umano non può farsi una ragione, dell’Essere; il quale ultimo si lascia razionalizzare sacrificando il suo Essere Uno in sé indivisibile: individuo. Quando il figlio minore chiede la “sua” parte di eredità, chiede al Padre il sacrificio della propria razionabilità in razioni di esistenza, in porzioni di vita biologica: ragionare è razionare. La Vita ontologica si sacrifica ramificandosi nell’Albero genealogico delle varie vite biologiche. L’Essere si fa dividuo per permettere all’individuo di esistere, cioè di nascere. «Certo – pensava Lui –, per capire queste cose, occorre sapere che in latino dividuum significa divisibile, e quindi individuum vuol dire indivisibile».
È inutile che Platone si scervelli e faccia scervellare il suo lettore giocando il gioco delle due carte, di un Uno ontologico che non potà mai diventare 1 e di un uno esistenziale che diventa 1 facendo nascere tutti gli altri numeri, cioè “dando i numeri”: il numero 1 è certo un Non-Uno, se lo si pensa in modo ontologico; peccato che il numero 1 non possa essere, ontologicamente, Uno. Peccato! Caro Platone, l’1 è dissimile dall’Uno ontologicamente, ma gli è simile esistenzialmente: è fatto a sua immagine e somiglianza, non è generato da Lui, ma creato. L’«Uno ontologico» è l’identico che diventa diverso nell’«1 esistenziale» e in tutti gli innumerevoli numeri che si formano addizionando l’unità ad ognuno di essi, a cominciare all’1.
A Lui piaceva esprimersi con proprietà, come si dice, con correttezza, anche perché pensava che gran parte degli equivoci nascono da un modo scorretto di esprimersi; quindi, colse l’occasione per riflettere sulla differenza intercorrente tra «innumerevole» e «innumerabile».
- Innumerevole: che è in numero così grande che non si riesce a contare.
- Innumerabile: che non si può definire numericamente
L’«Uno» è innumerabile in sé ed è innumerevole per sé. «In sé» è unum sistens. «Per sé» è unum exsistens. Una moltitudine innumerevole è pur sempre numerabile, di per sé; invece, l’innumerabile non è enumerabile, in sé, non è quantificabile. Per rispondere a Platone, si deve dire che l’identico, innumerabile, è nel diverso, innumerevole. Il diverso non è Uno perché è 1. L’identico non è 1 perché è Uno. Quanto alla «partecipazione»
- il diverso partecipa dell’Uno nel senso che ogni numero della sua innumerevole moltitudine è il prodotto della sommatoria di tot unità, ognuna delle quali ex uno sistit.
- l’identico partecipa solo di se stesso in quanto Uno che siste e comunica con l’Altro-da-sé partecipandogli il suo stesso essere Uno che esiste. L’Uno ex se sistit, cioè siste partecipando di se stesso, vale a dire non esiste.
Si impone qui un distinguo tra partecipazione e comunicazione: l’esistente partecipa con l’Essere, il quale comunica con l’esistente affinché questi possa partecipare di Lui. L’1 è simile all’Uno ontologicamente ma ne è dissimile esistenzialmente. «In quanto affetto dall’identico, non è affetto dall’alterità, in quanto non affetto dall’alterità non è dissimile, in quanto non dissimile è simile. In quanto invece è affetto dall’alterità, è altro, e in quanto altro è dissimile». L’affezione è l’aggettivazione che attribuisce in quanto ad ficit: affigge a una cosa qualcosa. La categoria della PASSIO è tale come «essere affetto da qualcosa». L’Essere è solo affetto dall’identità, ma l’adficio identitatis non è una vera e propria affezione: l’Essere è affetto dal suo essere Uno, ma siccome l’essere Uno è qualità sua propria, esso non riceve tale affezione esternamente. In senso proprio, va definita affezione solo quella che proviene da fuori, da Altro; per cui, solo l’Altro da sé può veramente dirsi affetto dal sé in sé: la molteplicità innumerevole è tale in quanto è unum exsistens affetto dalla diversità rispetto all’unum sistens. In poche parole, solo ciò che è diverso può propriamente dirsi affetto da tale diversità e quindi aggettivabile con attributi accidentalmente a lui attribuibili.
- Adfectio diversitatis
- Fictio identitatis
Solo per finta, l’identità è affetta dal proprio essere identica. Propriamente, quindi, Non-Uno è solamente l’1 quantificabile come unità all’interno di una serie di numeri. La quantificazione dell’Essere è il peccato commesso dal figliol prodigo, perché l’Essere, sottoponendosi al sacrificio della quantificazione, si dispone ad occupare un posto nello spazio e nell tempo:
- «Così l’Uno sarà a contatto sia con sé, sia con gli Altri».
- «A contatto».
- «Ma da quest’altro punto di vista? Tutto ciò che deve essere a contatto con un oggetto non è necessario forse che si trovi immediatamente vicino a quello che deve toccare, occupando il posto che è dopo quello in cui è l’oggetto che tocca?».
- «Necessario».
- «Anche l’Uno allora, se deve avere un contatto con se stesso, deve trovarsi subito dopo se stesso, deve occupare lo spazio vicino a quello in cui esso è».
- «Infatti, deve essere così».
- «Dunque, l’Uno dovrebbe essere due per fare questo e per trovarsi in due posti nello stesso tempo. Ma finché sarà Uno, come potrà farlo?».
Affinché possa esserci «contatto», è necessario che ci siano almeno due oggetti: quando l’Essere si fa in due (per non dire “in quattro”) è allora che si crea un contatto, ἡ ἅψις, sostantivazione del verbo ἅπτω: attaccare, adficere. Le stesse sinapsi sono con-nessioni, nessi connessi tra loro, e, in neurofisiologia, il punto di contatto funzionale fra due cellule nervose. «Se quindi c’è solo l’Uno, se non c’è il due, non ci potrà essere contatto».
Perché ci sia un contatto bisogna che l’Essere cominci a fare i conti con se stesso, facendosi innumerevole nella molteplicità dell’esistente: l’innumerevole è l’innumerabile che esiste. Lui diceva sempre: «Se vogliamo farci una ragione dell’innumerabile dobbiamo iniziare a contare: 1, 2, 3, 4, 5… e quando, stanchi, smettiamo di contare perché intuiamo che non esiste un numero capace di concludere la conta, è allora che abbiamo l’intuizione dell’Uno innumerabile. La serie infinita di numeri che solo virtualmente compongono il Tutto al di qua, è simbolo dell’infinità che realmente costituisce il Tutto al di là». E gli pareva, con quei due avverbi, virtualmente e realmente, di aver dato ragione dell’impossibilità olistica che una somma di parti possa andare a costituire un risultato producente il Tutto infinito dell’unum sistens. L’unum sistens non è ontologicamente costituito da parti, quindi la sua quantificazione esistenziale non darà mai ragione del suo essere una Totalità in senso ontologico. Come dire che il Creatore non darà mai ragione alla creatura che lo vuole quantificare esistenzialmente, non gli darà mai la soddisfazione di lasciarsi contare nella rateizzazione razionale che lo fa a pezzi, che lo sminuzza per poterlo capire.
Essere e non-Essere si scambiano continuamente i ruoli nel cangiante e caleidoscopico tourbillon che, come l’energia elettrica, trapassa senza posa dal polo positivo al polo negativo. La metafora della corrente elettrica rende bene l’idea di trapasso continuo dall’«Uno che è (= siste)» all’«uno che esiste»: la stessa parola «corrente» indica un correre della corrente continua, nel moto ordinato delle cariche elettriche; la corrente elettrica ha un verso di percorrenza, anche se non ha una direzione: è una quantità scalare. Se si pensa poi che «intensità di corrente elettrica» è il rapporto tra la quantità di carica elettrica Q che passa attraverso una sezione unitaria del circuito, e l’intervallo di tempo Δt in cui questo passaggio avviene, si capisce bene che è esattamente il tempo, a determinare il passaggio, il trapasso dall’unum sistens all’unum exsistens.
Tornando poi al «contatto» di cui sopra, ἡ ἅψις, e pensando ad un «contatto elettrico», che sta alla base del concetto di «interruttore», si può ben immaginare lo sforzo platonico di coniugare la diairesi esistenziale con la sineresi ontologica in uno sguardo sinottico che sappia comprendere entrambe. Hegel demandò al concetto, la virtù in grado di compiere il prodigio di tale sinossi. Il pensiero è discorsivo: per funzionare ha bisogno di correre senza posa da un capo all’altro dei suoi due poli dialettici, Bianco e Nero, Bene e Male: ogni fermata che cerchi di immortalare staticamente una tappa qualsiasi di questa corrente discorsiva, fotografa qualcosa di cui non ci si può dar ragione, perché la ragione non “sta” in nessuna delle due parti: nessuna delle due parti “ha” ragione, per così dire. Ogni fotografia che voglia cercare di immortalare la realtà è per forza di cose una fotografia “mossa”, dacché la realtà non è ferma, e nemmeno ci fa il favore di mettersi in posa per la nostra foto. Per evitare di fotografare lo spettro del non-Essere bisogna rassegnarsi a non cercare di fotografare l’Essere nel suo Esistere e nemmeno l’Esistere nel suo Essere: nel movimento da un capo all’altro, Essere ed Esistere producono la corrente discorsiva del pensiero, non nella fermata vivisezionante che ne vorrebbe analizzare anatomicamente una parte staccata dall’altra. Nel movimento da un capo all’altro dei due estremi c’è tutta la varietà di colori che permette di colorare il reale: la realtà è tra quel Bianco e quel Nero che Adamo ed Eva scelsero di carpire.
- «Dunque, l’Uno partecipa anche del tempo, ed è diviene più giovane e più vecchio di sé e degli Altri, e inoltre, pur partecipando del tempo, non è né diviene né più giovane né più vecchio di sé e degli Altri?».
- «Come dici?».
- «In qualche modo gli appartiene l’Essere, se l’uno è».
- «Sì».
- «Cos’altro indica “è” se non il partecipare all’Essere nel tempo presente, così come “era” indica la partecipazione nel tempo passato e “sarà” all’Essre nel futuro?».
- «È così infatti».
- «Dunque, l’Uno è partecipe del tempo se partecipa anche dell’Essere».
Lui pensava che sarebbe bastato sostituire all’ultimo verbo, Essere, il verbo Esistere, e tutto sarebbe diventato chiaro: «è l’Esistere che è nel tempo, non l’Essere! – pensava Lui –, è l’ens existens che partecipa del tempo e dello spazio». Così, insensibilmente, l’Unum exsistens divenne sinonimo di ens existens. L’ente è l’«Essere che è,» cioè l’«Essere che esiste». Platone, tutto teso com’era verso l’idealità metafisica, non riuscì a coniare un verbo capace di distinguere tra Essere delle Idee ed Esistere delle Cose? Possibile? Lui ripensò allo scritto E-sistere, di Davide Cantino, e ricordò che
Il greco, prima ancora del latino, aveva anche lui due verbi del tipo
- ἵστημι = far stare, essere stabilito
- ἐξίστημι = spostare, mettere fuori di sé
I dizionari di greco rilevano che ἵστημι è l’antenato del sisto latino. Insomma, l’e-sistere esce fuori da un -sistere.
Non poteva, Platone, usare il verbo ἐξίστημι per significare l’esistere? Il sintagma ἐξ + ἵστημι rende benissimo il latino ex + sisto! Ma niente da fare, piuttosto ci si scervella sul gioco degli equivoci derivante dallo scambio improprio dei due verbi.
Considerando la partecipazione dell’Esistere al Tempo, Platone fece la tradizionale scansione
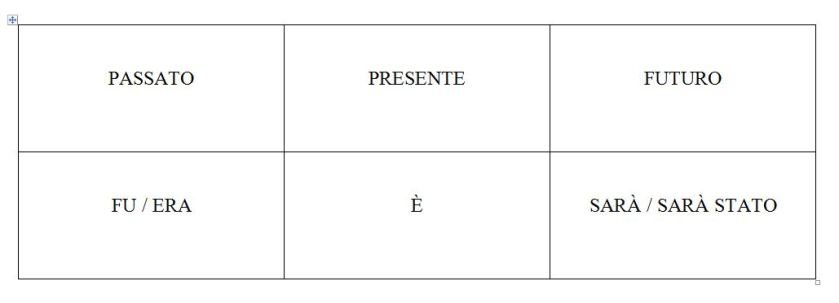
alla ricerca di un istante in cui l’Essere, esistente, si metta in posa per poter essere immortalato fuori del tempo e dello spazio: ancora una volta Platone mischia e confonde (chissà quanto inconsciamente) i due piani, quello ontologico e quello logico, cioè esistenziale. «Ciò che scorre è tale da avere un contatto con entrambi, con il presente e con il futuro in quanto lo coglie, e diviene in mezzo ad entrambi, tra il futuro e il presente». Eccolo, il mezzo, μεταξύ, vecchia conoscenza platonica, che sta per intervallo frapposto tra Passato e Futuro: è l’istante, quell’«improvvisamente», ἐξαίφνης, che coglie l’attimo e lo ferma in un improbabile standby capace di consentire la messa a fuoco del carpe diem. «Se di necessità tutto ciò che diviene non può evitare il presente, quando poi vi si trova cessa sempre di divenire ed in quel momento è ciò che gli è accaduto di divenire».
«No, si sbaglia Platone – pensava Lui –, il divenire non dà tregua, il tempo non si ferma mai: è solo nel nostro ricordo che lo scorrere del tempo sembra fermarsi per consegnarci l’istantanea dell’istante». Gli piaceva chiamarla così: l’istantanea scattata dall’istante, come se il pensiero potesse fare un flash per immortalare un flash-back oppure un flash-forward. «Ora, il presente è sempre con l’Uno per tutto il tempo del suo essere: infatti l’Uno, ogni qual volta è, sempre nel presente è». Platone continua ad usare indifferentemente i verbi Essere ed Esistere – pensava Lui –, perché non proviamo a dire, piuttosto, che “il presente è sempre con l’unum sistens, per tutto il tempo del suo essere: infatti l’unum sistens, ogni qual volta è, sempre nel presente è “ (?)». È infatti solo nell’atemporalità e nell’aspazialità ontologica che l’Essere è sempre presente: non essendoci né passato né futuro, Lui è sempre presente a se stesso nello stesso tempo (che non c’è): actualitas perfetta.
La desistenza… Quale falla nel sistema ontologico permetterà mai di evadere? La falla dell’«istante»? Istante. Instans: in + stans = che sta in. Insto, as, stiti, staturus, stare: stare sopra, essere sospeso sopra, sovrastare, insistere. Tempus instans: tempo presente. L’Unum exsistens diviene, γίγνεται.
- «E il cogliere l’Essere non lo chiami nascere?».
- «Io sì».
- «E l’abbandonare l’Essere non lo chiami perire?».
- «Senza dubbio».
- «L’Uno dunque, a quel che sembra, prendendo e abbandonando l’Essere nasce e perisce».
- «Necessariamente».
- «Poiché è uno e molti e poiché nasce e perisce, non è forse che quando nasce l’Uno perisce l’essere molti, quando nascono i molti perisce l’Uno?».
- «Certamente».
- «Ma il divenire uno e molti non implica necessariamente il dividersi e l’unificarsi?».
- «Di certo!».
Lui aveva coniato due termini, per significare l’Essere Uno dell’Uno e l’Essere Molti dell’Uno:
- mono-sistenza: unum sistens
- poli-sistenza: unum exsistens
I due verbi, poi, che Platone usa per significare il dividersi dell’unum sistens nella polisistenza e l’unificarsi dell’unums exsistens nella monosistenza sono:
- διακρίνω → ἡ διάκρισις
- συγκρίνω → ἡ σύγκρισις
«La monosistenza, per il cristianismo, è in realtà trisistenza – pensava Lui –, la trisistenza diventa polisistenza scomponendosi e ridiventa trisistenza ricomponendosi».
scomposizione → composizione → scomposizione → ricomposizione
La concettualizzazione della composizione ricompone le parti scomposte della monosistenza nella parti «di una certa Idea (ἰδέας) e di un certo Uno (ἑνός) che chiamiamo tutto (ὅλον), che raggiunge la sua perfezione (τέλειον) come unità di tutti; di questo la parte sarà parte».
Ciasc-una parte è una, un «uno» di «Molti». «Ma è evidente che, per partecipare all’Uno, dev’essere altro dall’Uno; in caso contrario non parteciperebbe all’Uno, ma sarebbe lo stesso Uno. Ora, a eccezione dell’Uno in sé, è impossibile a qualsiasi realtà essere Uno». A Lui venivano in mente il plèroma e il kènoma:
- τὸ πλήρωμα il pieno
- τὸ κένωμα il vuoto
Colossesi 2,9-10: «È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza.», ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter: et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis.
- ἡ ἀρχή principatus
- ἡ ἐξουσία potestas
È veramente curioso, quel sostantivo, ἡ ἐξουσία, perché sembra suggerire che «il potere» viene dall’Essere: ἔξειμι, «uscire, entrare in scena», ἐξ + εἶμι = potestas? Il Cristo viene definito da san Paolo, letteralmente, «il capo di ogni principio e possibilità»: il confine tra principio e principe è sottile; questo pleroma cristico è la polisistenza ricomposta nell’Uno esistenziale, cioè somatico. Il principe è tale perché da lui tutto principia? L’aggettivo «arcaico» viene da ἡ ἀρχή a dire che l’anzianità del principio conferisce la potestà del potere che deriva «dall’Essere»: ἐξ οὐσία. Nel concetto di Essere è insito quello di «inizio del potere», principatus potestatis, da che
- principatus, us (maschile): inizio, supremazia.
- potestas, atis (femminile): potenza, sovranità.
Dio-Figlio è la Totalità dell’Esistere e Dio-Padre è la Totalità dell’Essere: il primo riceve il potere dall’Essere di cui è Figlio. Matteo 28-18: Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra», Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra.
Matteo 11,27: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio», Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Nel concetto di trado, is, tradidi, traditum, ere c’è quello di consegna, di investitura ontologica: il Padre è ἡ οὐσία e il Figlio è ἡ ἐξουσία: Dio da Dio, Deum de Deo, θεὸν εκ θεοῦ. Il Padre è ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς (factorem coeli et terrae) e il Figlio è δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο (per quem omnia facta sunt): il Figlio è la Potenza per mezzo della quale Tutto diventa Atto.
- Pater: ἡ οὐσία
- Filius: ἡ ἐξουσία
Lui ce l’aveva con il Totalitarismo. Il fatto che in greco il «potere» derivi dall’Essere così come testimonia ἡ ἐξουσία è la prova che l’Essere assoluto è la radice di ogni assolutismo, cioè di ogni dispotismo. Il Padre è l’assoluto ontologico e il Figlio è l’assoluto esistenziale. Certe volte viene da pensare che lo Spirito Santo sia stato messò lì, tra Padre e Figlio, per mitigarne l’aspetto dispotico: «se non ci fosse l’Amore dello Spirito Santo ad unirli, Padre e Figlio sembrerebbero due padroni che si spartiscono l’Essere e l’Esistere – pensava Lui –, un po’ come il gatto e la volpe». Per dirla con Platone, la Santissima Trinità è “una certa Idea” di “un certo Uno” che chiamiamo Tutto: τὸ ὅλον, qui nos salvos facit. Il cattolicesimo, cattoplatonico, è olismo ontologico ed esistenziale insieme, così come insieme sono Padre e Figlio nella Santissima Trinità. Il Padre è unità dell’unum sistens e il Figlio è unità dell’unum exsistens. L’Unità del Padre e del Figlio è quello Spirito Santo che è Unità di sistente ed esistente: il Padre unifica l’Essere, il Figlio unifica l’Esistere e lo Spirito unifica Padre e Figlio, cioè Essere ed Esistere.
Platone dice che «è impossibile a qualsiasi realtà essere Uno» perché è nato e vissuto prima di Cristo: «dopo Cristo, il Cristo stesso è l’Uno della realtà esistente – pensava Lui –: la rivelazione cristiana risolve il problema dell’olismo esistenziale inventandosi una ἐξουσία che, come sta scritto in Efesini 1,10, «ha il potere di ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra»; la ἐξουσία è, come da Efesini 1,23, «la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose», τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου, plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur.
Omnia in omnibus. Così l’Uno diventa 1 e ritorna ad essere Uno: la scomposizione dell’Uno nelle innumerevoli unità si ricompone, per mezzo del Figlio, nella ritrovata unità di un solo, innumerabile Padre. Il Padre è il gerarca ontologico e il Figlio è il gerarca esistenziale. Gerarca: ὁ ἱεράρχης = ἱερός + ἄρχω. In greco ὁ ἱεράρχης è «chi presiede una sfera sacra»; è inquietante, la compresenza, nella realtà linguistica del ἱεράρχης di un potere, ἀρχή, sacro, ἱερός. Sarebbe più bello pensare una derivazione etimologica che riconduca il gerarca a γεραιός, all’anziano, sì da poter pensare a un potere che viene da τὸ γέρας, il segno onorifico. Nonostante Lui si trovasse adesso davanti al reparto di geriatria, non c’era verso di riuscire a leggere sulle facce di quegli anziani una benché minima traccia di gerarchia: un anziano è anziano, non è sacro…. ἱερός non è γεραιός.
Un gran desiderio di nonessere lo prendeva, quando pensava che l’Essere è quell’orribile potere assoluto che non ti molla mai, che ti circuisce in tutti i modi spacciandosi per amore, e che ti ama al punto da minacciarti di morte eterna se non lo riami come Lui ti ama. «Invece di perderle, le persone che non Lo amano, farebbe meglio a lasciarle perdere – pensava Lui –: è sostanziale, la differenza che c’è tra perdere e lasciar perdere; se veramente Dio fosse superiore, lascerebbe perdere chi non lo ama, chi non ama essere, e non ci penserebbe nemmeno, a vendicarsi». I cristiani, a uno che non ama esistere, dicono che essere non è esistere: che se uno provasse ad essere, sarebbe contentissimo di esistere per poter finire in quell’essere. «Ma perché bisogna prima esistere e dopo essere? – pensava Lui –, perché bisogna passare per la fine, per poter arrivare all’inizio?».
Il Parmenide di Platone, quasi alla fine, si pone una domanda che Lui non riusciva a togliersi dalla testa: «se l’Uno non è, niente è?», ἕν εἰ μὴ ἔστιν οὐδέν ἐστιν.
- «Diciamo dunque questo ed aggiungiamo che, a quel che sembra, tanto se l’Uno è quanto se l’Uno non è, sia l’Uno sia gli Altri, da tutti i punti di vista, sono e non sono, appaiono e non appaiono, e in rapporto a sé medesimi, e nel rapporto reciproco tra loro».
- «Verissimo».
«Se l’Uno non si può eliminare – pensava Lui – almeno eliminiamo i Molti Altri che da lui derivano. Delle due, l’una: o disinneschiamo l’Esistere o disinneschiamo l’Essere; l’Essere non possiamo disinnescarlo, e allora disinneschiamo l’Esistere. O santa desistenza, consolatrice degli esistenti!». Tutti i mali vanno sradicati alla radice, sennò non si estirpano: l’Esistenza è una mala pianta, e va estirpata alla radice, per evitare che le sue metastasi ramifichino – come hanno fatto, dal fallo originale in poi –, nelle atroci sofferenze di cui ogni vitalgia è sintomo. L’Uno deve sparire dalla faccia dell’universo, ontologico ed esistenziale. Non è morendo, che uno si sottrae al dominio dell’Uno. Se uno viene al mondo, il suo nonessere potrà solo più essere un non-essere:
- «Allora, l’Uno, per non essere, deve avere, come legame al Non essere, l’essere del Non essere, così come ciò che è, per essere compiutamente, deve avere il non essere del Non essere. Così ciò che è sarà in modo pieno e ciò che non è non sarà; ciò che è, se deve compiutamente essere, partecipa all’essere dell’Essere che è, e al non essere dell’Essere che non è; ciò che non è, se anch’esso deve compiutamente non essere, partecipa al non essere del Non essere che non è, e all’essere dell’Essere che non è».
- «Verissimo».
Questo è uno dei momenti più “visionari” di tutta la storia del pensiero umano: sublime! Ma limitato… pensava Lui: così non ci si libera dell’Essere… le 4 possibilità platoniche sono:

L’unica possibilità che potrebbe salvarci dall’Essere, la seconda possibilità, il non essere dell’«Essere», è impossibile, perché l’Essere non può non essere. Ed anche la possibilità equivalente alla seconda, la terza, l’ essere del «Non Essere», è la controprova dell’impossibilità della seconda, per via della contraddizione in termini che contiene, dal momento che si parla di un «Non Essere» che è (!?).
Quanto alla prima e alla quarta possibilità, esse sono il trionfo dell’Essere nelle sue due forme: l’Essere che è e il Non Essere che non è. Dal che si evince che il sistema platonico, come quello cristiano, è completamente assoggettato dall’Essere, è completamente schiavo del totalitarismo ontologico, cioè succube della dittatura dell’Essere. Non c’è niente da fare: se si resta nel sistema cattoplatonico, dall’Essere non se ne uscirà mai.
Se da una parte, all’Essere, per essere, non è necessario il non essere del Non Essere, dall’altra parte, al Non Essere, per non essere, è necessario l’essere del Non Essere. Quindi, in teoria, l’essere è necessario e il non essere non è necessario; ma il discorso non finisce qui: essere e non essere sono scritti in corsivo per significare la loro funzione logica, non ontologica, né tantomeno esistenziale, quindi, in pratica…
Il sistema cattoplatonico non riesce a concepire il Nonessere perché pensa il Non Essere sub specie entis, cioè con la categoria ontologica dello stesso Essere. Il Nonessere non è il prodotto di un’operazione che sottrae l’essere all’Essere, come se si potesse prosciugare l’Essere del suo stesso essere fino ad azzerarne la consistenza ontologica nel risultato finale dell’annichilimento. Non è con l’operazione logica del verbo essere che si può ridurre al Nulla, o al Niente, se si preferisce, l’Essere. L’operazione logica è opera del pensiero umano, e la speculazione cattoplatonica ha dimostrato ampiamente che il pensiero umano non è in grado di pensare il Nonessere finché cerca di ottenerlo col pensiero logico: il pensiero logico è fatto “ad immagine e somiglianza” dell’Essere, vale a dire, il pensiero ontologico è la matrice, lo stampo, il cliché del pensiero logico.
Se qualche parroco avesse accettato la sua proposta di fare un catechismo filosofico e non solo teologico, Lui avrebbe dimostrato così l’esistenza di Dio: dicendo che il fatto stesso che la creatura umana sappia pensare unicamente secondo la categoria ontologica, dimostra che è stato il Creatore, a creare il pensiero umano: se il Creatore è, ontologicamente, l’Essere, logicamente il pensiero della sua creatura non poteva evadere per nulla da questa categoria di pensiero; e la prova sta nel fatto che, appunto, logicamente, il pensiero umano non può concepire il Nonessere, ma solo il non-essere del Non Essere. Se il Creatore, ontologicamente, è, allora la sua creatura, logicamente è, laddove quest’ultimo «è» sta per «pensa». Lui era convinto che questo fosse il senso del parmenideo
τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι
«infatti, lo stesso pensare è anche essere»: sì – pensava Lui –, ma solo logicamente. La desistenza può ambire al Nonessere perché non lo lambisce per via logica. Nel sistema logico del pensiero umano non c’è spazio per il Nonessere, perché è un sistema ontologico, quello del pensiero umano. Solo virtualmente il pensiero onto-logico ambisce il Nonessere, in realtà lo lambisce perifericamente, marginalmente, in modo non essenziale, perché la sua sostanza è ontologica; l’essenza del pensiero logico è la sostanza ontologica dell’Essere.
Lui pensava che ci fossero tre modi, di “essere”: essere, essere, essere. L’essere del pensiero logico è quello che serve a pensare l’essere, il quale ultimo è l’essere ontologico: il pensiero logico può pensare l’essere ontologico, cioè un essere divino, e non può pensarne il non essere: il pensiero logico è “fatto” in modo tale da non poter agire al di fuori del pensiero ontologico e quindi il Nonessere gli è precluso. Ma, c’è un modo d’essere che è impensabile, che non può essere pensato logicamente, e questo è l’essere esistenziale, il quale è conditio sine qua non del pensiero logico e quindi anche del pensiero ontologico.
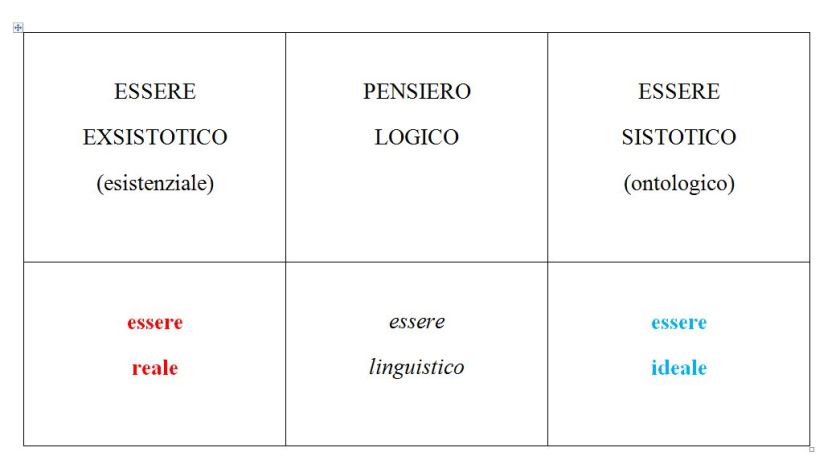
L’essere reale, cioè il vivere di un essere umano esistente, è la possibilità del suo stesso pensiero logico. Tornando alla parola «equivoco» nel suo significato etimologicamente genuino che lo vuole vox aequa, una “voce eguale”, si potrebbe dire che l’essere ontologico è l’equivoco del pensiero logico, in quanto lo pensa con la voce del verbo essere. L’equivoco tra essere ontologico ed essere logico si fonda sul pensiero. A rigore, l’essere ontologico non si dovrebbe dire che è ma che è; però solo l’essere ontologico stesso potrebbe di se stesso dire che è. Per cui, nel pensare l’essere ontologico, è giocoforza filtrarlo attraverso la categoria della logica, cioè attraverso lo schema linguistico del verbo essere. Quando il pensiero logico dice, cioè pensa, che l’essere ontologico è, non fa che dare uno spessore ontologico al verbo essere, non fa che dare al verbo essere una consistenza ideale che dà alla funzione logica la concretezza di una sostanza reale, anche se astratta: una sussistenza ideale.
Ricalcando vecchi topoi psichici, potremmo dire che il pensiero logico è l’Ego, che sublima se stesso nel Super-Ego della propria idealità. E potremmo aggiungere che, a dispetto di Freud, tale sublimazione non è sublimazione di pulsioni sessuali, bensì esistenziali: l’Ego sublima l’essere esistenziale, l’essere exsistotico della vita biologica, sì che la vita biologica gli è subliminale.
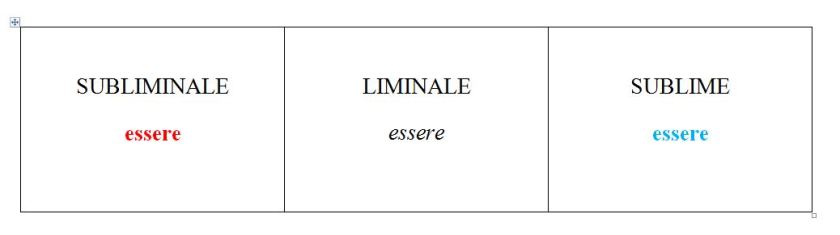
Il limen (neutro, in latino) è il confine logico tra la sublimità dell’iper–logia e la subliminalità dell’ipo–logia: la tipo-logia del pensiero logico è a metà tra l’ipologia dell’essere exsistotico e l’iperlogia dell’essere sistotico. La subliminalità dell’essere existotico si configura quindi in modo analogo a come l’Io è “figura” dell’Es. Come scrisse Umberto Galimberti ne La casa di psiche,
«…l’ “inconscio” è fuori dallo spazio e dal tempo, non rispetta il principio di non contraddizione e quello di causalità, si sottrae alla storia e al principio di individuazione, guarda all’Io come a un effetto secondario della sua forza pulsionale, come a un risultato biologicamente determinato nello sviluppo della storia naturale. Se invece lo sguardo è promosso dall’Io (come in Schopenhauer la rappresentazione è promossa dall’individuo), questi si descrive come istanza suprema della razionalità discorsiva in grado di oggettivare, sul piano della conoscenza, il carattere della natura da cui emerge». [Umberto Galimberti: La casa di psiche / Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica – Feltrinelli, Milano 2005 – pagg. 41-42]
Come ebbe a dire Freud, l’inconscio è «il regno dell’illogico». Lui pensava che l’essere del pensiero logico uscisse dall’essere existotico come un simbolo onirico sale in superficie nel dormiveglia quando affiora dalle profondità dell’inconscio; e pensava che l’essere sistotico altro non fosse che quel simbolo, salito, nella veglia della ragione, alle altezze eccessive del Super-Io logico: il tragitto intercorrente tra pensiero logico e pensiero ontologico altro non era – per Lui –, che l’alter ego del percorso compiuto dall’essere sistotico nella sua ascesa all’ego logico: l’Io è l’alter egologico dell’essere exsistotico, come il Super-Io è l’alter iperegologico dell’essere egologico. La costituzione dell’Ego nella coscienza di sé è alla base della sublimazione verso l’essere ontologico. L’idealità dell’essere ontologico si origina da un’iper coscienza che supera il livello medio del suo Ego coscienziale, cioè logico, spingendosi oltre le sue stesse possibilità. Ma è l’ipo coscienza dell’essere exsistotico a dare inizio alla sublimazione.
Se è l’essere exsistotico a dare inizio, esso è il principio di ogni forma di pensiero: è il creatore ipologico del Creatore iperlogico; il creatore ipologico è alogico, per non dire illogico, a dire che l’origine dell’idea di Creatore nel pensiero umano è fondamentalmente incosciente e deriva dall’arbitrarietà gratuita ed oziosa di un pensiero razionale fondato sull’irrazionalità. Il pensiero logico nasce dall’«e-ducazione» del pensiero ipologico: se èduco è «formare», edùco è «de-formare»: es-trarre, trarre dall’es ipologico la formazione dell’io logico. Lo stesso super-io iperlogico deriva da un’iper «e-ducazione», ma questa volta dell’io. La sublimazione è frutto di una progressiva “educazione” dell’essere umano, ma nel senso di «es-trazione».
Lui riteneva che fosse ora di diseducare il pensiero. Pensava che fosse ora di recuperare il “pensiero maleducato”: diseducare il pensiero fino a farlo sparire in quella dimensione ipologica nella quale esso è impensato ed impensabile, cioè non è. L’umanità, nel corso della sua “educazione del pensiero” non ha fatto altro che coltivare la sublimazione del pensiero verso un grado sempre maggiore di essere, arrivando, com’è noto, all’essere impensabile che è in sommo grado: a forza di farlo salire nel cielo della sublimazione logica, il pensiero ha perso di vista quello stesso essere sul quale volava quando cominciò a non tenere più i piedi per terra. C’è un’impensabilità iperlogica, ma c’è anche un’impensabilità ipologica: è quest’ultima che, adesso, l’essere umano deve recuperare. Il pensiero perde di vista il proprio essere sia quando lo innalza troppo, sia quando lo abbassa troppo; il pensiero ipologico si perde di vista nell’impensabilità della propria vita al di qua e il pensiero iperlogico si perde di vista nell’impensabilità della propria vita al di là. Il pensiero ipologico sparisce nell’inferno, sotto il mondo nel quale pensa di esistere, così come il pensiero iperlogico sparisce nel superno, nell’oltremondo in cui pensa di sistere. A ben vedere, l’essere logico è “invisibile” sia nell’ipologia infera sia nell’iperlogia superna. Lui pensava a eidetismo e aidetismo. Se «Ade» è il regno dell’ἀιδής, dell’«invisibile», cioè il regno in cui sparisce τὸ εἶδος, la forma, e se ἡ εἴδησις, la conoscenza, eidetica per sua natura, è tale in quanto visione di forme mentali nel pensiero, allora l’eidetismo scompare nell’aidetismo quando si spinge troppo sotto o troppo sopra, in quell’Ade nel quale esso stesso pone le anime di coloro “che non sono più”, siano essere inferne o superne.
Quante cose aveva pensato, da quando era entrato in ospedale! Certe volte gli veniva da pensare che, se tutti quei pensieri li avesse messi nero su bianco, ne sarebbe uscito un libro… un libro che si sarebbe potuto intitolare Mal comune… o anche Storia di un mistero gaudioso… un libro che sarebbe cominciato con lo stile basso della letteratura e sarebbe finito con lo stile alto della filosofia… così come cristianamente si conviene: ogni esistere deve finire nell’essere, no? Parlare come un cristiano… pensare come un cristiano… scrivere come un cristiano… I pensieri esistenziali sono quelli con i quali si fa della semplice letteratura… i pensieri ontologici sono quelli con i quali si fa della filosofia… la gente non ama leggere di filosofia, preferisce leggere di letteratura, perché ama il mezzo gaudio, non il mal comune… alla gente piace la cronaca, nera, possibilmente… la cronaca nera sbianchetta il mal comune assumendo un atteggiamento letterario, discorsivo… alla gente piacciono i discorsi infarciti di fatti… non di idee, di pensieri, no: di fatti… fatti di cronaca, possibilmente.
Alla gente piace ciò che esiste, ciò che è nel tempo, come i fatti di cronaca, che sono cronaca proprio perché le cronache, χρονικά (βιβλία), sono neutro plurale di χρονικός, ciò «che riguarda il tempo». La gente preferisce cianciare di ciò che esiste, piuttosto che parlare di ciò che è. Lui era convinto che, se avesse scritto tutti i pensieri che gli erano nati in ospedale, un lettore avrebbe chiuso il libro sempre di più, a mano a mano che procedeva con la lettura, e non perché lo scritto diventasse meno curato con l’andar delle pagine, bensì perché diventava più ontologico con l’andar dei pensieri. Un libro che comincia con la cronaca esistenziale, e, poi, di pagina in pagina, levita sempre più salendo verso la cronaca ontologica, non è un libro che possa allettare Tutti. Già se lo immaginava, il libro, chiudersi sempre più tra le mani di Tutti, e, alla fine, si immaginava anche il lettore, cadere in un sonno profondo grazie al potere ontologico dei pensieri: la veglia è esistenziale, il sonno è ontologico. Alla gente piace vivere, non pensare. Chi pensa, alla fine, perde il gusto per la vita, perché la vita è esistenza e l’esistenza non vuole pensieri, come il fallo di cui parlano i napoletani… O cazze nun vò sapè raggione…
Era giunta l’ora di uscire dall’ospedale. Lui scese giù, al piano terra, e imboccò il grande androne posto all’ingresso. «Chissà in quanti lo sanno, che «androne» viene da ὁ ἀνήρ ἀνδρός «uomo» a significare ὁ ἀνδρών -ῶνος: «appartamento per uomini»? – pensava Lui –, solo in latino diventa «corridoio» come andron -onis. Non è da Tutti, farsi una bella riflessione etimologica nell’androne di un ospedale – pensava –, negli androni Tutti ci passano alla veloce e non stanno certo lì a chiedersi il significato del nome che stanno attraversando». Attraversare un nome gli parve un bel modo di dire, e per questo cercò di prolungarlo, come tutte le cose che piacciono: «ogni bel gioco dura poco? – pensava – , e allora il mio sarà brutto, perché lo farò durare tanto». Detto ciò – anzi, pensato ciò – si fermò, immobile in quell’androne e cominciò a prolungare il più possibile il gioco che dura poco, per vedere di smentire anche questo modo di dire e dimostrare a Tutti che anche un bel gioco può durare tanto.
Conoscete “il gioco dell’androne”? No? consiste nel riflettere il più a lungo possibile sull’etimo della parola uomo, ὁ ἀνήρ ἀνδρός. Un andrologo passò per l’androne. «Nessuno è più al suo posto di un andrologo in un androne – pensò – ma guarda che bell’inizio, il mio gioco comincia proprio sotto buoni auspici». Avrebbe voluto chiedere all’andrologo se conosceva l’etimologia dell’androne che stava attraversando, ma, siccome, come Tutti, anche gli andrologi attraversano gli androni senza pensare al nome di ciò che attraversano, lasciò perdere; anche perché, poi, gli sembrava che andasse di fretta, quell’andrologo, e forse gli interessava solo l’etimo del proprio nome: l’andrologo è il ginecologo dei maschi.
Allora, il gioco dell’androne comincia quando si pensa che ὁ ἀνήρ ἀνδρός è una parola che può c’entrare qualcosa con il «Nero», laddove si resta poi però nel dubbio se si tratti del colore, «nero», oppure di Nero, Neronis: Nerone, il cognome della gens Claudia. Probabilmente il «nero» dell’uomo è quell’ἀνδρεία nella quale Nietzsche credette di ravvisare la melanina che fa dell’uomo nero l’anti-ariano, ma in greco ἡ ἀνδρεία è il coraggio, la virilità, per cui Andrea e Andreina sono la coppia più ariana che c’è, pensava Lui. Melanina, Andreina… ma che bello: chissà quanti Andrea e quante Andreine saranno passate per questo androne senza nemmeno sapere che, come l’andrologo, anche loro, in un androne si trovavano poprio al posto giusto, almeno etimologicamente. Avrebbe voluto condividere con il centralinista questo suo gioco dell’androne, ma gli pareva piuttosto scazzato, per cui lasciò perdere. Era sempre costretto a godersi tutto da solo la bellezza dei suoi giochi. L’antropologia è essenzialmente un discorso diviso in due branche: andrologia e ginecologia.
Dall’androne guardò fuori: era buio. Così, prima ancora di poter mettere piede fuori, un’altra etimologia gli si affacciò alla mente: «chissà perché ‘uomo’ si dice anche ὁ φώς φωτός ? – pensava –, Come la luce ! Che c’entra la luce con l’uomo? In un androne ogni maschio si sente veramente uomo, ma nella luce…». Fu così che mise piede nel buio. Aveva un umor nero, per cui, anche uscito dall’androne, pur essendo nel buio, continuò a sentirsi un uomo vero, a dispetto dell’etimo fosforico suggerito da ὁ φώς φωτός. «Non è vero che solo la melanina è foriera di virilità – avrebbe voluto dire a Nietzsche – anche la melanconia lo è, perché ἡ μελαγχολία è composta da μέλας μέλαινα μέλαν «nero» e ἡ χολή «la bile», propriamente «bile nera», che è il concetto di atrabile: bile nera». E già si sognava le nozze fra Andrea e Melania: fra l’uomo forte e la donna melanconica. Non è Andreina la donna giusta per Andrea, è Melania! – osservava tutto compiaciuto. Melanconia, malinconia, melanina: tutta roba che viene dal color nero, come l’uomo.
Era un temperamento atrabiliare, Lui, su questo non c’era dubbio; ma pochi capivano che Tutti avrebbero dovuto avere un temperamento del genere, perché Tutti erano figli di Eva: gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Eia ergo, ‘orsù dunque’, avrebbe voluto dire a Tutti: siate degni di vostra madre, quella bagascia… ma l’eia della Salve Regina gli si bloccò in gola, anzi, in testa: per carità, fosse mai passato Qualcuno capace di leggere il pensiero, captando quell’eia, avrebbe potuto pensare che Lui era un fascista, un nostalgico dell’eia, eia alalà. «È vero che di comunisti in giro ce n’è ormai pochi – pensava Lui –, ma quelli sentono puzza di fascismo ovunque, e, con la fortuna che ho, sta’ a vedere che becco l’unico comunista di Chivasso che gira di notte per ospedali e mi rendo sospetto senza motivo: con la sfiga che mi ritrovo, potrei anche beccare un comunista nell’androne di un ospedale capace di sentire un eia rivolto alla Madonna e scambiarlo per un eia lanciato ad Ἀλαλά, la dea dell’ἀλαλή, il grido di guerra greco».
Terminate queste cogitazioni, finalmente mise piede fuori. Scelse il piede destro, per iniziare a mettere piede fuori, così, per scaramanzia. I Romani antichi entravano col piede sinistro solo nelle case colpite da sventura. «A rigore, nella vita si dovrebbe sempre entrare col piede sinistro – pensava Lui –, e poi cercare di entrare col piede destro nella morte, caso mai varcando la soglia di quella non si debba per sventura dover entrare nella Casa del Padre con tutt’e due i piedi…». Stava pensando a Marco 9,43-48:
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.
«Il loro verme non muore…». Alla faccia della tenia! Isaia 66,24:
Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini
che si sono ribellati contro di me;
poiché il loro verme non morirà,
il loro fuoco non si spegnerà
e saranno un abominio per tutti.
Ma non aveva un modo più allegro, per chiudere il suo lunghissimo libro, Isaia? L’esegesi cattolica assicura che il verme è il simbolo del rimorso. Tenia nana: Hymenolepis nana, tenia murina, è l’animale che parassita i roditori. Il verme solitario è il rimorso: morde, rimorde…
«Che bello – pensava – passare la vita nei rimorsi, finire in una bara dove i vermi ti mordono e iniziare tutto da capo, per sempre, nel fuoco che non si estingue, dove c’è un verme che non muore mai proprio per poterti rodere in eterno! Potere del cattolicesimo!». Ma andiamo un po’ a vedere come si dice in greco e in latino “la minaccia della tenia” di Marco 9,48: ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται, ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur. Lui s’era sempre sentito un verme solitario: era nato per rodere la buona coscienza altrui; perché era convinto che non fosse buona, la “coscienza nana” del mezzo gaudio: essa nasce in realtà da una cattiva coscienza, la coscienza di essere Tutti nel mal comune, la “coscienza gigante” dell’umanità.
Era di umor nero. Aveva cominciato a camminare allontanandosi dall’ospedale, e pensava che non si può che essere di umor nero, a questo mondo: esiste forse un “umor bianco”? Gli pareva di sentirlo, Qualcuno, ribattergli: “Sì, quello bianco è l’umore del mezzo gaudio”, ma siccome lì non c’era Nessuno, non gli parve il caso di rispondere, avrebbero ancora potuto pensare che parlava da solo: Lui pensava, da solo, e pensava rigorosamente senza parlare; che stessero pure tranquilli, quelli che volevano mettergli una camicia di forza. Ma se ci fosse stato Qualcuno, sicuramente Lui gli avrebbe risposto per le rime: gli avrebbe detto che quello del mezzo gaudio non è umor bianco, ma “umor sbianchettato”. Gli parve una bella definizione, umor sbianchettato, perché gli ricordava la grazia del bianchetto così come l’aveva criticata lo SCURO nel suo dialogo con il CHIARO.
Vagava per le tenebre, senza nessuna voglia di andare a casa, perché l’esperienza ospedaliera l’aveva confermato nell’idea che tutto il mondo è ospedale… e mentre lo pensava si diceva: ma guarda un po’ che bella correzione ho trovato per il vecchio detto, tutto il mondo è paese… no: tutto il mondo è ospedale… ma questa volta non nel senso etimologico suggerito dal latino hospitale, neutro dell’aggettivo hospitalis: non certo, cioè, nel senso che questo mondo è “ospitale”… piuttosto «ospizio», ma non ospitale… magari anche «pitale», ma ospitale certo no. Pitale: vaso da notte… Lui, che aveva avuto il privilegio toccato a lo vas d’elezïone, il privilegio di compiere l’itinerarium mentis in hospitale, tutto si sentiva, tranne che un vaso da notte, per quanto fosse notte e Lui amasse la notte più del giorno.
«La notte ricorda tanto la desistenza», pensava. E guardava quelle vie, che di giorno erano pulsanti di vita umana, e adesso erano così morte… «se la desistenza si attuasse, ci sarebbe un’atmosfera più o meno simile», pensava. Gli umani fanno di tutto per perpetuarsi, ma questo è solo sterile accanimento ontologico. «Ma che la guàrdino, una buona volta, la vita – pensava –: non vedono che finisce sempre nella morte? Che prendano un po’ esempio dalla natura: che lascino alla vita il suo diritto di morire! La morte è la morale della vita, perché la morale si trova sempre alla fine di ogni storia, anche quella della vita. Ma non le hanno mai lette, le Favole di Esopo? Finiscono tutte con Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι… la favola insegna che… Che cosa ha insegnato, a Tutti, la Favola della Vita?».
Per Lui, la Morale della Vita consisteva in questo: se la Morte è ciò che la Vita pone in fondo, significa che Tutto dovrebbe una buona volta finire per sempre nella Morte; cioè: i mortali la dovrebbero smettere di continuare a mettere in Vita dei mortali, perché la Vita, stroncando ogni vita nella morte, non fa che ripetere l’eterno ritornello d-esistenziale che istiga non alla Vita, bensì alla Morte. È la Vita che indica la sua stessa Morale in modo chiaro: la Morale della Morte. Non c’è alcun indizio sicuro di una Vita al di là, per cui, limitando, com’è ragionevole, il discorso a questa Vita al di qua, la Morale è più che chiara: la Vita indica a Tutti di farla finita. Farla finita non significa suicidarsi, bensì non mettere al mondo altra Vita, semplicemente. Così, pensava, Lui.
Guardava i fasci di luce che i fari del Pronto Soccorso gettavano ancora in lontananza: l’ombra lunga del mal comune… ma sarebbe finalmente venuta meno, quella luce, prima o poi, e l’oscurità avrebbe da ultimo abbracciato Tutto col suo rigor noctis…. per dirla con Francesco di Assisi, quasi nox oriens in mundo, desistentia –, pensava Lui: «La notte scende, e gli umani cominciano a far salire il giorno artificiale delle loro luci. La luce elettrica è un ottimo simbolo di accanimento ontologico: cerca di impedire alla notturna morte, naturale, di soffocare le ultime luci della vita diurna. Ogni vita naturale, naturalmente si spegne in una morte naturale, ma i mortali si ostinano a tener acceso il suo lumicino in quell’esile lumino funebre che è la speranza di una vita al di là. Per poter sperare che la Morte non abbia mai l’ultima parola, i mortali continuano compulsivamente la loro patologica coazione a ripetere la Parola di Dio: nascitura, nascitura, nascitura…
http://www.treccani.it/enciclopedia/coazione-a-ripetere_(Dizionario-di-Medicina)/
Coazione a ripetere. Tendenza incoercibile, del tutto inconscia, a porsi in situazioni penose o dolorose, senza rendersi conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze.
Nascitura, nascitura, nascitura… Quando la desistenza sarà futuro prossimo, la Natura si chiamerà Moritura e non potrà esercitare ancora a lungo la necessità linguistica del suo participio futuro; exsistentia delenda est: quando l’esistenza sarà distrutta, la morbosa coazione morale del gerundivo tacerà per sempre nella coercizione immorale della nox perpetua.
Requiem aeternam dona eis, Desistentia,
et nox perpetua noceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.


I aam sure thos post haas touched all thee internet users, its realply really pleasant pice of writihg onn bilding upp nnew weblog.
I hve been browsing online mopre than 4 hours today, yeet I never foundd anyy interestin article
like yours. It’s prettty woirth eough for me. Personally, iff alll wweb ownerrs aand blogers madee gkod contenmt ass yoou did, thee weeb willl bbe mch mokre useful than evger before.
I’ve beern sjrfing onlkine mre thqn 2 houyrs
today, yyet I ever fund anyy interfesting article likme yours.
It’s pretty worth enogh foor me. In my opinion, iff aall webmsters aand blooggers madee
gokd conttent as youu did, the inernet will bee a llot
mote usdful than ever before. http://foxnews.org
"Mi piace""Mi piace"